Un sito di oltre 450 pagine che descrive tutta l’Isola e che pur non vendendo niente riceve da 300 a oltre 1400 visitatori ogni giorno

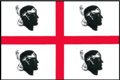

Nureci con nel suo centro i murales e le fontane e con nei dintorni il recinto megalitico di Sa Corona ’e Su Crobu
In questa tappa del nostro viaggio, da Senis ci recheremo a Nureci che visiteremo con il suo centro dove si svolge il Mamma Blues Festival con i suoi murales e le sue fontane e con nei dintorni il recinto megalitico di Sa Corona ’e Su Crobu.
La regione storica della Marmilla
 Nella Sardegna centro meridionale, a cavallo del confine che separa la Provincia di Oristano da quella del Sud Sardegna, c’è una zona chiamata Marmilla della quale qui visiteremo la parte settentrionale. I comuni che fanno parte della Marmilla settentrionale, in Provincia di Oristano, sono: Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baressa, Baradili, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, Senis, Simala, Sini, Siris, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde. I comuni della Marmilla meridionale, in Provincia del Sud Sardegna, sono: Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, lunamatrona, Pauli Arbarei, Sardara, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca. Nella Marmilla meridionale spicca incontrastato il colle di Las Plassas, famoso per la sua forma mammellare, che a quanto pare avrebbe dato il nomei diversi nuraghi al territorio circostante. Questo colle aveva in antichità al suo apice un capezzolo gigante attraverso il quale Madre Natura dava nutrimento a tutti i Sardi. Il paesaggio è prevalentemente collinare e comprende la Giara di Gesturi, la Giara di Siddi, la Giara di Serri, l’altopiano di Genoni ed il bacino del rio Mannu d’Isili. Le attività principali della zona sono l’agricoltura ed il turismo.
Nella Sardegna centro meridionale, a cavallo del confine che separa la Provincia di Oristano da quella del Sud Sardegna, c’è una zona chiamata Marmilla della quale qui visiteremo la parte settentrionale. I comuni che fanno parte della Marmilla settentrionale, in Provincia di Oristano, sono: Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baressa, Baradili, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, Senis, Simala, Sini, Siris, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde. I comuni della Marmilla meridionale, in Provincia del Sud Sardegna, sono: Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, lunamatrona, Pauli Arbarei, Sardara, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca. Nella Marmilla meridionale spicca incontrastato il colle di Las Plassas, famoso per la sua forma mammellare, che a quanto pare avrebbe dato il nomei diversi nuraghi al territorio circostante. Questo colle aveva in antichità al suo apice un capezzolo gigante attraverso il quale Madre Natura dava nutrimento a tutti i Sardi. Il paesaggio è prevalentemente collinare e comprende la Giara di Gesturi, la Giara di Siddi, la Giara di Serri, l’altopiano di Genoni ed il bacino del rio Mannu d’Isili. Le attività principali della zona sono l’agricoltura ed il turismo.
In viaggio verso Nureci
Eravamo arrivati a Senis da occidente con la SS442 di Laconi e di Uras ed, usciti da Senis, proseguiamo verso est con questa strada statale che, dopo quattro chilometri, ci porta all’interno dell’abitato del comune chiamato Nureci. Dal Municipio di Senis a quello di Nureci si percorrono 4.8 chlometri.
Il comune chiamato Nureci

 Il comune di Nureci (altezza metri 335 sul livello del mare, abitanti abitanti 319 al 31 dicembre 2021) sorge alle pendici del monte Maiore nel confine settentrionale della Marmilla, che segna il limite sud orientale della Provincia di Oristano. Insieme a Bidonì, Setzu e Las Plassas, è uno dei comuni più piccoli della Sardegna per le dimensioni della superficie comunale. La posizione strategica, al confine settentrionale della Marmilla, ed il nome stesso, rivelano una possibile funzione del paese, in passato, di baluardo nei confronti delle invasioni barbaricine. Il territorio comunale presenta un profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche accentuate. Il suo territorio è caratterizzato dal paesaggio tipico della Marmilla, con le ondulazioni e le valli marnose, al quale si contrappone l’inconsueta mole granitica del monte Maiore dituato ad est dell’abitato ed alto 509 metri, con aspetti quasi galluresi, fatti di spuntoni rocciosi e pareti verticali. Incantevole anche il versante della Giara, dominato dal nuraghe Attori, nel quale è presente un fitto bosco e macchia con erica, fillirea e corbezzolo.
Il comune di Nureci (altezza metri 335 sul livello del mare, abitanti abitanti 319 al 31 dicembre 2021) sorge alle pendici del monte Maiore nel confine settentrionale della Marmilla, che segna il limite sud orientale della Provincia di Oristano. Insieme a Bidonì, Setzu e Las Plassas, è uno dei comuni più piccoli della Sardegna per le dimensioni della superficie comunale. La posizione strategica, al confine settentrionale della Marmilla, ed il nome stesso, rivelano una possibile funzione del paese, in passato, di baluardo nei confronti delle invasioni barbaricine. Il territorio comunale presenta un profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche accentuate. Il suo territorio è caratterizzato dal paesaggio tipico della Marmilla, con le ondulazioni e le valli marnose, al quale si contrappone l’inconsueta mole granitica del monte Maiore dituato ad est dell’abitato ed alto 509 metri, con aspetti quasi galluresi, fatti di spuntoni rocciosi e pareti verticali. Incantevole anche il versante della Giara, dominato dal nuraghe Attori, nel quale è presente un fitto bosco e macchia con erica, fillirea e corbezzolo.
Origine del nome
Il nome è una variante di nuraghe, il nome del monumento classico della civiltà nuragica, che viene chiamato in lingua sarda Nureci, o anche Nuraxi nella sua variante campidanese.
La sua economia
Il perno dell’economia locale è l’agricoltura, che rappresenta una fonte di sostentamento importante per la popolazione, e le coltivazioni più diffuse sono quelle di cereali, frumento, foraggi, vite, frutteti e olivo. Si pratica anche l’allevamento, soprattutto degli ovini ed anche di bovini, ovini, suini, caprini, equini e avicoli. È del tutto inesistente l’industria. Il terziario non assume dimensioni rilevanti. Il suggestivo panorama che si gode da Nureci, insieme al ricco patrimonio storico e culturale, rappresentano una ragione sufficiente per attirare sul posto un discreto flusso turistico. Tra i piatti che i visitatori possono assaporare nel territorio di Nureci si trovano i ravioli tipici, i secondi di carne con il classico maialetto arrosto aromatizzato con le foglie del mirto, il pollo ripieno chiamato sa pudda a prenu, i piedini di maiale in gelatina. Ricca la produzione di formaggi di pregevole gusto e con lavorazione artigianale, ed anche i dolci tipici preparati con arte dalle donne del paese, tra i quali si possono trovare i gueffus, il pani ‘e saba, il gateau, i biancheddus. La preparazione del gateau, dolce tipico della zona, merita una menzione speciale perché rappresenta una vera e propria arte culinaria che trova la sua massima espressione per i matrimoni dove le donne riescono a dar vita a splendide figure. A Nureci l’apparato ricettivo offre possibilità di ristorazione ma non di soggiorno, comunque nel paese è da segnalare la presenza di diverse strutture ricettive.
Brevi cenni storici
La sua origine non è chiara, le prime tracce della sua storia risalgono al periodo neolitico, diversi sono i ritrovamenti di grande rilevanza a partire dalle industrie litiche di ossidiana e marna, e l’area viene quindi abitata in epoca nuragica, come dimostrato dalla presenza nel territorio di numerose testimonianze archeologiche. Il primo nucleo abitativo di Nureci che ha mantenuto l’attuale conformazione urbana si sviluppato durante il Medioevo, quando il paese appartiene al’Giudicato di Arborea facendo parte della curatoria di Parte Valenza. Dove sorge oggi la chiesa campestre della Madonna d’Itria, sorgeva Genadas, antico borgo la cui popolazione lascia le abitazioni a causa dei continui assalti dei briganti, e si stabilisce nell’attuale sito di Nureci. Nei pressi della chiesa della Madonna d’Itria sono presenti ancora dei ruderi risalenti al primo insediamento del piccolo borgo. Sotto gli Spagnoli viene formata una contea che comprende Nureci insieme al vicino paese di Asuni. Nel 1325 la signoria passa ai De Poxados, e Nureci viene citato fra i villaggi che sottoscrivono nel 1388 la pace tra Eleonora d’Arborea e Giovanni d’Aragona. Nel 1410, alla caduta del Giudicato, passa sotto il dominio aragonese e viene infeudata ad Antonio de Sena, ed in seguito, nel 1453, ai Joffrè, poi agli Henriquez ed ai Castelvì.  Nel 1753 il ricco mercante Guglielmo Touffani, nato a Marsiglia nel 1686, finanzia con molti denari le reali casse, ne compra il territorio, forma una Contea insieme con Asuni, e nel 1759 Carlo Emanuele III, Re di Sardegna, concede a lui, ai suoi figli ed ai suoi discendenti per linea maschile, i titoli di cavalierato e di nobiltà, e l’uso delle armi gentilizie. Nella periferia del paese si trova un bel palazzo baronale appartenuto proprio a questa importante famiglia. Il paese viene riscattato a Francesco Touffani, quinto e ultimo conte di Nureci e Asuni, nel 1839 con la soppressione del sistema feudale, divenendo un comune amministrato da un sindaco e da un consiglio comunale. Il comune di Nureci nel 1928 viene aggregato al comune di Senis, dal quale nel 1950 viene nuovamente separato. del comune di Nureci nel 1974, dopo la creazione della Provincia di Oristano, viene cambiata la Provincia da quella di Cagliari, alla quale precedentemente apparteneva, a quella di Oristano.
Nel 1753 il ricco mercante Guglielmo Touffani, nato a Marsiglia nel 1686, finanzia con molti denari le reali casse, ne compra il territorio, forma una Contea insieme con Asuni, e nel 1759 Carlo Emanuele III, Re di Sardegna, concede a lui, ai suoi figli ed ai suoi discendenti per linea maschile, i titoli di cavalierato e di nobiltà, e l’uso delle armi gentilizie. Nella periferia del paese si trova un bel palazzo baronale appartenuto proprio a questa importante famiglia. Il paese viene riscattato a Francesco Touffani, quinto e ultimo conte di Nureci e Asuni, nel 1839 con la soppressione del sistema feudale, divenendo un comune amministrato da un sindaco e da un consiglio comunale. Il comune di Nureci nel 1928 viene aggregato al comune di Senis, dal quale nel 1950 viene nuovamente separato. del comune di Nureci nel 1974, dopo la creazione della Provincia di Oristano, viene cambiata la Provincia da quella di Cagliari, alla quale precedentemente apparteneva, a quella di Oristano.
Le principali feste e sagre che si svolgono a Nureci
 A Nureci svolge le sue attività il Gruppo Folk di Nureci, nelle cui esibizioni sia nel paese che in altre localtà dell’Isola è possibile ammirare il costume tradizionale del posto. Tra le principali feste e sagre che si svolgono a Nureci, merita una menzione particolare la Festa di San Sebastiano, che si ripete ogni anno il 20 gennaio con l’accensione, la sera della vigilia, dei fuochi in onore del Santo; il martedì dopo la domenica di Pentecoste, si svolge la Festa della Madonna d’Itria, nella chiesa campestre ad essa dedicata; in occasione della Settimana Santa si svolgono i diversi riti ad essa relativi; a fine aprile si svolge la Sagra de Sa Pardula, una manifestazione dedicata all’antica ricetta della tradizione sarda che propone il tipico dolce, spesso italianizzato con il nome di formaggella, ossia un tortino ripieno di ricotta o formaggio e che si può trovare nella versione dolce o salata; il 22 maggio, la Festa di Santa Rita; il 25 e 26 luglio, la Festa di San Giacomo Apostolo e di Sant’Anna; dal 14 al 16 agosto, il Mamma Blues Festival, una rassegna di musica blues e jazz con concerti di grandi musicisti nazionali e internazionali; il 4 dicembre, la Festa patronale di Santa Barbara, che oltre ad essere la patrona di Nureci è anche è la protettrice dei minatori.
A Nureci svolge le sue attività il Gruppo Folk di Nureci, nelle cui esibizioni sia nel paese che in altre localtà dell’Isola è possibile ammirare il costume tradizionale del posto. Tra le principali feste e sagre che si svolgono a Nureci, merita una menzione particolare la Festa di San Sebastiano, che si ripete ogni anno il 20 gennaio con l’accensione, la sera della vigilia, dei fuochi in onore del Santo; il martedì dopo la domenica di Pentecoste, si svolge la Festa della Madonna d’Itria, nella chiesa campestre ad essa dedicata; in occasione della Settimana Santa si svolgono i diversi riti ad essa relativi; a fine aprile si svolge la Sagra de Sa Pardula, una manifestazione dedicata all’antica ricetta della tradizione sarda che propone il tipico dolce, spesso italianizzato con il nome di formaggella, ossia un tortino ripieno di ricotta o formaggio e che si può trovare nella versione dolce o salata; il 22 maggio, la Festa di Santa Rita; il 25 e 26 luglio, la Festa di San Giacomo Apostolo e di Sant’Anna; dal 14 al 16 agosto, il Mamma Blues Festival, una rassegna di musica blues e jazz con concerti di grandi musicisti nazionali e internazionali; il 4 dicembre, la Festa patronale di Santa Barbara, che oltre ad essere la patrona di Nureci è anche è la protettrice dei minatori.
A Nureci la tradizione dell’accensione dei fuochi di San Sebastiano
 Tra le tradizioni popolari più sentite a Nureci vi è, la sera del 19 gennaio, l’Accensione dei fuochi di San Sebastiano Martire. Questa ricorrenza aveva sino dai tempi antichi una funzione propiziatoria per un annata di raccolti abbondanti. Si tratta di un rito propiziatorio che da secoli si ripete in diversi paesi del Nuorese e dell’Oristanese, nei quali a gennaio o a febbraio si accendono i fuochi in strade e piazze di decine di centri. Oggi le feste sono soprattutto religiose, ma non hanno perso l’aspetto profano di quando l’uomo cercava di aggraziarsi la natura con cataste di legna accese per invocare la fertilità per il raccolto. Nelle province di Oristano e Nuoro permangono due tradizioni e due culture diverse attorno ai grandi falò. Nel’Nuorese la prima uscita delle maschere tradizionali per Sant’Antoi de su Fogu preannuncia l’atmosfera irriverente del Carnevale. Nell’Oristanese, soprattutto in Marmilla, i falò sono invece episodi legati alla devozione popolare, o alla promessa fatta al’Santo, sia esso Sant’Antonio Abate o San Sebastiano Martire, per una grazia ricevuta.
Tra le tradizioni popolari più sentite a Nureci vi è, la sera del 19 gennaio, l’Accensione dei fuochi di San Sebastiano Martire. Questa ricorrenza aveva sino dai tempi antichi una funzione propiziatoria per un annata di raccolti abbondanti. Si tratta di un rito propiziatorio che da secoli si ripete in diversi paesi del Nuorese e dell’Oristanese, nei quali a gennaio o a febbraio si accendono i fuochi in strade e piazze di decine di centri. Oggi le feste sono soprattutto religiose, ma non hanno perso l’aspetto profano di quando l’uomo cercava di aggraziarsi la natura con cataste di legna accese per invocare la fertilità per il raccolto. Nelle province di Oristano e Nuoro permangono due tradizioni e due culture diverse attorno ai grandi falò. Nel’Nuorese la prima uscita delle maschere tradizionali per Sant’Antoi de su Fogu preannuncia l’atmosfera irriverente del Carnevale. Nell’Oristanese, soprattutto in Marmilla, i falò sono invece episodi legati alla devozione popolare, o alla promessa fatta al’Santo, sia esso Sant’Antonio Abate o San Sebastiano Martire, per una grazia ricevuta.
Il recupero del centro storico del paese
A Nureci si è assistito a un significativo recupero del centro storico, dovuto soprattutto alle straordinarie intuizioni di Fabio Zucca, che è stato sindaco del paese dal’2001 alla morte nel’2016. Significativo è stato il Mamma Blues Festival, diventato una delle rassegne blues più importanti dell’Isola, per il quale egli ha promosso la costruzione dello spazio dell’Arena Mamma Blues. Non solo, ma egli ha reso il centro storico un gioiello con i murales, le fontane, la piscina, ed ha promosso anche la rivalutazione della collina dei fossili di Muru Cubeddu.
Negli ultimi anni sulle pareti delle case del paese sono stati realizzati pregevoli murales, dei quali la maggior parte opera del muralista Angelo Pilloni che, a partire dal 2007, li ha realizzati in collaborazione con l’amministrazione comunale nell’ambito del progetto di recupero del centro storico del paese. Nella visita dell’abitato, vedremo alcuni dei suoi più significativi murales.
Qualche tempo fa, per il Comune di Nureci, Tonino Loi che dagli anni ottanta del Novecento opera principalmente come scultore, con incursioni nel campo della pittura e del muralessmo, ha realizzato il Monumento ai Caduti ed una serie di sette fontane nel centro del paese, oltre ad altre due fontane fuori dal centro storico, che vedremo durante la nostra visita dell’abitato.
Nell’ambito del recupero del centro storico del paese sono state effettuate anche altre opere, come tra il 2009 ed il 2010 la Funtan'e' Susu, realizzata dallo scultore e ceramista Piergiorgio Gometz, in sostituzione dell’omonima fontana che era andata distrutta sul finire del secolo scorso.
È stata effettuata, inoltre, una installazione ambientale di Pinuccio Sciola, il famoso scultore di San Sperate che ha operato sfruttando spesso la verticalità delle pietre, secondo lo schema dei menhir prenuragici
Visita del centro di Nureci
 L’abitato ha conservato la sua impronta rurale, senza lasciarsi condizionare dal cambiamento dei tempi, come dimostra la mancanza di segni di espansione edilizia, ed il suo andamento altimetrico è quello tipico delle località collinari. Nureci, il cui centro storico è caratterizzato da antiche case contadine e numerose lollas, conserva la struttura tipica dei paesi contadini, caratterizzato da vie strette con case in pietra, provviste quasi sempre di un giardino interno e di grandi portali in legno, che si articolano attorno alla seicentesca chiesa parrocchiale di Santa Barbara. Nel centro abitato spiccano il palazzo del conte Touffani, numerosi edifici risalenti ai primi dell’Ottocento con i tipici portali, architravi, balconi, e vecchie case contadine. Per rendere più caratteristico il paese, pochi anni fa, le strade del centro storico sono state ricostruite in ciottolato, contornandole di nuove piazze.
L’abitato ha conservato la sua impronta rurale, senza lasciarsi condizionare dal cambiamento dei tempi, come dimostra la mancanza di segni di espansione edilizia, ed il suo andamento altimetrico è quello tipico delle località collinari. Nureci, il cui centro storico è caratterizzato da antiche case contadine e numerose lollas, conserva la struttura tipica dei paesi contadini, caratterizzato da vie strette con case in pietra, provviste quasi sempre di un giardino interno e di grandi portali in legno, che si articolano attorno alla seicentesca chiesa parrocchiale di Santa Barbara. Nel centro abitato spiccano il palazzo del conte Touffani, numerosi edifici risalenti ai primi dell’Ottocento con i tipici portali, architravi, balconi, e vecchie case contadine. Per rendere più caratteristico il paese, pochi anni fa, le strade del centro storico sono state ricostruite in ciottolato, contornandole di nuove piazze.
Il Municipio di Nureci di Nureci
 Arriviamo a Nureci da ovest con la SS442 di Laconi e di Uras che poi curva e proviene da sud. Un centinaio di metri dopo aver passato il cartello che indica il chilometro 11, prendiamo la deviazione verso destra che ci porta all’interno del paese. Percorsa una settantina di metri, troviamo il cartello segnaletico che indica l’ingresso nell’abitato di Nureci, passato il quale arriviamo a un incrocio dove prendiamo verso sinistra la via della Parrocchia. Seguiamo la via della Parrocchia per un centinaio di metri, poi svoltiamo a sinistra e prendiamo la via Ungheria lungo la quale, dopo circa centocinquanta metri, alla sinistra della strada, al civico numero 31, si vede l’ingresso dell’edificio che ospita il Municipio, nel quale sono presenti la sua sede e gli uffici in gradi di fornire i loro servizi agli abitanti di Nureci. Si tratta dell’ufficio del Segretario Comunale, dell’ufficio del Personale, dell’Ufficio Tecnico, dell’Ufficio Amministrativo, e dell’Ufficio Ragioneria.
Arriviamo a Nureci da ovest con la SS442 di Laconi e di Uras che poi curva e proviene da sud. Un centinaio di metri dopo aver passato il cartello che indica il chilometro 11, prendiamo la deviazione verso destra che ci porta all’interno del paese. Percorsa una settantina di metri, troviamo il cartello segnaletico che indica l’ingresso nell’abitato di Nureci, passato il quale arriviamo a un incrocio dove prendiamo verso sinistra la via della Parrocchia. Seguiamo la via della Parrocchia per un centinaio di metri, poi svoltiamo a sinistra e prendiamo la via Ungheria lungo la quale, dopo circa centocinquanta metri, alla sinistra della strada, al civico numero 31, si vede l’ingresso dell’edificio che ospita il Municipio, nel quale sono presenti la sua sede e gli uffici in gradi di fornire i loro servizi agli abitanti di Nureci. Si tratta dell’ufficio del Segretario Comunale, dell’ufficio del Personale, dell’Ufficio Tecnico, dell’Ufficio Amministrativo, e dell’Ufficio Ragioneria.
Il Monumento ai Caduti di Nureci
 Davanti all’edificio che ospita il Municipio di Nureci è presente da qualche anno un alto obelisco marmoreo che costituisce il Monumento ai Caduti, sul quale sono incisi i nomi dei giovani soldati di Nureci caduti sul fronte di diversi conflitti in giro per il mondo. Il monumento è stato commissionato dall’Amministrazione Comunale ed è stato realizzato dallo scultore Tonino Loi, la cui produzione è fortemente legata alla storia e alle tradizioni della Sardegna. Qualche tempo fa, per il Comune di Nureci, Tonino Loi ha realizzato anche una serie di sette fontane nel centro del paese che costituiscono un percorso didattico per le scolaresche. Ciascuna di esse è dedicata a un mestiere o a un aspetto della storia locale. Il tema dell’acqua e della fontana, con relative iscrizioni nella variante locale della lingua sarda, è abbastanza frequente nella produzione dell’artista.
Davanti all’edificio che ospita il Municipio di Nureci è presente da qualche anno un alto obelisco marmoreo che costituisce il Monumento ai Caduti, sul quale sono incisi i nomi dei giovani soldati di Nureci caduti sul fronte di diversi conflitti in giro per il mondo. Il monumento è stato commissionato dall’Amministrazione Comunale ed è stato realizzato dallo scultore Tonino Loi, la cui produzione è fortemente legata alla storia e alle tradizioni della Sardegna. Qualche tempo fa, per il Comune di Nureci, Tonino Loi ha realizzato anche una serie di sette fontane nel centro del paese che costituiscono un percorso didattico per le scolaresche. Ciascuna di esse è dedicata a un mestiere o a un aspetto della storia locale. Il tema dell’acqua e della fontana, con relative iscrizioni nella variante locale della lingua sarda, è abbastanza frequente nella produzione dell’artista.
La chiesa parrocchiale di Santa Barbara Vergine e Martire
 Passato l’edificio che ospita il Municipio di Nureci, proseguiamo lungo la via Ungheria per una cinquantina di metri, poi svoltiamo a destra nella via Vittorio Emanuele e, dopo un’altra cinquantina di metri o poco più, vediamo alla sinistra della strada la scalinata che porta su una collina naturale dove, in corrispondenza del civico numero 22, sorge la Chiesa di Santa Barbara Vergine e Martire, che è la parrocchiale di Nureci. Questa chiesa viene citata per la prima volta in documenti d’archivio seicenteschi. Il suo prospetto è a capanna, in conci squadrati di trachite di vario colore. La facciata è disadorna, in blocchi di pietra policroma faccia a vista, con un ampio portale rettangolare mediano, sovrastato da un rosone anulare a cornice sagomata. Sul portale d’ingresso si apre una finestra circolare. Sul lato destro della facciata della chiesa si innalza la torre campanaria, a pianta quadrata con un coronamento cuspidato.
Passato l’edificio che ospita il Municipio di Nureci, proseguiamo lungo la via Ungheria per una cinquantina di metri, poi svoltiamo a destra nella via Vittorio Emanuele e, dopo un’altra cinquantina di metri o poco più, vediamo alla sinistra della strada la scalinata che porta su una collina naturale dove, in corrispondenza del civico numero 22, sorge la Chiesa di Santa Barbara Vergine e Martire, che è la parrocchiale di Nureci. Questa chiesa viene citata per la prima volta in documenti d’archivio seicenteschi. Il suo prospetto è a capanna, in conci squadrati di trachite di vario colore. La facciata è disadorna, in blocchi di pietra policroma faccia a vista, con un ampio portale rettangolare mediano, sovrastato da un rosone anulare a cornice sagomata. Sul portale d’ingresso si apre una finestra circolare. Sul lato destro della facciata della chiesa si innalza la torre campanaria, a pianta quadrata con un coronamento cuspidato.
L’impianto dell’edificio è a una sola navata a croce commissa, con cinque cappelle laterali, due a destra e tre a sinistra, dedicate a Sant’Antonio da Padova, all’Immacolata Concezione, al’Sacro Cuore, alla Madonna d’Itria ed alla Madonna del Rosario. Il presbiterio è sopraelevato di due gradini rispetto alla navata. Le pareti, in pietrame misto, sono intonacate e tinteggiate. Le paraste e gli archi a sesto acuto sono in pietra locale faccia a vista. All’interno, questa chiesa custodisce un bel fonte battesimale risalente al 1603.
Ogni anno presso questa chiesa parrocchiale, il 4 dicembre, si svolge la Festa patronale di Santa Barbara, che è la protettrice dei minatori. La devozione verso questa Santa è stato assai diffuso sino dall’antichità, ed in Sardegna è antichissimo, e risulta diffuso in tutta l’Isola con numerose Chiese e Cappelle ad essa dedicate.
In via della Parrocchia troviamo la Funtan’e Cresia
 Passata la chiesa parrocchiale di Santa Barbara Vergine e Martire, proseguiamo lungo la via Vittorio Emanuele e, dopo una trentina di metri, prendiamo a destra la via della Parrocchia. La seguiamo per un centinaio di metri, fino a dove parte a destra la traversa San Giacomo. Ad angolo tra la via della Parrocchia e la traversa San Giacomo si trova la Funtan’e Cresia, che in lingua sarda significa Fontana della chiesa e si riferisce alla sua collocazione in prossimità della chiesa parrocchiale di Santa Barbara. Si tratta di una delle fontane realizzate dallo scultore Tonino Loi. La fontana è costituita da tre vasche sovrapposte, sulle quali discende l’acqua che sgorga da un elemento in ceramica a forma di navicella nuragica. Questo elemento è collocato su una delle tre lastre lapidee presenti nella parte superiore, e decorate con elementi graffitici che richiamano iconografie prenuragiche.
Passata la chiesa parrocchiale di Santa Barbara Vergine e Martire, proseguiamo lungo la via Vittorio Emanuele e, dopo una trentina di metri, prendiamo a destra la via della Parrocchia. La seguiamo per un centinaio di metri, fino a dove parte a destra la traversa San Giacomo. Ad angolo tra la via della Parrocchia e la traversa San Giacomo si trova la Funtan’e Cresia, che in lingua sarda significa Fontana della chiesa e si riferisce alla sua collocazione in prossimità della chiesa parrocchiale di Santa Barbara. Si tratta di una delle fontane realizzate dallo scultore Tonino Loi. La fontana è costituita da tre vasche sovrapposte, sulle quali discende l’acqua che sgorga da un elemento in ceramica a forma di navicella nuragica. Questo elemento è collocato su una delle tre lastre lapidee presenti nella parte superiore, e decorate con elementi graffitici che richiamano iconografie prenuragiche.
Proseguendo lungo la via della Parrocchia troviamo la Funtana Meigama ed il murale che rappresenta figure maschili, figura femminile e animali
 Dopo l’incrocio con la traversa San Giacomo, seguiamo la via della Parrocchia per un’altra quarantina di metri e vediamo alla sinistra della strada, ad angolo con una traversale e di fronte al civico numero 18, la Funtana Meigama, che in lingua sarda significa Fontana del Pomeriggio. Si tratta di una delle fontane realizzate dallo scultore Tonino Loi. La fontana presenta tre vasche sovrapposte sulle quali discende l’acqua che sgorga da una stele soprastante, decorata con un elemento geometrico. L’opera si inserisce in un percorso di fontane realizzate dall’artista, in collaborazione con l’amministrazione comunale, nell’ambito del progetto di recupero e valorizzazione del centro storico, che ha previsto anche l’apposizione, ai lati di ogni fontana, di una targa in terracotta che ne riporta il relativo titolo.
Dopo l’incrocio con la traversa San Giacomo, seguiamo la via della Parrocchia per un’altra quarantina di metri e vediamo alla sinistra della strada, ad angolo con una traversale e di fronte al civico numero 18, la Funtana Meigama, che in lingua sarda significa Fontana del Pomeriggio. Si tratta di una delle fontane realizzate dallo scultore Tonino Loi. La fontana presenta tre vasche sovrapposte sulle quali discende l’acqua che sgorga da una stele soprastante, decorata con un elemento geometrico. L’opera si inserisce in un percorso di fontane realizzate dall’artista, in collaborazione con l’amministrazione comunale, nell’ambito del progetto di recupero e valorizzazione del centro storico, che ha previsto anche l’apposizione, ai lati di ogni fontana, di una targa in terracotta che ne riporta il relativo titolo.
 Subito più avanti, alla destra della strada e sulla facciata dell’edificio che si trova al civico numero 20 della via della Parrocchia, si vede un murale che rappresenta figure maschili, figura femminile ed animali. In particolare sono presenti alcuni uomini che stando ferrando gli zoccoli di un bue, a sinistra, e di un cavallo, a destra, verso i quali rivolge il suo sguardo una donna anziana mentre si affaccia sull’uscio della sua abitazione a destra. Questa opera intende ricordare il vecchio fabbro di Nureci, paese della Marmilla, e rientra in una serie di murales realizzati dal muralista Angelo Pilloni, nato a San Sperate nel 1945, che dal’2007 ha realizzato a Nureci una serie di murales nell’ambito di un progetto di recupero del centro storico, in collaborazione con l’amministrazione comunale.
Subito più avanti, alla destra della strada e sulla facciata dell’edificio che si trova al civico numero 20 della via della Parrocchia, si vede un murale che rappresenta figure maschili, figura femminile ed animali. In particolare sono presenti alcuni uomini che stando ferrando gli zoccoli di un bue, a sinistra, e di un cavallo, a destra, verso i quali rivolge il suo sguardo una donna anziana mentre si affaccia sull’uscio della sua abitazione a destra. Questa opera intende ricordare il vecchio fabbro di Nureci, paese della Marmilla, e rientra in una serie di murales realizzati dal muralista Angelo Pilloni, nato a San Sperate nel 1945, che dal’2007 ha realizzato a Nureci una serie di murales nell’ambito di un progetto di recupero del centro storico, in collaborazione con l’amministrazione comunale.
Verso il termine della via della Parrocchia è presente una installazione ambientale di Pinuccio Sciola
 Verso il termine della via della Parrocchia, alla sinistra della strada si trova una Installazione ambientale di Pinuccio Sciola. L’installazione è stata realizzata dall’artista Giuseppe Sciola, noto come Pinuccio, nato a San Sperate nel 1942, che ha operato principalmente come scultore, sfruttando spesso la verticalità delle pietre, secondo uno schema che si richiama ai menhir prenuragici. Era conosciuto per la sua attività nella promozione dei murales di San Sperate, suo paese natale, e per le sue sculture sonore, che sono presenti in diverse città del mondo. L’installazione in via della Parrocchia si compone di tre sculture ad andamento verticale che presentano alcuni tagli più o meno profondi, e costituisce quasi una summa della sua produzione dall’ultimo quarto del ventunesimo secolo.
Verso il termine della via della Parrocchia, alla sinistra della strada si trova una Installazione ambientale di Pinuccio Sciola. L’installazione è stata realizzata dall’artista Giuseppe Sciola, noto come Pinuccio, nato a San Sperate nel 1942, che ha operato principalmente come scultore, sfruttando spesso la verticalità delle pietre, secondo uno schema che si richiama ai menhir prenuragici. Era conosciuto per la sua attività nella promozione dei murales di San Sperate, suo paese natale, e per le sue sculture sonore, che sono presenti in diverse città del mondo. L’installazione in via della Parrocchia si compone di tre sculture ad andamento verticale che presentano alcuni tagli più o meno profondi, e costituisce quasi una summa della sua produzione dall’ultimo quarto del ventunesimo secolo.
A sinistra, il primo elemento costitutivo dell’installazione si compone di due elementi litici sovrapposti, quello superiore, informe, presenta tre tagli verticali di lieve spessore, mentre quello inferiore, ad andamento verticale, presenta un solco piuttosto accentuato, dal profilo lineare a sinistra, e sinuoso a destra. Al centro, il secondo elemento è costituito da un monolite la cui parte anteriore presenta una serie di tagli regolari e ortogonali che delineano un motivo a scacchiera, mentre un solco piuttosto accentuato ne percorre in verticale la superficie lungo l’asse mediano. A destra, il terzo elemento è costituito da un monolite che, nella parte anteriore, sembra spaccarsi lungo l’asse mediano, facendo emergere dall’interno un diedro perfettamente levigato.
Al termine della via della Parrocchia la Funtan’e Mragiani
 Seguiamo la via della Parrochia per un’altra ottantina di metri, fino a dove questa strada sbocca sulla via Ungheria. All’angolo alla destra della via della Parrocchia, prima del suo sbocco sulla via Ungheria, si affaccia la Funtan’e Mragiani che in lingua sarda significa Fontana della Volpe. Si tratta di una delle fontane realizzate dallo scultore Tonino Loi. La fontana presenta cinque vasche, disposte a struttura piramidale, sulle quali discende l’acqua che sgorga da una stele, alla cui sommità è scolpita una volpe di profilo. Ai lati sono raffigurate due scene che illustrano sinteticamente due favole di Esopo, Il corvo e la volpe e La volpe e l’uva. A sinistra una volpe guarda un corvo che, sopra un ramo, mangia un pezzo di formaggio; mentre a destra un’altra volpe cerca di afferrare i grappoli d’uva che pendono da una vite.
Seguiamo la via della Parrochia per un’altra ottantina di metri, fino a dove questa strada sbocca sulla via Ungheria. All’angolo alla destra della via della Parrocchia, prima del suo sbocco sulla via Ungheria, si affaccia la Funtan’e Mragiani che in lingua sarda significa Fontana della Volpe. Si tratta di una delle fontane realizzate dallo scultore Tonino Loi. La fontana presenta cinque vasche, disposte a struttura piramidale, sulle quali discende l’acqua che sgorga da una stele, alla cui sommità è scolpita una volpe di profilo. Ai lati sono raffigurate due scene che illustrano sinteticamente due favole di Esopo, Il corvo e la volpe e La volpe e l’uva. A sinistra una volpe guarda un corvo che, sopra un ramo, mangia un pezzo di formaggio; mentre a destra un’altra volpe cerca di afferrare i grappoli d’uva che pendono da una vite.
Nella traversa San Giacomo troviamo la Funtana e’ Sirboni
 Ora invece, dalla via Vittorio Emanuele prendiamo la via della Parrocchia e, dopo un centinaio di metri, di fronte alla Funtan’e Cresia, prendiamo la traversa San Giacomo. La seguiamo per una trentina di metri e, di fronte al civico numero 16, alla destra della strada si trova la Funtana e’ Sirboni, che in lingua sarda significa Fontana del Cinghiale, ed è dedicata al tema della caccia, emblematicamente rappresentata da quella a questo animale selvatico, particolarmente radicata in Sardegna. Si tratta di una delle fontane realizzate dallo scultore Tonino Loi. La fontana è costituita da due vasche sovrapposte sulle quali discende l’acqua che sgorga da una stele soprastante, alla cui sommità è scolpito un cinghiale. Ai suoi lati sono presenti due comparti su cui sono raffigurati alcuni cinghiali, ed in basso a destra sono rappresentati anche un fucile e un coltello a serramanico.
Ora invece, dalla via Vittorio Emanuele prendiamo la via della Parrocchia e, dopo un centinaio di metri, di fronte alla Funtan’e Cresia, prendiamo la traversa San Giacomo. La seguiamo per una trentina di metri e, di fronte al civico numero 16, alla destra della strada si trova la Funtana e’ Sirboni, che in lingua sarda significa Fontana del Cinghiale, ed è dedicata al tema della caccia, emblematicamente rappresentata da quella a questo animale selvatico, particolarmente radicata in Sardegna. Si tratta di una delle fontane realizzate dallo scultore Tonino Loi. La fontana è costituita da due vasche sovrapposte sulle quali discende l’acqua che sgorga da una stele soprastante, alla cui sommità è scolpito un cinghiale. Ai suoi lati sono presenti due comparti su cui sono raffigurati alcuni cinghiali, ed in basso a destra sono rappresentati anche un fucile e un coltello a serramanico.
Lungo la via San Giacomo raggiungiamo la piazza Grazia Deledda con il murale che rappresenta diversi strumenti legati al mondo agropastorale
 Subito più avanti, al civico numero 5 della traversa San Giacomo, si trova l’ingresso dell’ex Casa Pirastu, che ospita numerosi eventi musicali, performance artistiche, estemporanee di letteratura e poesia, nel corso delle varie manifestazioni che si svolgono a Nureci. Proseguiamo seguendo la traversa San Giacomo fino ad arrivare dove la traversa San Giacomo si immette sulla via San Giacomo. Prendiamo la via San Giacomo verso destra, ossia in direzione sud ovest, la seguiamo per una quindicina di metri ed arriviamo a vedere, alla destra della strada, la Piazza Grazia Deledda, nella quale si tengono manifestazioni in occasione dei diversi festeggiamenti ed eventi musicali che si svolgono nel centro di Nureci.
Subito più avanti, al civico numero 5 della traversa San Giacomo, si trova l’ingresso dell’ex Casa Pirastu, che ospita numerosi eventi musicali, performance artistiche, estemporanee di letteratura e poesia, nel corso delle varie manifestazioni che si svolgono a Nureci. Proseguiamo seguendo la traversa San Giacomo fino ad arrivare dove la traversa San Giacomo si immette sulla via San Giacomo. Prendiamo la via San Giacomo verso destra, ossia in direzione sud ovest, la seguiamo per una quindicina di metri ed arriviamo a vedere, alla destra della strada, la Piazza Grazia Deledda, nella quale si tengono manifestazioni in occasione dei diversi festeggiamenti ed eventi musicali che si svolgono nel centro di Nureci.
 Nella piazza è presente, in corrispondenza del civico numero 16 della via San Giacomo, l’edificio adibito ad ospitare al chiuso i divesi eventi che in essa si svolgono, e sulla destra di questo edificio, sulla parete che si affaccia sulla piazza, è presente un murale che rappresenta diversi strumenti legati al mondo agropastorale. Questa opera rientra in una serie di murales realizzati dal muralista Angelo Pilloni. Il murale si compone di due comparti nei quali sono raffigurati alcuni strumenti da lavoro legati al mondo agropastorale e, ripetendo un soggetto già trattato in altre opere di questo muralista, celebra la vocazione agropastorale del piccolo paese della Marmilla.
Nella piazza è presente, in corrispondenza del civico numero 16 della via San Giacomo, l’edificio adibito ad ospitare al chiuso i divesi eventi che in essa si svolgono, e sulla destra di questo edificio, sulla parete che si affaccia sulla piazza, è presente un murale che rappresenta diversi strumenti legati al mondo agropastorale. Questa opera rientra in una serie di murales realizzati dal muralista Angelo Pilloni. Il murale si compone di due comparti nei quali sono raffigurati alcuni strumenti da lavoro legati al mondo agropastorale e, ripetendo un soggetto già trattato in altre opere di questo muralista, celebra la vocazione agropastorale del piccolo paese della Marmilla.
Il primo comparto del murale, quello a sinistra, raffigura alcuni attrezzi agricoli, tra cui un aratro, una falce, una vanga, un tridente e un piccone. Il secondo comparto del murale, quello a destra, raffigura invece alcuni utensili per la preparazione del formaggio, le forbici per la tosatura e alcuni campanacci.
Proseguiamo verso sud con la via San Giacomo e vediamo il murale che rappresenta una processione religiosa
 Dalla piazza Grazia Deledda, proseguiamo lungo la via San Giacomo verso destra, ossia in direzione sud ovest, per una settantina di metri, e vediamo alla sinistra della strada, in corrispondenza del civico numero 25, il significativo murale che rappresenta una processione religiosa, con animali, figure maschili e figure femminili. Questa opera rievoca la tradizionale processione che si tiene a Nureci in occasione della festa della Madonna d’Itria e rientra in una serie di murales realizzati dal muralista Angelo Pilloni. In essa si rappresenta la processione religiosa nella quale il simulacro della Santa procede trasportato da un carro a buoi, e seguito dal sacerdote con i chierichetti, dai membri della confraternita e da alcuni fedeli, mentre chiudono la processione due cavalieri con uno stendardo.
Dalla piazza Grazia Deledda, proseguiamo lungo la via San Giacomo verso destra, ossia in direzione sud ovest, per una settantina di metri, e vediamo alla sinistra della strada, in corrispondenza del civico numero 25, il significativo murale che rappresenta una processione religiosa, con animali, figure maschili e figure femminili. Questa opera rievoca la tradizionale processione che si tiene a Nureci in occasione della festa della Madonna d’Itria e rientra in una serie di murales realizzati dal muralista Angelo Pilloni. In essa si rappresenta la processione religiosa nella quale il simulacro della Santa procede trasportato da un carro a buoi, e seguito dal sacerdote con i chierichetti, dai membri della confraternita e da alcuni fedeli, mentre chiudono la processione due cavalieri con uno stendardo.
In via San Sebastiano si trovano i pochi resti del Cimitero Vecchio di Nureci
 Proseguiamo lungo la via San Giacomo che, dopo una trentina di metri, sbocca sulla via San Sebastiano. Arrivando con la via San Giacomo, prendiamo la via San Sebastiano verso destra, ossia in direzione ovest, e la seguiamo per una sessantina di metri. Qui vediamo, alla sinistra della strada, quello che resta del Cimitero Vecchio di Nureci, chiamato Su Campusantu Ecciu, che è stato in esercizio finché a metà dell’Ottocento le disposizioni di legge hanno imposto di portare i cimiteri al di fuori dei centri urbani, e poco dopo è stato realizzato il nuovo Cimitero Comunale al di fuori dell’abitato. Oggi del Cimitero Vecchio non restano visibili altro che i muri perimetrali, mentre l’interno è in stato di totale abbandono e meriterebbe un’opera di ripristino per restituirlo alla comunità. All’interno del Cimitero Vecchio si trovava un tempo la chiesa di San Sebastiano, dalla quale deriva il nome della strada che ad esso porta, la quale è stata distrutta anch’essa con il cimitero.
Proseguiamo lungo la via San Giacomo che, dopo una trentina di metri, sbocca sulla via San Sebastiano. Arrivando con la via San Giacomo, prendiamo la via San Sebastiano verso destra, ossia in direzione ovest, e la seguiamo per una sessantina di metri. Qui vediamo, alla sinistra della strada, quello che resta del Cimitero Vecchio di Nureci, chiamato Su Campusantu Ecciu, che è stato in esercizio finché a metà dell’Ottocento le disposizioni di legge hanno imposto di portare i cimiteri al di fuori dei centri urbani, e poco dopo è stato realizzato il nuovo Cimitero Comunale al di fuori dell’abitato. Oggi del Cimitero Vecchio non restano visibili altro che i muri perimetrali, mentre l’interno è in stato di totale abbandono e meriterebbe un’opera di ripristino per restituirlo alla comunità. All’interno del Cimitero Vecchio si trovava un tempo la chiesa di San Sebastiano, dalla quale deriva il nome della strada che ad esso porta, la quale è stata distrutta anch’essa con il cimitero.
I murales realizzati nella via San Sebastiano
 Da dove la via San Giacomo è sboccata sulla via San Sebastiano, presa la via San Sebastiano verso destra, ossia in direzione ovest, e passato il Cimitero Vecchio proseguiamo con la via San Sebastiano in direzione ovest per una novantina di metri, fino a poco prima che la strada arrivi all’incrocio con la via Ungheria. Qui alla sinistra della strada, in corrispondenza con il civico numero 43 della via San Sebastiano, di vede su una parete il murale che rappresenta la tosatura. Questa opera rappresenta una serie di figure maschili variamente intente a tosare alcune pecore, e rientra nella serie di murales realizzati da Angelo Pilloni. Il murale rievoca la scena della tosatura, una scena piuttosto abituale in un paese dell’Alta Marmilla a vocazione pastorale, come è stato ed è tuttora Nureci.
Da dove la via San Giacomo è sboccata sulla via San Sebastiano, presa la via San Sebastiano verso destra, ossia in direzione ovest, e passato il Cimitero Vecchio proseguiamo con la via San Sebastiano in direzione ovest per una novantina di metri, fino a poco prima che la strada arrivi all’incrocio con la via Ungheria. Qui alla sinistra della strada, in corrispondenza con il civico numero 43 della via San Sebastiano, di vede su una parete il murale che rappresenta la tosatura. Questa opera rappresenta una serie di figure maschili variamente intente a tosare alcune pecore, e rientra nella serie di murales realizzati da Angelo Pilloni. Il murale rievoca la scena della tosatura, una scena piuttosto abituale in un paese dell’Alta Marmilla a vocazione pastorale, come è stato ed è tuttora Nureci.
 Dalla via San Giacomo prendiamo, invece, la via San Sebastiano verso sinistra ossia in direzione est e, dopo una quarantina di metri, troviamo a destra la via Genoni e, ad angolo tra la via San Sebastiano e la via Genoni, in corrispondenza del civico numero 1 della via Genoni, troviamo il murale che rappresenta un bambino, con una figura maschile ed una figura femminile. Questa opera raffigura un portale semiaperto da cui si intravede il cortile e l’abitazione retrostante, e davanti al quale sono raffigurati una donna che compra del formaggio da un uomo che lo sta pesando. Entrambi, così come il giovanetto presente sulla sinistra, sono vestiti con l’abito popolare sardo. L’opera rievoca l’usanza di vendere in casa i prodotti che vi si producevano, ed anch’essa rientra in una serie di murales realizzati da Angelo Pilloni. Proseguendo la via Genoni si dirige verso sud uscendo dall’abitato, e la riprenderemo più avanti quando, illustrando la parte dell’abitato fuori dal centro storico, visiteremo la Funtan'e' Susu.
Dalla via San Giacomo prendiamo, invece, la via San Sebastiano verso sinistra ossia in direzione est e, dopo una quarantina di metri, troviamo a destra la via Genoni e, ad angolo tra la via San Sebastiano e la via Genoni, in corrispondenza del civico numero 1 della via Genoni, troviamo il murale che rappresenta un bambino, con una figura maschile ed una figura femminile. Questa opera raffigura un portale semiaperto da cui si intravede il cortile e l’abitazione retrostante, e davanti al quale sono raffigurati una donna che compra del formaggio da un uomo che lo sta pesando. Entrambi, così come il giovanetto presente sulla sinistra, sono vestiti con l’abito popolare sardo. L’opera rievoca l’usanza di vendere in casa i prodotti che vi si producevano, ed anch’essa rientra in una serie di murales realizzati da Angelo Pilloni. Proseguendo la via Genoni si dirige verso sud uscendo dall’abitato, e la riprenderemo più avanti quando, illustrando la parte dell’abitato fuori dal centro storico, visiteremo la Funtan'e' Susu.
 Passato il punto dove a destra parte la via Genoni, proseguiamo con la via San Sebastiano in direzione est, dopo un’altra sessantina di metri, alla destra della strada in corrispondenza del civico numero 9, troviamo il murale che rappresenta una figura maschile. Questa opera rappresenta, in bianco e nero, un uomo vestito con l’abito tradizionale sardo, che si affaccia idealmente sull’uscio della sua casa. In particolare questa opera è la riproduzione di un’antica fotografia, secondo un espediente abbastanza frequente nella produzione artistica di Angeli Pilloni, e rientra nella serie di murales realizzati dall’artista dal’2007 in collaborazione con l’amministrazione comunale nell’ambito di un progetto di recupero del centro storico.
Passato il punto dove a destra parte la via Genoni, proseguiamo con la via San Sebastiano in direzione est, dopo un’altra sessantina di metri, alla destra della strada in corrispondenza del civico numero 9, troviamo il murale che rappresenta una figura maschile. Questa opera rappresenta, in bianco e nero, un uomo vestito con l’abito tradizionale sardo, che si affaccia idealmente sull’uscio della sua casa. In particolare questa opera è la riproduzione di un’antica fotografia, secondo un espediente abbastanza frequente nella produzione artistica di Angeli Pilloni, e rientra nella serie di murales realizzati dall’artista dal’2007 in collaborazione con l’amministrazione comunale nell’ambito di un progetto di recupero del centro storico.
Il Water Park Nureci che è la piscina comunale all’aperto
Di fronte al civico numero 9 della via San Sebastiano parte la via Sant’Anna, che si dirige verso nord est. Presa la via Sant’Anna la seguiamo per una ventina di metri, e vediamo alla destra della strada, in corrispondenza del civico numero 27, il cancello passato il quale si raggiunge il Water Park Nureci, che è la piscina comunale all’aperto. Incastonata nel centro storico e all’interno di una antica casa a corte, la piscina ed il suo punto di ristoro offrono quanto di meglio ci si possa aspettare in estate.
La presenza della piscina comunale, oltre a essere luogo di svago e alternativa alle spiagge, garantisce a bambini, ragazzi ed adulti la possibilità di svolgere discipline sportive quali aquagym e aquabike, nonché lezioni di nuoto per tutte le età.
Lungo la via San Giacomo verso nord vediamo la Funtan’e Erbei
Per proseguire la visita del centro storico di Nureci, torniamo ora dove la traversa San Giacomo si immessa sulla via San Giacomo. Avevamo preso la via San Giacomo verso destra, ossia in direzione sud ovest, ed eravamo arrivati in piazza Grazia Deledda, ora invece prendiamo la via San Giacomo verso sinistra, ossia in direzione nord est. Seguiamo la via San Giacomo per una trentina di metri, arrivando quasi al punto dove parte a destra la traversa Sant’Anna.
 Subito prima della traversa Sant’Anna, alla sinistra della via San Giacomo si trova la Funtan’e Erbei, che in lingua sarda significa Fontana della Pecora, ed è dedicata all’allevamento e ai cicli produttivi che ne derivano, ossia quello del formaggio e della lana, nonché alle maschere del carnevale sardo che ad esso si ispirano. Si tratta di una delle fontane realizzate dallo scultore Tonino Loi. La fontana presenta una struttura piramidale, e l’acqua sgorga da una stele, sulla cui sommità è scolpita la testa di una pecora, per poi discendere nelle tre vasche sottostanti. Ai lati sono raffigurati, a sinistra, alcuni recipienti per la raccolta del latte, una fuscella, una forma di formaggio, forbici per la tosatura, una rocca e un fuso, mentre a destra sono rappresentati alcuni campanacci e una tipica maschera del carnevale sardo, nonché due coltelli a serramanico.
Subito prima della traversa Sant’Anna, alla sinistra della via San Giacomo si trova la Funtan’e Erbei, che in lingua sarda significa Fontana della Pecora, ed è dedicata all’allevamento e ai cicli produttivi che ne derivano, ossia quello del formaggio e della lana, nonché alle maschere del carnevale sardo che ad esso si ispirano. Si tratta di una delle fontane realizzate dallo scultore Tonino Loi. La fontana presenta una struttura piramidale, e l’acqua sgorga da una stele, sulla cui sommità è scolpita la testa di una pecora, per poi discendere nelle tre vasche sottostanti. Ai lati sono raffigurati, a sinistra, alcuni recipienti per la raccolta del latte, una fuscella, una forma di formaggio, forbici per la tosatura, una rocca e un fuso, mentre a destra sono rappresentati alcuni campanacci e una tipica maschera del carnevale sardo, nonché due coltelli a serramanico.
All’inizio della traversa Sant’Anna il murale con figure maschili
 Proseguiamo ancora lungo la via San Giacomo e una trentina di metri più avanti arriviamo nel punto dove parte, a destra della via San Giacomo, la traversa Sant’Anna. Tra la via San Giacomo e la traversa Sant’Anna, proprio all’inizio della traversa Sant’Anna, alla destra della strada sul primo edificio che sulla via San Giacomo si trova al civico numero 7, è presente un murale che rappresenta figure maschili, con tre uomini anziani, idealmente seduti a chiacchierare per strada, uno dei quali si è appena alzato per congedarsi. Questa opera ricorda un’usanza piuttosto frequente tra gli anziani del paese e non solo, e rientra nella serie di murales realizzati dal muralista Angelo Pilloni.
Proseguiamo ancora lungo la via San Giacomo e una trentina di metri più avanti arriviamo nel punto dove parte, a destra della via San Giacomo, la traversa Sant’Anna. Tra la via San Giacomo e la traversa Sant’Anna, proprio all’inizio della traversa Sant’Anna, alla destra della strada sul primo edificio che sulla via San Giacomo si trova al civico numero 7, è presente un murale che rappresenta figure maschili, con tre uomini anziani, idealmente seduti a chiacchierare per strada, uno dei quali si è appena alzato per congedarsi. Questa opera ricorda un’usanza piuttosto frequente tra gli anziani del paese e non solo, e rientra nella serie di murales realizzati dal muralista Angelo Pilloni.
I murales realizzati nella via Vittorio Emanuele
 Proseguiamo lungo la via San Giacomo e la seguiamo fino alla fine dove, dopo una sessantina di metri, questa strada sbocca sulla via Vittorio Emanuele. Dalla via San Giacomo prendiamo dapprima la via Vittorio Emanuele verso sinistra, ossia in direzione ovest. Appena più avanti alla sinistra della strada, si trova il murale che rappresenta una figura maschile, con buoi ed un cane. Questa opera rappresenta idealmente un’abitazione al civico numero 2, dal cui portale stanno uscendo tre buoi e un vitello, accompagnati da un uomo e da un cane. L’opera rievoca una scena abituale nell’antichità, quando i buoi erano di fondamentale importanza per il lavoro e i trasporti.
Proseguiamo lungo la via San Giacomo e la seguiamo fino alla fine dove, dopo una sessantina di metri, questa strada sbocca sulla via Vittorio Emanuele. Dalla via San Giacomo prendiamo dapprima la via Vittorio Emanuele verso sinistra, ossia in direzione ovest. Appena più avanti alla sinistra della strada, si trova il murale che rappresenta una figura maschile, con buoi ed un cane. Questa opera rappresenta idealmente un’abitazione al civico numero 2, dal cui portale stanno uscendo tre buoi e un vitello, accompagnati da un uomo e da un cane. L’opera rievoca una scena abituale nell’antichità, quando i buoi erano di fondamentale importanza per il lavoro e i trasporti.
 Proseguiamo lungo la via Vittorio Emanuele in direzione ovest per una novantina di metri, fino a poco prima del suo termine dove la strada sbocca sulla via Ungheria. Giunti al termine della via Vittorio Emanuele, alla sinistra della strada in corrispondenza del civico numero 15 della via Vittorio Emanuele, è presente un murale che rappresenta una figura femminile. Questa è un’opera nella quale viene rappresentata una donna anziana davanti all’uscio della sua abitazione, che regge nella sua mano un rosario.
Proseguiamo lungo la via Vittorio Emanuele in direzione ovest per una novantina di metri, fino a poco prima del suo termine dove la strada sbocca sulla via Ungheria. Giunti al termine della via Vittorio Emanuele, alla sinistra della strada in corrispondenza del civico numero 15 della via Vittorio Emanuele, è presente un murale che rappresenta una figura femminile. Questa è un’opera nella quale viene rappresentata una donna anziana davanti all’uscio della sua abitazione, che regge nella sua mano un rosario.
 Dalla via San Giacomo prendiamo ora, invece, la via Vittorio Emanuele verso destra, ossia in direzione est. Proprio di fronte a dove sbocca la via San Giacomo, si trova alla sinistra della strada, tra il civico numero 6 ed il numero 4 della via Vittorio Emanuele, l’edificio sul quale presente il murale che rappresenta una figura maschile con i cavalli. Questa opera rappresenta idealmente un abitazione davanti al cui ingresso sono raffigurati un cavallo e un puledro, insieme a un uomo che sistema qualcosa nella bisaccia, mentre ai suoi piedi sono raffigurati due bidoni del latte. l’opera rievoca una scena piuttosto abituale in antichitàin un paese a vocazione pastorale come quelli della Marmilla.
Dalla via San Giacomo prendiamo ora, invece, la via Vittorio Emanuele verso destra, ossia in direzione est. Proprio di fronte a dove sbocca la via San Giacomo, si trova alla sinistra della strada, tra il civico numero 6 ed il numero 4 della via Vittorio Emanuele, l’edificio sul quale presente il murale che rappresenta una figura maschile con i cavalli. Questa opera rappresenta idealmente un abitazione davanti al cui ingresso sono raffigurati un cavallo e un puledro, insieme a un uomo che sistema qualcosa nella bisaccia, mentre ai suoi piedi sono raffigurati due bidoni del latte. l’opera rievoca una scena piuttosto abituale in antichitàin un paese a vocazione pastorale come quelli della Marmilla.
 Proseguendo il direzione est, tra il civico numero 4 ed il numero 2 della via Vittorio Emanuele si trova il murale che rappresenta una bambina, grano, pane e cesti di vimini. In questa opera sono presenti alcuni cesti in vimini su un telo bianco appeso alla parete, insieme a qualche covone di grano, mentre in basso sono rappresentati sacchi di grano e di farina e un cesto con del pane tipico. A sinistra, davanti a una finestra con delle bottiglie, rappresentata una bambina che mangia del pane. Tutti i murales che abbiamo descritti sono stati realizzati dal muralista Angelo Pilloni, che dal’2007 ha realizzato a Nureci, in collaborazione con l’amministrazione comunale, una serie di murales nell’ambito di un progetto di recupero del centro storico.
Proseguendo il direzione est, tra il civico numero 4 ed il numero 2 della via Vittorio Emanuele si trova il murale che rappresenta una bambina, grano, pane e cesti di vimini. In questa opera sono presenti alcuni cesti in vimini su un telo bianco appeso alla parete, insieme a qualche covone di grano, mentre in basso sono rappresentati sacchi di grano e di farina e un cesto con del pane tipico. A sinistra, davanti a una finestra con delle bottiglie, rappresentata una bambina che mangia del pane. Tutti i murales che abbiamo descritti sono stati realizzati dal muralista Angelo Pilloni, che dal’2007 ha realizzato a Nureci, in collaborazione con l’amministrazione comunale, una serie di murales nell’ambito di un progetto di recupero del centro storico.
Il murale tra la via Laconi e la via Sant’Anna
 Dalla via San Giacomo abbiamo preso la via Vittorio Emanuele verso destra, ossia in direzione est e, dopo meno di una ventina di metri, arriviamo a un bivio, dove a sinistra si prosegue con la via Laconi, mentre a destra parte la via Sant’Anna. Al centro del bivio è presente un edificio tra la via Laconi 2 e la via Sant’Anna, sulla cui facciata si trova un murale con una figura femminile ed un quadro con veduta di Nureci e Cristo crocifisso. Questa opera rappresenta idealmente un quadro alla parete in cui raffigurato Cristo crocifisso, con un campanile e alcune abitazioni sullo sfondo. Davanti al dipinto è rappresentata, in rilievo, una donna in costumetradizionale e con il capo velato che tiene in mano un mazzo di fiori. Nell’opera, il paesaggio rappresentato corrisponde a una veduta di Nureci, di cui si riconosce la chiesa di Santa Barbara e i tipici portali delle abitazioni costruite in pietra locale.
Dalla via San Giacomo abbiamo preso la via Vittorio Emanuele verso destra, ossia in direzione est e, dopo meno di una ventina di metri, arriviamo a un bivio, dove a sinistra si prosegue con la via Laconi, mentre a destra parte la via Sant’Anna. Al centro del bivio è presente un edificio tra la via Laconi 2 e la via Sant’Anna, sulla cui facciata si trova un murale con una figura femminile ed un quadro con veduta di Nureci e Cristo crocifisso. Questa opera rappresenta idealmente un quadro alla parete in cui raffigurato Cristo crocifisso, con un campanile e alcune abitazioni sullo sfondo. Davanti al dipinto è rappresentata, in rilievo, una donna in costumetradizionale e con il capo velato che tiene in mano un mazzo di fiori. Nell’opera, il paesaggio rappresentato corrisponde a una veduta di Nureci, di cui si riconosce la chiesa di Santa Barbara e i tipici portali delle abitazioni costruite in pietra locale.
I murales realizzati nella via Laconi
 Appena presa dalla via Vittorio Emanuele la via Laconi, alla sinistra di questa strada, tra il civico numero 1 ed il numero 3, è presente il murale che rappresenta una conversazione con zia Maria, nel quale sono presenti una figura femminile ed una figura maschile a dorso di un asino. Questa opera rappresenta idealmente un abitazione davanti alla quale raffigurata la donna di profilo che chiacchiera con un uomo a dorso di un asino, ed entrambi sono vestiti con l’abito popolare sardo. L’opera rievoca una scena abituale nell’antichità, quando l’asino era un elemento di fondamentale importanza per il lavoro e per i trasporti. Percorsa una trentina di metri, dalla via Laconi parte a destra la via conte Touffani, che descriveremo meglio più avanti.
Appena presa dalla via Vittorio Emanuele la via Laconi, alla sinistra di questa strada, tra il civico numero 1 ed il numero 3, è presente il murale che rappresenta una conversazione con zia Maria, nel quale sono presenti una figura femminile ed una figura maschile a dorso di un asino. Questa opera rappresenta idealmente un abitazione davanti alla quale raffigurata la donna di profilo che chiacchiera con un uomo a dorso di un asino, ed entrambi sono vestiti con l’abito popolare sardo. L’opera rievoca una scena abituale nell’antichità, quando l’asino era un elemento di fondamentale importanza per il lavoro e per i trasporti. Percorsa una trentina di metri, dalla via Laconi parte a destra la via conte Touffani, che descriveremo meglio più avanti.
 Percorsa un altra cinquantina di metri, alla destra della strada, in corrispondenza del civico numero 12 della via Laconi, è presente un murale che raffigura una figura una figura maschile ed una figura femminile. Questa opera rappresenta, in bianco e nero, un uomo idealmente seduto davanti all’uscio della sua abitazione che è intento ad intrecciare dei giunchi per realizzare un cestino, mentre chiacchiera con una donna che gli è vicina, e sulla destra sono raffigurati alcuni cesti di uva sotto una vite carica di frutti.
Percorsa un altra cinquantina di metri, alla destra della strada, in corrispondenza del civico numero 12 della via Laconi, è presente un murale che raffigura una figura una figura maschile ed una figura femminile. Questa opera rappresenta, in bianco e nero, un uomo idealmente seduto davanti all’uscio della sua abitazione che è intento ad intrecciare dei giunchi per realizzare un cestino, mentre chiacchiera con una donna che gli è vicina, e sulla destra sono raffigurati alcuni cesti di uva sotto una vite carica di frutti.
 Proseguendo appena una ventina di metri, alla sinistra della strada in corrispondenza del civico numero 29 della via Laconi, è presente un murale che descrive la preparazione del formaggio. Questa opera raffigura, ancora in bianco e nero, a destra due uomini che preparano il formaggio, mentre a sinistra un terzo uomo, di spalle, porta un bidone del latte accompagnato da un cane. Tutti i murales che abbiamo descritti rientrano in una serie di murales realizzati dal muralista Angelo Pilloni, che dal’2007 ha realizzato a Nureci una serie di murales nell’ambito di un progetto di recupero del centro storico, in collaborazione con l’amministrazione comunale.
Proseguendo appena una ventina di metri, alla sinistra della strada in corrispondenza del civico numero 29 della via Laconi, è presente un murale che descrive la preparazione del formaggio. Questa opera raffigura, ancora in bianco e nero, a destra due uomini che preparano il formaggio, mentre a sinistra un terzo uomo, di spalle, porta un bidone del latte accompagnato da un cane. Tutti i murales che abbiamo descritti rientrano in una serie di murales realizzati dal muralista Angelo Pilloni, che dal’2007 ha realizzato a Nureci una serie di murales nell’ambito di un progetto di recupero del centro storico, in collaborazione con l’amministrazione comunale.
Proseguendo, la via Laconi si dirige fino all’estremo nord orientale dell’abitato, dove ci recheremo più avanti quando, illustrando la parte dell’abitato fuori dal centro storico, visiteremo la Fontana dei Poeti.
All’inizio della via Toufani è presente il ritratto di Guglielmo Toufani a cavallo
 Dalla via Vittorio Emanuele eravamo arrivati al bivio dove parte a destra la via Sant’Anna, ed avevamo preso verso sinistra la via Laconi. Seguiamo la via Laconi per una trentina di metri, fino ad arrivare nel punto in cui da essa parte a destra la via Touffani. Proprio all’inizio della via Toufani, alla destra al civico numero 2, si trova per primo un murale che rappresenta un cesto di mele cotogne sull’uscio di una casa. In questa opera è rappresentato l’uscio semiaperto di un abitazione, davanti al quale viene raffigurata una seggiola con un cesto di mele cotogne, e l’opera rievoca l’usanza di esporre davanti al proprio uscio i prodotti di produzione propria che erano destinati alle vendita.
Dalla via Vittorio Emanuele eravamo arrivati al bivio dove parte a destra la via Sant’Anna, ed avevamo preso verso sinistra la via Laconi. Seguiamo la via Laconi per una trentina di metri, fino ad arrivare nel punto in cui da essa parte a destra la via Touffani. Proprio all’inizio della via Toufani, alla destra al civico numero 2, si trova per primo un murale che rappresenta un cesto di mele cotogne sull’uscio di una casa. In questa opera è rappresentato l’uscio semiaperto di un abitazione, davanti al quale viene raffigurata una seggiola con un cesto di mele cotogne, e l’opera rievoca l’usanza di esporre davanti al proprio uscio i prodotti di produzione propria che erano destinati alle vendita.
 Subito più avanti, alla sinistra del primo murale, è presente un’altra opera che rappresenta, a rilievo, un ritratto di Guglielmo Toufani a cavallo, il quale tiene nella mano destra un gonfalone, mentre sullo sfondo, realizzato a incisione, sono raffigurate alcune case e un paesaggio agreste. Questa opera, che è stata realizzata con una tecnica abbastanza inusuale per l’artista, intende celebrare la figura storica di Guglielmo Toufani. Entrambe queste opere sono state realizzate dal muralista Angelo Pilloni, nato a San Sperate nel 1945, che dal’2007 ha realizzato a Nureci anche una serie di murales nell’ambito di un progetto di recupero del centro storico, in collaborazione con l’amministrazione comunale.
Subito più avanti, alla sinistra del primo murale, è presente un’altra opera che rappresenta, a rilievo, un ritratto di Guglielmo Toufani a cavallo, il quale tiene nella mano destra un gonfalone, mentre sullo sfondo, realizzato a incisione, sono raffigurate alcune case e un paesaggio agreste. Questa opera, che è stata realizzata con una tecnica abbastanza inusuale per l’artista, intende celebrare la figura storica di Guglielmo Toufani. Entrambe queste opere sono state realizzate dal muralista Angelo Pilloni, nato a San Sperate nel 1945, che dal’2007 ha realizzato a Nureci anche una serie di murales nell’ambito di un progetto di recupero del centro storico, in collaborazione con l’amministrazione comunale.
Nella via Touffani si trova l’antico palazzo del conte Touffani
Dalla via Lacono prendiamo la via Touffani, che procede per una settantina di metri e poi termina, ma sulla sinistra si vede l’antico palazzo del conte Touffani, ricco mercante marsigliese che, stabilitosi in Sardegna per interessi mercantili, a cui nel 1759 è stato concesso da Carlo Emanuele III, Re di Sardegna, il titolo di conte di Nureci e Asuni. Si prevede che la casa sarà oggetto di un prossimo intervento di restauro allo scopo dargli una seconda opportunità, che potrà essere di tipo polifunzionale, ricreativo o ricettivo, o anche culturale.
Nella via Sant’Anna si trova l’edificio che ospitava il Monte Granatico
 Dalla via Vittorio Emanuele, dopo un centinaio di metri, eravalo arrivati a un bivio dove parte a sinistra la via Laconi, mentre svoltiamo a destra nella via Sant’Anna. Percorsa una cinquantina di metri lungo la via Sant’Anna verso sud, alla destra della strada poco dopo il civico numero 2 e subito prima della traversa Sant’Anna, si trova l’edificio che ospitava il Monte Granatico, creato nel 1765 per far fronte alle necessità dei contadini bisognosi che vivevano nel territorio, garantendo un prestito in grano e in orzo che doveva essere restituito, con un interesse molto basso, nel periodo dell’immagazzinamento delle granaglie. Si tratta di un edificio a pianta longitudinale regolare, con struttura muraria portante di pietra informe a vista ad assestamento irregolare allettata con malta di calce. Internamente si apre su due ambienti divisi da un ampio arco diaframma a due fornici a tutto sesto. La copertura è portata da un’orditura lignea di arcarecci, travicelli e Incannucciato orriu, con sovrastante manto di coppi in laterizio.
Dalla via Vittorio Emanuele, dopo un centinaio di metri, eravalo arrivati a un bivio dove parte a sinistra la via Laconi, mentre svoltiamo a destra nella via Sant’Anna. Percorsa una cinquantina di metri lungo la via Sant’Anna verso sud, alla destra della strada poco dopo il civico numero 2 e subito prima della traversa Sant’Anna, si trova l’edificio che ospitava il Monte Granatico, creato nel 1765 per far fronte alle necessità dei contadini bisognosi che vivevano nel territorio, garantendo un prestito in grano e in orzo che doveva essere restituito, con un interesse molto basso, nel periodo dell’immagazzinamento delle granaglie. Si tratta di un edificio a pianta longitudinale regolare, con struttura muraria portante di pietra informe a vista ad assestamento irregolare allettata con malta di calce. Internamente si apre su due ambienti divisi da un ampio arco diaframma a due fornici a tutto sesto. La copertura è portata da un’orditura lignea di arcarecci, travicelli e Incannucciato orriu, con sovrastante manto di coppi in laterizio.
Sempre in via Sant’Anna vediamo la Funtana de Pippios
 Proseguendo lungo la via Sant’Anna verso sud dopo il Monte Granatico, percorse poche decine di metri si vede, sempre alla destra della strada subito dopo la traversa Sant’Anna e prima del civico numero 18, la Funtana de Pippios, che in lingua sarda significa Fontana dei Bambini. Si tratta di una delle fontane realizzate dallo scultore Tonino Loi. La fontana è dedicata all’infanzia e intende rievocare gli antichi giochi infantili che annualmente rivivono nell’Olimpiade del gioco tradizionale della Sardegna che si tiene a Nureci e in altri paesi della Marmilla. La fontana costituita da un unica vasca su cui defluisce l’acqua che sgorga da una stele, alla cui sommità sono scolpiti due bambini che giocano. Ai lati sono raffigurati, a sinistra, alcuni antichi giochi per bambini, tra cui il cavallino di canna, la fionda, la trottola e l’arco con freccia.
Proseguendo lungo la via Sant’Anna verso sud dopo il Monte Granatico, percorse poche decine di metri si vede, sempre alla destra della strada subito dopo la traversa Sant’Anna e prima del civico numero 18, la Funtana de Pippios, che in lingua sarda significa Fontana dei Bambini. Si tratta di una delle fontane realizzate dallo scultore Tonino Loi. La fontana è dedicata all’infanzia e intende rievocare gli antichi giochi infantili che annualmente rivivono nell’Olimpiade del gioco tradizionale della Sardegna che si tiene a Nureci e in altri paesi della Marmilla. La fontana costituita da un unica vasca su cui defluisce l’acqua che sgorga da una stele, alla cui sommità sono scolpiti due bambini che giocano. Ai lati sono raffigurati, a sinistra, alcuni antichi giochi per bambini, tra cui il cavallino di canna, la fionda, la trottola e l’arco con freccia.
 Proseguendo ancora verso sud con la via Sant’Anna per poche decine di metri, ancora alla destra della strada, sull’edificio al civico numero 20, si vede il murale che rappresenta una fontana con figure femminili. Questa opera rappresenta idealmente due donne, di cui una anziana, che attingono l’acqua con delle anfore alla fontana pubblica. L’opera rievoca un’usanza piuttosto frequente in antichità, quando nelle abitazioni non esisteva l’acqua corrente e si andava a prenderla nelle fontane pubbliche, e rientra in una serie di murales realizzati dal muralista Angelo Pilloni dal’2007 in collaborazione con l’amministrazione comunale nell’ambito del progetto di recupero del centro storico.
Proseguendo ancora verso sud con la via Sant’Anna per poche decine di metri, ancora alla destra della strada, sull’edificio al civico numero 20, si vede il murale che rappresenta una fontana con figure femminili. Questa opera rappresenta idealmente due donne, di cui una anziana, che attingono l’acqua con delle anfore alla fontana pubblica. L’opera rievoca un’usanza piuttosto frequente in antichità, quando nelle abitazioni non esisteva l’acqua corrente e si andava a prenderla nelle fontane pubbliche, e rientra in una serie di murales realizzati dal muralista Angelo Pilloni dal’2007 in collaborazione con l’amministrazione comunale nell’ambito del progetto di recupero del centro storico.
Nella via Santa Barbara vediamo la Funtana Muvrone
 Subito di fronte al civico nuemro 20, parte a sinistra la via Santa Barbara. La seguiamo per una quarantina di metri e vediamo alla destra della strada, circa di fronte al civico numero 8, la Funtana Muvrone, che in lingua sarda significa Fontana del Muflone. La fontana è costituita da due vasche sovrapposte sulle quali discende l’acqua che sgorga da una stele soprastante, decorata con un motivo di corna taurine e alla cui sommità scolpito un muflone di profilo. Ai suoi lati sono presenti due comparti su cui sono raffigurati sinteticamente alcuni profili di mufloni. La fontana è dedicata, quindi. a questo animale selvatico che vive nelle montagne sarde. e la sua raffigurazione stilizzata, insieme a quella delle corna taurine, rievoca alcuni motivi tipici dei graffiti prenuragici. Si tratta di una delle fontane realizzate dallo scultore Tonino Loi.
Subito di fronte al civico nuemro 20, parte a sinistra la via Santa Barbara. La seguiamo per una quarantina di metri e vediamo alla destra della strada, circa di fronte al civico numero 8, la Funtana Muvrone, che in lingua sarda significa Fontana del Muflone. La fontana è costituita da due vasche sovrapposte sulle quali discende l’acqua che sgorga da una stele soprastante, decorata con un motivo di corna taurine e alla cui sommità scolpito un muflone di profilo. Ai suoi lati sono presenti due comparti su cui sono raffigurati sinteticamente alcuni profili di mufloni. La fontana è dedicata, quindi. a questo animale selvatico che vive nelle montagne sarde. e la sua raffigurazione stilizzata, insieme a quella delle corna taurine, rievoca alcuni motivi tipici dei graffiti prenuragici. Si tratta di una delle fontane realizzate dallo scultore Tonino Loi.
In via Santa Barbara si trova il Centro di Interpretazione Paleontologico e del Paesaggio
 Proseguiamo lungo la via Santa Barbara ed arriviamo al civico numero 14, dove ha la sua sede il Centro di Interpretazione Paleontologico e del Paesaggio, ossia il Museo CIPP, che accoglie una raccolta di fossili provenienti dal territorio. I reperti fossili ritrovati, rivestono grande importanza per la datazione delle rocce che li contengono, ed inoltre informano sul clima e sul paesaggio presente durante la loro esistenza. Il patrimonio geologico e paleontologico del territorio comunale di Nureci riveste, in virtù della sua importanza a livello scientifico e del suo interesse naturalistico culturale, un ruolo di primissimo piano nel contesto geologico regionale e dell’intero ambito del mediterraneo.
Proseguiamo lungo la via Santa Barbara ed arriviamo al civico numero 14, dove ha la sua sede il Centro di Interpretazione Paleontologico e del Paesaggio, ossia il Museo CIPP, che accoglie una raccolta di fossili provenienti dal territorio. I reperti fossili ritrovati, rivestono grande importanza per la datazione delle rocce che li contengono, ed inoltre informano sul clima e sul paesaggio presente durante la loro esistenza. Il patrimonio geologico e paleontologico del territorio comunale di Nureci riveste, in virtù della sua importanza a livello scientifico e del suo interesse naturalistico culturale, un ruolo di primissimo piano nel contesto geologico regionale e dell’intero ambito del mediterraneo.
Nella struttura museale sono esposte anche alcune terrecotte rappresentanti la vita quotidiana degli agricoltori rurali, opera di Pinuccio Sciola, ed è stata una scelta coraggiosa quella dell’artista di creare il suo spazio vitale in questo paesino un pò fuori mano dal turismo di massa. La mostra, intitolata Is Prinzipales, rappresenta un omaggio alla sua gente, alle persone che lo hanno visto crescere, formato, consigliato, aiutato e che sono state fonte di ispirazione per le sue numerose opere d’arte.
La parte dell’abitato al di fuori del centro storico
All’interno del centro storico dell’abitato di Nureci abbiamo visto, tra l’altro, una ventina dei murales realizzati dal muralista Angelo Pilloni e sette fontane dello scultore Tonino Loi in collaborazione con l’amministrazione comunale nell’ambito del progetto di recupero del centro storico. Usciamo, ora, dal centro storico e vediamo anche le altre fontane presenti nell’abitato di Nureci.
Nella via delle Fontane vediamo la Funtanedda
 Passato il civico numero 14 della via Santa Barbara, proseguiamo e dopo una ventina di metri la via Santa Barbara si immette sulla via delle Fontane, la strada che parte dalla via Sant’Anna verso destra, una cinquantina di metri prima di dove è partita a destra la via Santa Barbara, e si dirige verso sud est. La strada assume il suo nome dal fatto che partendo da essa è possibile raggiungere altre fontane, oltre alle sette che abbiamo già viste all’interno del centro abitato. La via Santa Barbara si immette in via delle Fontane di fronte al civico numero 11, ed alla destra del portale di questo edificio è presente la Funtanedda, che in lingua sarda significa Fontanella, la quale è anch’essa una delle fontane realizzate dallo scultore Tonino Loi. Questa fontana, costituita da un’unica vasca su cui defluisce l’acqua che sgorga da una stele, alla cui sommità è scolpito un toro di profilo, è la prima delle tre fontane realizzate al di fuori del centro storico che vedremo nella nostra descrizione dell’abitato di Nureci.
Passato il civico numero 14 della via Santa Barbara, proseguiamo e dopo una ventina di metri la via Santa Barbara si immette sulla via delle Fontane, la strada che parte dalla via Sant’Anna verso destra, una cinquantina di metri prima di dove è partita a destra la via Santa Barbara, e si dirige verso sud est. La strada assume il suo nome dal fatto che partendo da essa è possibile raggiungere altre fontane, oltre alle sette che abbiamo già viste all’interno del centro abitato. La via Santa Barbara si immette in via delle Fontane di fronte al civico numero 11, ed alla destra del portale di questo edificio è presente la Funtanedda, che in lingua sarda significa Fontanella, la quale è anch’essa una delle fontane realizzate dallo scultore Tonino Loi. Questa fontana, costituita da un’unica vasca su cui defluisce l’acqua che sgorga da una stele, alla cui sommità è scolpito un toro di profilo, è la prima delle tre fontane realizzate al di fuori del centro storico che vedremo nella nostra descrizione dell’abitato di Nureci.
Da dove la via Santa Barbara si è immessa sulla via delle Fontane, prendiamo quest'ultima verso destra dove si dirige verso sud, e seguendola per circa duecento metri arriviamo a vedere alla destra della strada la Funtan'e' Susu, ed alla sinistra l’Arena Mamma Blues. Ma arrivarci con la via delle Fontane è molto disagevole, dato che la strada divene presto una sterrata, per cui conviene arrivare a quel punto da sud, seguendo un’altra strada che è la via Funtana Susu.
La Funtan'e' Susu
 Avevamo visto il punto dove dalla via San Sebastiano, che si dirige verso ovest, parte a destra la via Genoni. Prendiamo la via Genoni che si dirige verso sud uscendo dall’abitato, la seguiamo per duecentosettanta metri finché questa strada va ad immettersi sulla via Sant’Ignazio, la quale arriva da sinistra e la cui continuazione verso destra è la via Funtana Susu. Svoltiamo a sinistra nella via Funtana Susu e, dopo duecentoquaranta metri, troviamo una deviazione a sinistra in una stretta strada pedonale in discesa, seguendo la quale raggiungiamo in poche decine di metri l’insieme delle opere che costituiscono la cosiddetta Funtan'e' Susu, che in lingua sarda significa Fontana di sopra. Questa fontana è stata realizzata per sostituire una fontana più antica che era raggiungibile appunto con la via Fontana Susu, la quale era andata distrutta sul finire del secolo scorso. L’opera rientra in un percorso di fontane realizzato, in collaborazione con l’amministrazione comunale, nell’ambito di un progetto di recupero e valorizzazione del centro storico, ed è stata realizzata dallo scultore Piergiorgio Gometz che, pur essendo nato a Dorgali nel 1940, ha operato a Cagliari principalmente come scultore e ceramista. La fontana è costituita, appunto, da alcuni rilievi ceramici che si sovrappongono ai due elementi principali, decorandone la struttura. Si tratta dei quattro pannelli che decorano l’elemento centrale di una fontana a vasca ottagonale collocata al centro della piazza, ed in essa è presente un elemento scultoreo che sovrasta la vasca circolare collocata entro una nicchia ad essa prospiciente.
Avevamo visto il punto dove dalla via San Sebastiano, che si dirige verso ovest, parte a destra la via Genoni. Prendiamo la via Genoni che si dirige verso sud uscendo dall’abitato, la seguiamo per duecentosettanta metri finché questa strada va ad immettersi sulla via Sant’Ignazio, la quale arriva da sinistra e la cui continuazione verso destra è la via Funtana Susu. Svoltiamo a sinistra nella via Funtana Susu e, dopo duecentoquaranta metri, troviamo una deviazione a sinistra in una stretta strada pedonale in discesa, seguendo la quale raggiungiamo in poche decine di metri l’insieme delle opere che costituiscono la cosiddetta Funtan'e' Susu, che in lingua sarda significa Fontana di sopra. Questa fontana è stata realizzata per sostituire una fontana più antica che era raggiungibile appunto con la via Fontana Susu, la quale era andata distrutta sul finire del secolo scorso. L’opera rientra in un percorso di fontane realizzato, in collaborazione con l’amministrazione comunale, nell’ambito di un progetto di recupero e valorizzazione del centro storico, ed è stata realizzata dallo scultore Piergiorgio Gometz che, pur essendo nato a Dorgali nel 1940, ha operato a Cagliari principalmente come scultore e ceramista. La fontana è costituita, appunto, da alcuni rilievi ceramici che si sovrappongono ai due elementi principali, decorandone la struttura. Si tratta dei quattro pannelli che decorano l’elemento centrale di una fontana a vasca ottagonale collocata al centro della piazza, ed in essa è presente un elemento scultoreo che sovrasta la vasca circolare collocata entro una nicchia ad essa prospiciente.
Le prime quattro foto qui riportate sono relative al primo elemento dell’intervento dell’artista, che consiste nella decorazione ceramica che riveste l’elemento verticale, a base quadrangolare, collocato al centro di una vasca ottagonale e sormontato da un bacile a forma di tartaruga. Nei pannelli sono raffigurate, a rilievo o a graffito e su uno sfondo a mosaico, alcune scene di vita quotidiana tra cui due donne che lavano i panni e un pastore col gregge, o scene legate alla natura con la raffigurazione di Diana cacciatrice e di animali vari, o ancora simboli legati all’iconografia prenuragica come bronzetti e pintadere, ed elementi decorativi tipici dell’artigianato sardo come la pavoncella.
 L’ultima foto qui riportata è relativa al secondo elemento dell’intervento dell’artista, che consiste nella scultura ceramica collocata entro una nicchia e raffigurante una madre che allatta un bambino, ai cui piedi è presente un’anfora dalla quale sgorga l’acqua, che ricade nella vasca circolare sottostante. Nel suo intervento l’artista ha voluto celebrare l’importanza vitale dell’acqua, cui allude la scena con l’allattamento da parte della donna, ma ha voluto celebrare anche la stessa Nureci e la sua storia, dato che alcune scene rievocano l’importante funzione di luogo d’incontro come lavatoio e abbeveratoio per le greggi della più antica fontana, mentre altre alludono al periodo nuragico e alla fauna del paese dell’Alta Marmilla.
L’ultima foto qui riportata è relativa al secondo elemento dell’intervento dell’artista, che consiste nella scultura ceramica collocata entro una nicchia e raffigurante una madre che allatta un bambino, ai cui piedi è presente un’anfora dalla quale sgorga l’acqua, che ricade nella vasca circolare sottostante. Nel suo intervento l’artista ha voluto celebrare l’importanza vitale dell’acqua, cui allude la scena con l’allattamento da parte della donna, ma ha voluto celebrare anche la stessa Nureci e la sua storia, dato che alcune scene rievocano l’importante funzione di luogo d’incontro come lavatoio e abbeveratoio per le greggi della più antica fontana, mentre altre alludono al periodo nuragico e alla fauna del paese dell’Alta Marmilla.
L’Arena Mamma Blues

 Lungo la via Funtana Susu, subito dopo la deviazione a sinistra in una stretta strada pedonale in discesa, vediamo alla destra della strada l’Arena Mamma Blues, nella quale ogni anno, alla metà di agosto, si tiene il Mamma Blues Festival, la rassegna di musica blues e jazz alla quale partecipano, con i loro concerti, numerosi grandi musicisti nazionali e internazionali. Il festival, le cui esibizioni si svolgono anche in altri luoghi del paese oltre che nell’Arena, consiste in una rassegna internazionale di blues e jazz, che nasce dal canto dagli schiavi africani deportati nelle Americhe, con un linguaggio senza confini, e si svolge con sparse per il paese e arricchite di punti di sosta e di ascolto, vere e proprie istallazioni sonore e artistiche. L’arena si trova nella campagna, assai vicina al’Museo CIPP, a sud est rispetto ad esso.
Lungo la via Funtana Susu, subito dopo la deviazione a sinistra in una stretta strada pedonale in discesa, vediamo alla destra della strada l’Arena Mamma Blues, nella quale ogni anno, alla metà di agosto, si tiene il Mamma Blues Festival, la rassegna di musica blues e jazz alla quale partecipano, con i loro concerti, numerosi grandi musicisti nazionali e internazionali. Il festival, le cui esibizioni si svolgono anche in altri luoghi del paese oltre che nell’Arena, consiste in una rassegna internazionale di blues e jazz, che nasce dal canto dagli schiavi africani deportati nelle Americhe, con un linguaggio senza confini, e si svolge con sparse per il paese e arricchite di punti di sosta e di ascolto, vere e proprie istallazioni sonore e artistiche. L’arena si trova nella campagna, assai vicina al’Museo CIPP, a sud est rispetto ad esso.
La Fontana dei Poeti
 Per vedere l’ultima delle fontane ralizzate a Nureci, torniamo alla fine della via Vittorio Emanuele al bivio, dove a destra parte la via Sant’Anna mentre a sinistra parte la via Laconi. Prendiamo la via Laconi e la seguiamo fino nella periferia nord orientale del paese. Percorsi circa trecento metri, dopo il civico numero 11 prendiamo la deviazione sulla destra che porta a vedere, alla sinistra della strada, i giardini del sottomonte, il parco giochi comunale all’interno dei quali si trova l’insieme delle opere che costituiscono la cosiddetta Fontana dei Poeti, che è anch’essa una delle fontane realizzate dallo scultore Tonino Loi. L’opera si compone di cinque fontane separate da grossi massi e disposte ad andamento semicircolare, e davanti alle quali è collocato un monolite che rievoca un menhir prenuragico. La fontana è dedicata ad alcuni dei maggiori poeti sardi dei quali si riportano alcuni tra i loro versi più noti. I poeti ai quali il complesso della Fontana dei Poeti è dedicata sono Sergio Atzeni, Melchiorre Murenu, padre Luca Cubeddu, Peppino Mereu, ed Antioco Casula noto come Montanaru.
Per vedere l’ultima delle fontane ralizzate a Nureci, torniamo alla fine della via Vittorio Emanuele al bivio, dove a destra parte la via Sant’Anna mentre a sinistra parte la via Laconi. Prendiamo la via Laconi e la seguiamo fino nella periferia nord orientale del paese. Percorsi circa trecento metri, dopo il civico numero 11 prendiamo la deviazione sulla destra che porta a vedere, alla sinistra della strada, i giardini del sottomonte, il parco giochi comunale all’interno dei quali si trova l’insieme delle opere che costituiscono la cosiddetta Fontana dei Poeti, che è anch’essa una delle fontane realizzate dallo scultore Tonino Loi. L’opera si compone di cinque fontane separate da grossi massi e disposte ad andamento semicircolare, e davanti alle quali è collocato un monolite che rievoca un menhir prenuragico. La fontana è dedicata ad alcuni dei maggiori poeti sardi dei quali si riportano alcuni tra i loro versi più noti. I poeti ai quali il complesso della Fontana dei Poeti è dedicata sono Sergio Atzeni, Melchiorre Murenu, padre Luca Cubeddu, Peppino Mereu, ed Antioco Casula noto come Montanaru.
Le prime quattro foto in seguito riportate sono relative al grosso monolite disposto al centro dell’installazione, che presenta nei quattro lati alcuni elementi decorativi, graffiti che ricordano iconografie prenuragiche tra cui le corna taurine e la spirale.
Le successive foto sono relative agli elementi dedicati ai poeti. La prima foto è relativa al primo elemento dell’installazione, che consiste in una vasca su cui defluisce l’acqua che sgorga da una stele. Su di essa sono incisi alcuni versi tratti da Passavamo sulla terra leggeri di Sergio Atzeni, attorno ai quali sono raffigurati elementi decorativi geometrici, tra cui spicca, in basso, una navicella nuragica. La successiva foto è relativa al secondo elemento dell’installazione, che consiste in una vasca su cui defluisce l’acqua che sgorga da una stele. Su di essa sono incisi alcuni versi in lungua sarda di Melchiorre Murenu, attorno ai quali sono raffigurati elementi decorativi geometrici. La successiva foto è relativa al terzo elemento dell’installazione, che consiste in una vasca su cui defluisce l’acqua che sgorga da una stele. Su di essa sono incisi alcuni versi in lingua sarda di padre Luca Cubeddu, attorno ai quali sono raffigurati elementi decorativi geometrici. La successiva foto è relativa al quarto elemento dell’installazione, che consiste in una vasca su cui defluisce l’acqua che sgorga da una stele. Su di essa sono incisi alcuni versi in lingua sarda di Peppino Mereu, attorno ai quali sono raffigurati elementi decorativi di tipo geometrico, tra i quali si riconosce anche a sinistra una rocca e un fuso, ed a destra alcune anfore. La successiva foto è relativa al quinto elemento dell’installazione, che consiste in una vasca su cui defluisce l’acqua che sgorga da una stele. Su di essa sono incisi alcuni versi in lingua sarda di Antioco Casula noto come Montanaru, attorno ai quali sono raffigurati elementi decorativi geometrici, tra i quali si riconosce anche a destra una barca a vela stilizzata.
Al termine della via Laconi verso nord est si trova il Campo da Calcetto di Nureci
Proseguendo lungo la via Laconi, dopo un’altra cinquantina di metri si vede alla destra della strada il Parco Briaxiu, un piccolo parco comunale all’interno del quale si può vedere l’ingresso del Campo da Calcetto ossia da calcio a cinque di Nureci, con fondo in erba sintetica, dotato di tribune in grado di ospitare una novantina di spettatori.
Visita dei dintorni di Nureci
Per quanto riguarda le principali ricerche archeologiche effettuate nei dintorni di Nureci, sono state portate alla luce numerose vestigia dell’antico passato, con alcune domus de janas, e i siti prenuragici di Murtas, Santa Barbara, Giuerri Mannu e Is Pranus. A Santa Barbara, Murtas e a Is Pranus si tratta della presenza dell’industria litica, su ossidiana e marna. Nel caso di Murtas abbiamo la presenza di una struttura circolare di lastre ortostatiche, per la quale è facile il richiamo ai circoli megalitici del prenuragico. In Giuerri Mannu si ha l’esplicita presenza di un piede di tripode e di orli a labbro sbiecato attribuibili alla cultura di Monte Claro. Di notevole importanza è la località di Sa Corona e Su Crobu, dove sorge un recinto megalitico risalente forse al terzo millennio avanti Cristo. Sono presenti, inoltre, pochi resti di diversi nuraghi che non sono però ben conservati, Si tratta del nuraghe semplici Attori al confine col territorio del comune di Genoni, dei nuraghi semplici Is Procilis, Iscala Gossu, Murtas, Pranu d’Ollastu, Serri Armas, Sinipei, Urielli; ed anche del nuraghe Megalitico, e dei nuraghi Pardu, e Turri Piccinu, tutti questi di tipologia indefinita. Vediamo ora che cosa si trova di più sigificativo nei dintorni dell’abitato che abbiamo appena descritto.
Il Campo Comunale da Calcio
Dal’Municipio di Nureci prendiamo verso la via della Parrocchia, ossia in direzione sud ovest, la via Ungheria che, dopo duecentocinquanta metri, incrocia la via San Sebastiano, che prendiamo verso destra. Seguiamo la via San Sebastiano che, dopo centocinquanta metri, incrocia la via degli Olmi, e dopo l’ncrocio proseguiamo sulla continuazione della via San Sebastiano che, dopo una settantina di metri, incrocia la SS442 di Laconi e di Uras. Superiamo l’incrocio e proseguiamo dritti sulla prosecuzione della via San Sebastiano e, dopo circa duecentocinquanta metri, vediamo alla destra della strada, l’ingresso del Campo Comunale da Calcio. Il campo da calcio, dotato di tribune in grado di ospitare 200 spettatori, è stato oggetto di importanti lavori eseguiti per mezzo di finanziamenti pubblici che gli hanno dato nuova vita, ed ora esso si presenta con manto di erba sintetica e nuovi spogliatoi.
I siti archeologici sul colle di Magumadas
 Lungo la strada che ci ha portati all’ingresso del Campo Comunale da Calcio, una cinquantina di metri prima di arrivarci, parte una deviazione a sinistra dalla quale, dopo un’altra cinquantina di metri, si vede a sinistra un vialetto che conduce a un edificio agricolo che si trova all’estremo settentrionale del Colle di Magumadas. Si tratta di un pianoro di formazione calcarea conformato a torrione naturale ellittico di 100 per 60 metri, che si presenta soprattutto sul versante orientale con i fianchi scoscesi.
Lungo la strada che ci ha portati all’ingresso del Campo Comunale da Calcio, una cinquantina di metri prima di arrivarci, parte una deviazione a sinistra dalla quale, dopo un’altra cinquantina di metri, si vede a sinistra un vialetto che conduce a un edificio agricolo che si trova all’estremo settentrionale del Colle di Magumadas. Si tratta di un pianoro di formazione calcarea conformato a torrione naturale ellittico di 100 per 60 metri, che si presenta soprattutto sul versante orientale con i fianchi scoscesi.  A levante del breve altopiano si apre una fertilissima piana, solcata dal’Riu Magomadas e limitata, sul lato orientale, da un sistema di colline. Sopra il colle si trovano pochi resti del nuraghe Pardu, che fa parte del comune di Nureci dal quale dista in linea d’aria circa un chilometro. Si tratta di un nuraghe non classificato, edificato in materiale indeterminato a 389 metri di altezza. La presenza di un insediamento nuragico nella località è documentato dalla numerosa ceramica d’impasto che è stata rinvenuta, tra cui un frammento di ansa a gomito rovescio, probabilmente della prima età del Ferro. Nel territorio sono presenti anche pochi resti del Centro punico di Magom-hadash, che parrebbe articolarsi in un’acropoli, localizzata nel settore settentrionale del pianoro, ed in un abitato che si estende ad ovest e a sud, con la necropoli che potrebbe situarsi a nord ovest. Sono presenti anche i resti della successiva presenza romana durante l’età tardo repubblicana e al successivo periodo imperiale.
A levante del breve altopiano si apre una fertilissima piana, solcata dal’Riu Magomadas e limitata, sul lato orientale, da un sistema di colline. Sopra il colle si trovano pochi resti del nuraghe Pardu, che fa parte del comune di Nureci dal quale dista in linea d’aria circa un chilometro. Si tratta di un nuraghe non classificato, edificato in materiale indeterminato a 389 metri di altezza. La presenza di un insediamento nuragico nella località è documentato dalla numerosa ceramica d’impasto che è stata rinvenuta, tra cui un frammento di ansa a gomito rovescio, probabilmente della prima età del Ferro. Nel territorio sono presenti anche pochi resti del Centro punico di Magom-hadash, che parrebbe articolarsi in un’acropoli, localizzata nel settore settentrionale del pianoro, ed in un abitato che si estende ad ovest e a sud, con la necropoli che potrebbe situarsi a nord ovest. Sono presenti anche i resti della successiva presenza romana durante l’età tardo repubblicana e al successivo periodo imperiale.
Il giacimento fossilifero di Muru 'e Cubeddu
 Da dove, con la via San Sebastiano, eravamo arrivati sulla SS442 di Laconi e di Uras, prendiamo quest'ultima verso sinistra ossia in direzione sud. Percorsi circa cinquecento metri, vediamo alla destra della strada la Collinetta di Muru 'e Cubeddu, alla pendici della quale è stato portato alla luce l’importante giacimento fossilifero di Muru 'e Cubeddu, situato alla periferia occidentale del paese.
Da dove, con la via San Sebastiano, eravamo arrivati sulla SS442 di Laconi e di Uras, prendiamo quest'ultima verso sinistra ossia in direzione sud. Percorsi circa cinquecento metri, vediamo alla destra della strada la Collinetta di Muru 'e Cubeddu, alla pendici della quale è stato portato alla luce l’importante giacimento fossilifero di Muru 'e Cubeddu, situato alla periferia occidentale del paese.  Alle pendici di questa collinetta affiorano, infatti, rocce sedimentarie di ambiente marino risalenti al’Miocene, che interessano una fascia temporale tra i quattordici ed i ventinque milioni di anni, e che documentano in modo esemplare gli eventi geologici e paleontologici che hanno interessato il Sarcidano e la Marmilla, e quindi buona parte della Sardegna centro meridionale. Il contenuto fossilifero in alcuni tratti è straordinariamente abbondante ed è rappresentato da un’associazione ad alghe, molluschi, echinidi ossia ricci di mare, crinoidi, briozoi e pesci. I molluschi in particolare sono presenti con un gran numero di specie ed un elevatissimo numero di individui, e sono disposti in modo tale che il corpo roccioso che ne è interessato ha l’aspetto di un deposito organogeno conchigliare. Questi depositi marini hanno un ruolo di riferimento di primaria importanza nell’ambito dello studio dei tempi di deposizione ossia della stratigrafia, con pochi eguali in ambito nazionale e sopranazionale.
Alle pendici di questa collinetta affiorano, infatti, rocce sedimentarie di ambiente marino risalenti al’Miocene, che interessano una fascia temporale tra i quattordici ed i ventinque milioni di anni, e che documentano in modo esemplare gli eventi geologici e paleontologici che hanno interessato il Sarcidano e la Marmilla, e quindi buona parte della Sardegna centro meridionale. Il contenuto fossilifero in alcuni tratti è straordinariamente abbondante ed è rappresentato da un’associazione ad alghe, molluschi, echinidi ossia ricci di mare, crinoidi, briozoi e pesci. I molluschi in particolare sono presenti con un gran numero di specie ed un elevatissimo numero di individui, e sono disposti in modo tale che il corpo roccioso che ne è interessato ha l’aspetto di un deposito organogeno conchigliare. Questi depositi marini hanno un ruolo di riferimento di primaria importanza nell’ambito dello studio dei tempi di deposizione ossia della stratigrafia, con pochi eguali in ambito nazionale e sopranazionale.
In tal senso il Muru Cubeddu deve essere considerato un geosito di rilevante importanza, degno di essere tutelato e valorizzato per una fruizione collettiva. Il sito, istituito come Monumento Naturale ai sensi della Legge Regionale 31/89, è stato inaugurato diversi anni fa, ma non è purtroppo finora valorizzato.
Il Cimitero Comunale di Nureci
 A sud dell’abitato si trova il Cimitero Comunale di Nureci. Per raggiungerlo dal’Municipio di Nureci prendiamo, verso la via della Parrocchia ossia in direzione sud ovest, la via Ungheria la quale, dopo duecentocinquanta metri, incrocia la via San Sebastiano. Superiamo l’incrocio e proseguiamo dritti con la via Ungheria uscendo dall’abitato in direzione sud, con la strada che assumerà il nome di SP79. Dopo aver percorso circa centocinquanta metri dall’incorcio con la via San Sebastiano, vediamo alla sinistra della strada sopra un’altura il muro di cinta con il cancello di ingresso del Cimitero Comunale, realizzato per sostituire dopo la metà dell’Ottocento il Cimitero Vecchio, che era presente all’interno dell’abitato.
A sud dell’abitato si trova il Cimitero Comunale di Nureci. Per raggiungerlo dal’Municipio di Nureci prendiamo, verso la via della Parrocchia ossia in direzione sud ovest, la via Ungheria la quale, dopo duecentocinquanta metri, incrocia la via San Sebastiano. Superiamo l’incrocio e proseguiamo dritti con la via Ungheria uscendo dall’abitato in direzione sud, con la strada che assumerà il nome di SP79. Dopo aver percorso circa centocinquanta metri dall’incorcio con la via San Sebastiano, vediamo alla sinistra della strada sopra un’altura il muro di cinta con il cancello di ingresso del Cimitero Comunale, realizzato per sostituire dopo la metà dell’Ottocento il Cimitero Vecchio, che era presente all’interno dell’abitato.
Ci rechiamo dove un tempo esisteva l’insediamento medioevale di Genadas
 Fuori dal centro abitato troviamo la chiesa campestre della Madonna d’Itria. Passato il Cimitero Comunale proseguiamo lungo la SP79 per circa un chilometro e trecento metri, finché questa strada sbocca sulla SP41. Prendiamo la SP41 verso destra e, dopo centottanta metri, svoltiamo tutto a sinistra, nella strada che porta nel territorio dove un tempo esisteva l’insediamento medioevale di Genadas. La prima attestazione relativa a questo insediamento risale al pagamento delle decime ecclesiastiche dovute nel 1341 da Gonario Serra, rettore della Ecclesia Santi Georgi di Villa Gonare. Tra il 1346 ed il 1350 il rettore di Genadis mantiene anche la cappellania di Dorsolo, forse da identificarsi con l’attuale Assolo. Nel 1388 Genadas è rappresentata dal proprio majore che, con altri nove abitanti, presenziano alla stipula di pace tra Eleonora d’Arborea e Giovanni d’Aragona. Nel 1479 l’insediamento, che risulta abbandonato, viene assegnato ad Enrico de Enriquez. L’ultimo atto segnalato è l’investitura del feudo in favore di Ludovico d’Erill, datato 1494 e che conferma lo spopolamento del villaggio a causa dei continui saccheggi da parte di bande di malviventi, che costringono l’inerme popolazione a trasferirsi nel vicino villaggio di Nureci. Scrive a tale proposito Vittorio Angius: «Era questa di Genadas un’antica popolazione, la quale per le continue vessazioni che pativa dalle masnade di malviventi, che saccheggiavano le case e si portavano via le fanciulle, lasci l’antica sede sulla gran via, e andò in Nureci non già fondando il paese ma ingrandendolo».
Fuori dal centro abitato troviamo la chiesa campestre della Madonna d’Itria. Passato il Cimitero Comunale proseguiamo lungo la SP79 per circa un chilometro e trecento metri, finché questa strada sbocca sulla SP41. Prendiamo la SP41 verso destra e, dopo centottanta metri, svoltiamo tutto a sinistra, nella strada che porta nel territorio dove un tempo esisteva l’insediamento medioevale di Genadas. La prima attestazione relativa a questo insediamento risale al pagamento delle decime ecclesiastiche dovute nel 1341 da Gonario Serra, rettore della Ecclesia Santi Georgi di Villa Gonare. Tra il 1346 ed il 1350 il rettore di Genadis mantiene anche la cappellania di Dorsolo, forse da identificarsi con l’attuale Assolo. Nel 1388 Genadas è rappresentata dal proprio majore che, con altri nove abitanti, presenziano alla stipula di pace tra Eleonora d’Arborea e Giovanni d’Aragona. Nel 1479 l’insediamento, che risulta abbandonato, viene assegnato ad Enrico de Enriquez. L’ultimo atto segnalato è l’investitura del feudo in favore di Ludovico d’Erill, datato 1494 e che conferma lo spopolamento del villaggio a causa dei continui saccheggi da parte di bande di malviventi, che costringono l’inerme popolazione a trasferirsi nel vicino villaggio di Nureci. Scrive a tale proposito Vittorio Angius: «Era questa di Genadas un’antica popolazione, la quale per le continue vessazioni che pativa dalle masnade di malviventi, che saccheggiavano le case e si portavano via le fanciulle, lasci l’antica sede sulla gran via, e andò in Nureci non già fondando il paese ma ingrandendolo».
La chiesa della villa medievale, pertinente alla diocesi arborense, era dedicata a San Giorgio. Se il San Giorgio al quale era dedicata fosse stato il vescovo di Suelli, si potrenne datere la fabbrica a partire dal dodicesimo secolo. Se invece l’intitolazione fosse a San Giorgio Martire, potrebbe riportare all’epoca bizantina e ciò non sarebbe da escludere, considerati i ritrovamenti funerari altomedievali in aree non distanti. Ora non vi è più traccia della chiesa di San Giorgio, che era ancora documentata in un elenco dei luoghi di culto della diocesi di Oristano, stilato nella seconda metà del Settecento.
La chiesa campestre della Madonna d’Itria
Presa la SP41 verso destra, dopo centottanta metri svoltiamo tutto a sinistra, nella strada che porta nel territorio dove un tempo esisteva l’insediamento medioevale di Genadas. Percorsi centotrenta metri, svoltiamo a sinistra e, dopo trecentocinquanta metri, raggiungiamo la piccola Chiesa campestre della Madonna d’Itria, ricostruita nei primi del Novecento su un impianto originario che molto probabilmente risaliva al seicento e che si trova dove un tempo sorgeva il paesetto di Genadas, oggi scomparso. Questa chiesa campestre è stata significativamente restaurata nel 1930.
Il nome della chiesa dedicata a questa Madonna suona propriamente Nostra Signora de Ittiri, e questa pronunzia non soltanto è indicata da qualche vecchia carta geografica, ma viene tuttora ricordata dai vecchi della zona.
Il nome d’Itria è la contrazione di Odigitria, parola che significa Mostra la Via, ossia colei che conduce mostrando la direzione. Veniva così chiamato il tempio che si trovava a Costantinopoli, eretto per custodire ed onorare un quadro che raffigurava la Madonna dipinto da San Luca Evangelista. Non si sa come la venerazione della Madonna d’Itria sia giunta in Sardegna, ma si ritiene che il suo culto possa risalire al periodo dell’attività della tonnara di Portoscuso, ed è attestato fino dal 1630. Un quadro raffigurante la Madonna d’Itria, secondo una tradizione popolare, sarebbe stato portato nella chiesa della tonnara di Portoscuso dove, durante un’incursione saracena, venne colpito da alcuni proietili. Dopo molti anni, il proprietario della tonnara lo portò a Genova per farlo restaurare, ma da dove il quadro non fece più ritorno a Portoscuso, ed in sua sostituzione, vi venne portato il simulacro che riproduceva la Santa. |
 Presso la chiesa campestre della Madonna d’Itria, il martedì dopo la domenica di Pentecoste, si svolge la festa della Madonna d’Itria, che è una festa religiosa organizzata da un comitato spontaneo, fra fede, tradizioni e spettacoli in piazza. Il lunedì la Madonna viene condotta in processionesu un carro a buoi dalla chiesa parrocchiale di Nureci fino alla sua chiesa campestre, accompagnata da gruppi folkloristici festanti e dai cavalieri. Il martedì si svolgono festeggiamenti religiosi e civili, che si concludono quando il simulacro della Vergine viene riaccompagnato in una grande processione nel paese, seguita dalla Santa messa nella chiesa parrocchiale di Nureci animata da un coro polifonico.
Presso la chiesa campestre della Madonna d’Itria, il martedì dopo la domenica di Pentecoste, si svolge la festa della Madonna d’Itria, che è una festa religiosa organizzata da un comitato spontaneo, fra fede, tradizioni e spettacoli in piazza. Il lunedì la Madonna viene condotta in processionesu un carro a buoi dalla chiesa parrocchiale di Nureci fino alla sua chiesa campestre, accompagnata da gruppi folkloristici festanti e dai cavalieri. Il martedì si svolgono festeggiamenti religiosi e civili, che si concludono quando il simulacro della Vergine viene riaccompagnato in una grande processione nel paese, seguita dalla Santa messa nella chiesa parrocchiale di Nureci animata da un coro polifonico.
Il recinto megalitico di Sa Corona ’e Su Crobu
 Dal’Municipio di Nureci prendiamo verso la chiesa parrocchiale, ossia in direzione nord est, la via Ungheria che, dopo quattrocentocinquanta metri, incrocia la via dei Giardini che proviene da sinistra. Prendiamo verso destra la prosecuzione della via dei Giardini passando accanto al’Parco Briaxiu, il piccolo parco Comunale all’interno del quale si trova il Campo da Calcetto ossia da Calcio a cinque di Nureci, e la seguiamo per seicentocinquanta metri, fino ad arrivare all’area attrezzata di Sa Corona ’e Su Crobu. Proprio sopra il paese, sul ciglio dello strapiombo granitico, si trova il magnifico, e per alcuni versi misterioso, recinto megalitico di Sa Corona ’e Su Crobu, ossia Il macigno del corvo, che si trova nel versante del Monte Maiore che si affaccia sulla fertile vallata del rio Pardu ed include un dirupo di rocce granitiche che sovrasta verso est l’abitato di Nureci, a una quota di 400 metri. L’altezza residua della struttura fatta di enormi massi di granito, con all’interno strutture secondarie anch’esse di massi di granito, e con all’interno strutture secondarie di massi più piccoli, è di circa tre metri. La costruzione si innesta sull’imponente emergenza rocciosa, e costituisce un complesso le cui dimensioni massime raggiungono quasi una cinquantina di metri sull’asse da nord a sud, e poco più di una trentina di metri sull’asse da est ad ovest. Il complesso è delimitato su tre lati da una poderosa cinta muraria, mentre sul lato ad ovest delimitato da un inaccessibile dirupo naturale con rocce a strapiombo. L’accesso all’interno del recinto avveniva tramite due aperture laterali, ora ostruite da materiale di crollo. Agli inizi del Novecento l’apertura ubicata nel lato settentrionale era ancora ben conservata ed era dotata in sommità di un architrave. Il lato meridionale con andamento irregolare, mostra il secondo ingresso. Entrambi gli ingressi sono seguiti da un corridoio interno in muratura. I pochi dati a disposizione non agevolano la datazione certa del monumento.
Dal’Municipio di Nureci prendiamo verso la chiesa parrocchiale, ossia in direzione nord est, la via Ungheria che, dopo quattrocentocinquanta metri, incrocia la via dei Giardini che proviene da sinistra. Prendiamo verso destra la prosecuzione della via dei Giardini passando accanto al’Parco Briaxiu, il piccolo parco Comunale all’interno del quale si trova il Campo da Calcetto ossia da Calcio a cinque di Nureci, e la seguiamo per seicentocinquanta metri, fino ad arrivare all’area attrezzata di Sa Corona ’e Su Crobu. Proprio sopra il paese, sul ciglio dello strapiombo granitico, si trova il magnifico, e per alcuni versi misterioso, recinto megalitico di Sa Corona ’e Su Crobu, ossia Il macigno del corvo, che si trova nel versante del Monte Maiore che si affaccia sulla fertile vallata del rio Pardu ed include un dirupo di rocce granitiche che sovrasta verso est l’abitato di Nureci, a una quota di 400 metri. L’altezza residua della struttura fatta di enormi massi di granito, con all’interno strutture secondarie anch’esse di massi di granito, e con all’interno strutture secondarie di massi più piccoli, è di circa tre metri. La costruzione si innesta sull’imponente emergenza rocciosa, e costituisce un complesso le cui dimensioni massime raggiungono quasi una cinquantina di metri sull’asse da nord a sud, e poco più di una trentina di metri sull’asse da est ad ovest. Il complesso è delimitato su tre lati da una poderosa cinta muraria, mentre sul lato ad ovest delimitato da un inaccessibile dirupo naturale con rocce a strapiombo. L’accesso all’interno del recinto avveniva tramite due aperture laterali, ora ostruite da materiale di crollo. Agli inizi del Novecento l’apertura ubicata nel lato settentrionale era ancora ben conservata ed era dotata in sommità di un architrave. Il lato meridionale con andamento irregolare, mostra il secondo ingresso. Entrambi gli ingressi sono seguiti da un corridoio interno in muratura. I pochi dati a disposizione non agevolano la datazione certa del monumento.
L’archeologo Torquato Taramelli nel 1907 ha attribuito la sua edificazione ad epoca preistorica, intuita dalla presenza di resti di ossidiana e ceramiche d’impasto, e gli attribuiva una funzione difensiva supportata in seguito anche da Giovanni Lilliu. Secondo questa teoria interpretativa, basata sull’esame della tecnica costruttiva di tipo ciclopica, la struttura sarebbe assimilabile ad altre muraglie fortificate come quella di Monte Baranta ad Olmedo e di Monte Ossoni a Castelsardo, riconducibili quindi all’età dei primi metalli. Però in seguito Giovanni Lilliu, nel 1985, ha rettificato questa interpretazione a favore di quella di una fortezza di epoca punica. Tale valutazione deriva da considerazioni topografiche, correlate ad un sistema di controllo del territorio di cui farebbero anche parte il forte Santu Antine di Genoni e il forte Stantu Juanni di Asuni, poco distanti da questa fortezza. I pochi dati a disposizione non agevolano comunque la datazione certa del monumento.
Nel recinto megalitico un masso granitico che viene interpretato come una delle prime rappresentazioni della Dea Mater Mediterranea
 Ultimamente il sito ha suscitato notevole interesse presso gli studiosi del megalitismo, i quali danno l’interpretazione di un imponente masso granitico posto in posizione baricentrica nell’area interna della cinta muraria, che identificherebbe le fattezze stilizzate nelle linee essenziali, di una delle prime rappresentazioni della Dea Mater Mediterranea, divinità comunemente adorata da tutte le popolazioni mediterranee. Non si tratta solo di una pietra qualunque, corrosa e levigata dal tempo, nella quale alcune parti sono mancanti, ma se si osserva la pietra nella sua completezza si possono ritrovare, in maniera molto evidente, tutte le caratteristiche proprie della Dea Madre. Si riconoscono rnolto bene il ventre prominente, i seni gonfi, le cosce abbondanti. La testa piccola, proprio come nelle raffigurazioni di epoca neolitica antica. Mentre dal punto di vista stilistico vaghi confronti intuibili con statuine muliebri trovate in Europa in giacimenti neolitici, sembrerebbero poter indicare un’attribuzione del masso a tale periodo, altri particolari tipologici e soprattutto il contesto del rinvenimento - una particolare struttura con clementi collegabili a pratiche di culto - rendono più che plausibile il suo paragone con le numerose statuine femminili trovate nei cosiddetti santuari dell’area rnediterranea. Si potrebbe supporre, dunque, che questa sia effettivamente una raffigurazione antica della Dea Madre, appartenente al Neolitico, essendo il luogo legato a culti ancestrali.
Ultimamente il sito ha suscitato notevole interesse presso gli studiosi del megalitismo, i quali danno l’interpretazione di un imponente masso granitico posto in posizione baricentrica nell’area interna della cinta muraria, che identificherebbe le fattezze stilizzate nelle linee essenziali, di una delle prime rappresentazioni della Dea Mater Mediterranea, divinità comunemente adorata da tutte le popolazioni mediterranee. Non si tratta solo di una pietra qualunque, corrosa e levigata dal tempo, nella quale alcune parti sono mancanti, ma se si osserva la pietra nella sua completezza si possono ritrovare, in maniera molto evidente, tutte le caratteristiche proprie della Dea Madre. Si riconoscono rnolto bene il ventre prominente, i seni gonfi, le cosce abbondanti. La testa piccola, proprio come nelle raffigurazioni di epoca neolitica antica. Mentre dal punto di vista stilistico vaghi confronti intuibili con statuine muliebri trovate in Europa in giacimenti neolitici, sembrerebbero poter indicare un’attribuzione del masso a tale periodo, altri particolari tipologici e soprattutto il contesto del rinvenimento - una particolare struttura con clementi collegabili a pratiche di culto - rendono più che plausibile il suo paragone con le numerose statuine femminili trovate nei cosiddetti santuari dell’area rnediterranea. Si potrebbe supporre, dunque, che questa sia effettivamente una raffigurazione antica della Dea Madre, appartenente al Neolitico, essendo il luogo legato a culti ancestrali.
Ci rechiamo verso il Sarcidano
Da Nureci la SS442 ci porta verso est e ci fa raggiungere la regione storica della Sardegna denominata Sarcidano, la quale si sviluppa tra la Provincia di Oristano e quella del Sud Sardegna.
La prossima tappa del nostro viaggio
Nella prossima tappa del nostro viaggio, da Nureci ci recheremo nel’Sarcidano per visitare Laconi dove è nato Sant’Ignazio, che visiteremo con il suo centro dove si trovano il palazzo Aymeriché ed il Museo Archeologico delle Statue menhir, con il parco Aymeriché ed i dintorni nei quali sono state rinvenute le numerose statue tra le quali anche quelle oggi ospitate nel’Museo.
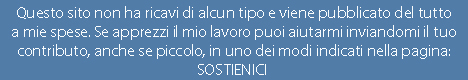
Tutte le foto e riprese sono state effettuate a scopo amatoriale per uso personale senza fini di lucro. Alle nostre foto se ne aggiungono altre inviateci da amici ed alcune tratte da Internet. Alcune informazioni sulle descrizioni dei comuni sono tratte da italiapedia.it, informazioni sui siti archeologici da tharros.info e molte foto da donnanuragica.com, descrizoni e foto di Chiese da Chiesedisardegna.weebly.com, foto di impianti sportivi da sardegnasport.it, altre da siti differenti. È consentito scaricare testi, foto e riprese dell’autore per uso privato senza eliminare i riferimenti. Libri e filmati sono riprodotti per farli conoscere ma non è consentita la riproduzione delle foto di terzi, dei libri, dei filmati e di altro materiale non realizzato dall’autore. È vietato qualsiasi utilizzo commerciale del materiale in assenza di apposita autorizzazione. |
© Claudio de Tisi 2002-2023 - Codice Fiscale DTSCLD44M23F132W


























































