Un sito di oltre 450 pagine che descrive tutta l’Isola e che pur non vendendo niente riceve da 300 a oltre 1400 visitatori ogni giorno

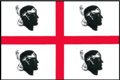

Sant’Antioco, l’antica Sulci dove sopravvive l’arte di tessere il bisso, con il Tophet fenicio e la necropoli punica
Inizieremo ora la visita dell’isola di Sant’Antioco, che effettueremo in tre tappe. In questa prima tappa visiteremo il paese di Sant’Antioco e vedremo anche gli importanti resti archeologici presenti all’interno dell’abitato. Nella successiva tappa vedremo i resti del periodo nuragico e soprattutto del periodo fenicio punico nell’isola di Sant’Antioco, ed effettureremo la visita di tutte le coste dell’isola con le diverse cale e le sue diverse spiagge. Nella terza tappa ci recheremo a Calasetta, il secondo paese dell’isola, che vedremo con il suo centro abitato e con le sue spiagge.
Il Sulcis nella regione storica del Sulcis-Iglesiente
 L’area della regione storica del Sulcis-Iglesiente si estende a nord della valle del Cixerri. Confina a nord est con il Campidano ed ha una forma vagamente triangolare. Il Sulcis (nome in lingua sarda Sa Meurreddìa) si estende nella porzione sudoccidentale dell’isola, parte integrante della regione storica del Sulcis-Iglesiente, ed appartiene alla Provincia del Sud Sardegna ed a quella di Cagliari. I suoi comuni nella Provincia del Sud Sardegna sono Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domus de Maria, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Santadi, Siliqua, Teulada, Tratalias, Villamassargia e Villaperuccio. Quelli nella città Metropolitana di Cagliari sono Pula, Sarroché e Villa San Pietro, che si trovano però tra il Sulcis ed il Campidano di Cagliari, per cui possono essere considerate appartenenti all’una o all’altra di queste regioni. È un territorio in cui la natura è incontaminata, nel tratto costiero caratterizzato da ampie spiagge, tra cui spicca Piscinas, con le sue metafisiche dune di sabbia, o la splendida insenatura di Masua, che guarda il faraglione calcareo di Pan di Zucchero.
L’area della regione storica del Sulcis-Iglesiente si estende a nord della valle del Cixerri. Confina a nord est con il Campidano ed ha una forma vagamente triangolare. Il Sulcis (nome in lingua sarda Sa Meurreddìa) si estende nella porzione sudoccidentale dell’isola, parte integrante della regione storica del Sulcis-Iglesiente, ed appartiene alla Provincia del Sud Sardegna ed a quella di Cagliari. I suoi comuni nella Provincia del Sud Sardegna sono Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domus de Maria, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Santadi, Siliqua, Teulada, Tratalias, Villamassargia e Villaperuccio. Quelli nella città Metropolitana di Cagliari sono Pula, Sarroché e Villa San Pietro, che si trovano però tra il Sulcis ed il Campidano di Cagliari, per cui possono essere considerate appartenenti all’una o all’altra di queste regioni. È un territorio in cui la natura è incontaminata, nel tratto costiero caratterizzato da ampie spiagge, tra cui spicca Piscinas, con le sue metafisiche dune di sabbia, o la splendida insenatura di Masua, che guarda il faraglione calcareo di Pan di Zucchero.
Da San Giovanni Suergiu la SS126 Sud Occidentale Sarda ci porta sull’isola di Sant’Antioco
Da San Giovanni Suergiu proseguiamo verso sud lungo la SS126 Sud Occidentale Sarda fino a raggiungere, dopo circa nove chilometri e mezzo, l’isola di Sant’Antioco. Arriviamo sull’isola attraverso uno stretto istmo, lungo cinque chilometri, che collega l’isola di Sant’Antioco all’isola madre. L’isola di Sant’Antioco si estende per 109 chilometri quadrati. È la quarta isola d’Italia come dimensione dopo Sicilia, Sardegna ed Elba. Ha due soli centri abitati, il paese di Sant’Antioco e il paese chiamato Calasetta, oltre all’importante complesso turistico di Maladroxia.
La ex centrale Termoelettrica di Santa Caterina
 A quasi quattro chilometri verso sud ovest con la SS126 Sud Occidentale Sarda da San Giovanni Suergiu, troviamo sulla destra della strada le indicazioni che conducono alla Centrale di Santa Caterina una grande centrale Termoelettrica ormai dismessa. Si tratta di uno dei principali monumenti di archeologia industriale del Sulcis, entrata in funzione nel 1939. Si deve la sua nascita all’ingegner Angelo Omodeo che nel 1911 fonda la Società Elettrica Sarda, e nel 1913 la Società Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso, la quale si occuperà delle opere idrauliche su Tirso e Coghinas. Scopo delle aziende, sviluppare la produzione di energia elettrica per lo sviluppo industriale e sociale dell’isola. L’impianto, il primo in Italia idoneo ad utilizzare il carbone del Sulcis polverizzato, utilizzava dei generatori di vapore per produrre l’energia elettrica. L’alimentazione del carbone avveniva mediante un sistema di rotaie su cui scorrevano i carri tramoggia che convogliavano il minerale a due mulini atti alla sua macinazione. Negli anni della seconda guerra mondiale ha assicurato la vitale fornitura elettrica non solo al complesso industriale del bacino carbonifero ma anche all’area metropolitana di Cagliari attraverso un articolato collegamento in rete. Nel settembre del 1943 i soldati tedeschi in ritirata hanno asportato il 4° gruppo turbo-alternatore. Il macchinario sarà poi parzialmente recuperato in Germania al termine del conflitto e rimesso successivamente in opera. Una quinta caldaia è stata attrezzata dopo il 1950 in virtù degli aiuti statunitensi del Piano Marshall. La centrale ha cessato il servizio nel 1963 chiudendo definitivamente nel 1965.
A quasi quattro chilometri verso sud ovest con la SS126 Sud Occidentale Sarda da San Giovanni Suergiu, troviamo sulla destra della strada le indicazioni che conducono alla Centrale di Santa Caterina una grande centrale Termoelettrica ormai dismessa. Si tratta di uno dei principali monumenti di archeologia industriale del Sulcis, entrata in funzione nel 1939. Si deve la sua nascita all’ingegner Angelo Omodeo che nel 1911 fonda la Società Elettrica Sarda, e nel 1913 la Società Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso, la quale si occuperà delle opere idrauliche su Tirso e Coghinas. Scopo delle aziende, sviluppare la produzione di energia elettrica per lo sviluppo industriale e sociale dell’isola. L’impianto, il primo in Italia idoneo ad utilizzare il carbone del Sulcis polverizzato, utilizzava dei generatori di vapore per produrre l’energia elettrica. L’alimentazione del carbone avveniva mediante un sistema di rotaie su cui scorrevano i carri tramoggia che convogliavano il minerale a due mulini atti alla sua macinazione. Negli anni della seconda guerra mondiale ha assicurato la vitale fornitura elettrica non solo al complesso industriale del bacino carbonifero ma anche all’area metropolitana di Cagliari attraverso un articolato collegamento in rete. Nel settembre del 1943 i soldati tedeschi in ritirata hanno asportato il 4° gruppo turbo-alternatore. Il macchinario sarà poi parzialmente recuperato in Germania al termine del conflitto e rimesso successivamente in opera. Una quinta caldaia è stata attrezzata dopo il 1950 in virtù degli aiuti statunitensi del Piano Marshall. La centrale ha cessato il servizio nel 1963 chiudendo definitivamente nel 1965.
Dopo la sua dismissione, negli ultimi anni si è acceso il dibattito attorno alla sua destinazione definitiva, tuttavia una soluzione non è stata ancora individuata. Nel corso dei decenni sono stati presentati diversi progetti, non legati al campo dell’industria, per una possibile riqualificazione dell’area, ma i fondi necessari alla sistemazione del complesso frenano gli entusiasmi. Intanto, la struttura resta affacciata, su quella laguna a cui porta anche un certo risalto, pregna della sua fama e del suo fascino storico, sempre pronta a farsi ammirare dal visitatore di passaggio così come dall’appassionato di edifici storici abbandonati.
La frazione Is Loddis
 Percorso poco più di un chilometro lungo la SS126 Sud Occidentale Sarda, si trova, alla sinistra della strada, la strada che conduce alla frazione Is Loddis (altezza metri 1, distanza in linea d’aria 3.10 chilometri dal comune di Sant’Antioco di cui fa parte, abitanti circa 48), chiamata Is Loddis nelle carte IGM, Is Loddus nella segnaletica stradale presente sul posto, ed indicata a volte come Santa Caterina. Passata questa frazione del comune di Sant’Antioco, sulla sinistra vediamo il grande stagno laguna di Santa Caterina, a est della quale si trova la Salina di Stato di Sant’Antioco, ed un poco più avanti troveremo il mare aperto, mentre sulla destra dell’istmo vediamo il mare aperto verso nord ovest, e sullo sfondo si vede il paese di Sant’Antioco.
Percorso poco più di un chilometro lungo la SS126 Sud Occidentale Sarda, si trova, alla sinistra della strada, la strada che conduce alla frazione Is Loddis (altezza metri 1, distanza in linea d’aria 3.10 chilometri dal comune di Sant’Antioco di cui fa parte, abitanti circa 48), chiamata Is Loddis nelle carte IGM, Is Loddus nella segnaletica stradale presente sul posto, ed indicata a volte come Santa Caterina. Passata questa frazione del comune di Sant’Antioco, sulla sinistra vediamo il grande stagno laguna di Santa Caterina, a est della quale si trova la Salina di Stato di Sant’Antioco, ed un poco più avanti troveremo il mare aperto, mentre sulla destra dell’istmo vediamo il mare aperto verso nord ovest, e sullo sfondo si vede il paese di Sant’Antioco.
Passata la frazione vediamo sulla sinistra lo stagno di Santa Caterina e la salina di Stato di Sant’Antioco
 Lo stagno laguna di Santa Caterina e la salina di Stato di Sant’Antioco costituiscono un sistema lagunare e stagnale legato all’emersione di barre sabbiose, che costituivano una zona umida di grande interesse. Lo stagno laguna di Santa Caterina ha una superficie di 690 ettari, e la sua profondità massima si aggira intorno ai due metri, mentre gli apporti idrici da parte dei corsi d’acqua sono assicurati dal rio Palmas, dal rio Sassu e dai numerosi canali di bonifica che costituiscono una fitta rete di drenaggio intorno alla zona. La zona è stata, però, fortemente condizionata dall’intervento dell’uomo, legato all’impianto delle saline, che si è manifestato attraverso la costruzione di argini provvisti di chiuse, che delimitano le vasche evaporanti e le caselle salanti.
Lo stagno laguna di Santa Caterina e la salina di Stato di Sant’Antioco costituiscono un sistema lagunare e stagnale legato all’emersione di barre sabbiose, che costituivano una zona umida di grande interesse. Lo stagno laguna di Santa Caterina ha una superficie di 690 ettari, e la sua profondità massima si aggira intorno ai due metri, mentre gli apporti idrici da parte dei corsi d’acqua sono assicurati dal rio Palmas, dal rio Sassu e dai numerosi canali di bonifica che costituiscono una fitta rete di drenaggio intorno alla zona. La zona è stata, però, fortemente condizionata dall’intervento dell’uomo, legato all’impianto delle saline, che si è manifestato attraverso la costruzione di argini provvisti di chiuse, che delimitano le vasche evaporanti e le caselle salanti.
 All’interno dello stagno laguna si trovano quattro isolotti, ossia a nord est la piccola Isola de Sa Scruidda, più a sud ovest l’Isola Manna, a sud rispetto a questa l’Isola Porcu ’e Scriba, poi ancora a sud ovest l’Isola Gruccianas. La parte meridionale dell’area dello stagno laguna era stata adibita a peschiera, costituendo la Peschiera di Palmas, che un tempo comprendeva tutta la laguna. La sua produttività è stata, però, notevolmente ridotta a causa dell’inquinamento determinato dagli scarichi urbani ed agricoli, ed inoltre tutta l’area lagunare è interessata da una fitta rete di strade che alterano profondamente l’assetto naturale della laguna. Oggi, nello stagno laguna non viene esercitata l’attività di pesca in quanto le acque ipersaline sono proibitive per la popolazione ittica.
All’interno dello stagno laguna si trovano quattro isolotti, ossia a nord est la piccola Isola de Sa Scruidda, più a sud ovest l’Isola Manna, a sud rispetto a questa l’Isola Porcu ’e Scriba, poi ancora a sud ovest l’Isola Gruccianas. La parte meridionale dell’area dello stagno laguna era stata adibita a peschiera, costituendo la Peschiera di Palmas, che un tempo comprendeva tutta la laguna. La sua produttività è stata, però, notevolmente ridotta a causa dell’inquinamento determinato dagli scarichi urbani ed agricoli, ed inoltre tutta l’area lagunare è interessata da una fitta rete di strade che alterano profondamente l’assetto naturale della laguna. Oggi, nello stagno laguna non viene esercitata l’attività di pesca in quanto le acque ipersaline sono proibitive per la popolazione ittica.
La salina di Stato di Sant’Antioco
 La salina di Stato di Sant’Antioco si estende su una fascia pericostiera lunga circa venti chilometri, per una profondità massima di circa tre chilometri, in località Is Cortiois. Realizzata nei primi anni sessanta del Novecento mediante opere di regimazione e collegamento di lagune costiere esistenti, è entrata in produzione nel finire dello stesso decennio. La salina comprende 1.300 ettari di zona evaporante, la cui funzione produttiva consiste nel portare le acque di mare a saturazione, e 200 ettari di zona salante, nella quale si ha la precipitazione del cloruro di sodio. Il movimento delle acque a ciclo continuo viene realizzato sfruttando per la maggior parte della superficie il dislivello naturale del terreno, ed ove ciò non è possibile provvedono sei stazioni idrovore di sollevamento dislocate in diverse zone della salina. Il periodo più favorevole alla produzione va da maggio a settembre, e le operazioni di pompaggio hanno inizio quando le evaporazioni prendono il netto sopravvento sulle piogge. Durante il restante periodo dell’anno l’attività produttiva è tesa alla conservazione delle caratteristiche delle acque presenti nelle diverse zone evaporanti. Le caratteristiche di questi importantissimi siti, costituiscono uno straordinario habitat soprattutto per la sosta e lo svernamento dei limicoli, di spatole, gru, aironi bianchi maggiori e di piccoli gruppi di oche, per i nidificanti abituali quali il cavaliere d’Italia, l’avoceta, il fratino, il fraticello, la sterna zampenere, la pernice di mare, il gabbiano roseo ed il gabbiano corallino, anatre di varie specie oltre al famoso fenicottero rosa che, ormai costantemente al di sopra del migliaio di individui, rappresenta proprio nella salina una delle più importanti popolazioni europee di questa specie.
La salina di Stato di Sant’Antioco si estende su una fascia pericostiera lunga circa venti chilometri, per una profondità massima di circa tre chilometri, in località Is Cortiois. Realizzata nei primi anni sessanta del Novecento mediante opere di regimazione e collegamento di lagune costiere esistenti, è entrata in produzione nel finire dello stesso decennio. La salina comprende 1.300 ettari di zona evaporante, la cui funzione produttiva consiste nel portare le acque di mare a saturazione, e 200 ettari di zona salante, nella quale si ha la precipitazione del cloruro di sodio. Il movimento delle acque a ciclo continuo viene realizzato sfruttando per la maggior parte della superficie il dislivello naturale del terreno, ed ove ciò non è possibile provvedono sei stazioni idrovore di sollevamento dislocate in diverse zone della salina. Il periodo più favorevole alla produzione va da maggio a settembre, e le operazioni di pompaggio hanno inizio quando le evaporazioni prendono il netto sopravvento sulle piogge. Durante il restante periodo dell’anno l’attività produttiva è tesa alla conservazione delle caratteristiche delle acque presenti nelle diverse zone evaporanti. Le caratteristiche di questi importantissimi siti, costituiscono uno straordinario habitat soprattutto per la sosta e lo svernamento dei limicoli, di spatole, gru, aironi bianchi maggiori e di piccoli gruppi di oche, per i nidificanti abituali quali il cavaliere d’Italia, l’avoceta, il fratino, il fraticello, la sterna zampenere, la pernice di mare, il gabbiano roseo ed il gabbiano corallino, anatre di varie specie oltre al famoso fenicottero rosa che, ormai costantemente al di sopra del migliaio di individui, rappresenta proprio nella salina una delle più importanti popolazioni europee di questa specie.
I menhir Su Para e Sa Mongia
 Proseguendo lungo la strada statale, possiamo vedere i primi segni dell’antica frequentazione umana a Sant’Antioco, ossia due menhir aniconici presumibilmente risalenti all’Eneolitico. Li incontriamo percorrendo la SS126 Sud Occidentale Sarda, al chilometro 3, cinquecento metri dopo la deviazione per la frazione Is Loddis, vicino allo stagno di Santa Caterina, sull’istmo che dall’isola madre porta a Sant’Antioco, a pochi metri dalla ferrovia sulla sinistra, all’interno di un campo privato recintato. Realizzati in roccia trachitica, vengono comunemente chiamati Su Para e Sa Mongia ossia il frate e la suora. Questi due menhir sono rozzamente sbozzati, uno ha caratteristiche prettamente femminili, mentre l’altro rappresenta sicuramente l’elemento maschile. Si suppone che lì vicino sorgesse un villaggio di capanne e che i due menhir testimoniassero la presenza degli dei nella comunità. Oppure che si tratti di quello che resta di un gruppo di pietre fitte.
Proseguendo lungo la strada statale, possiamo vedere i primi segni dell’antica frequentazione umana a Sant’Antioco, ossia due menhir aniconici presumibilmente risalenti all’Eneolitico. Li incontriamo percorrendo la SS126 Sud Occidentale Sarda, al chilometro 3, cinquecento metri dopo la deviazione per la frazione Is Loddis, vicino allo stagno di Santa Caterina, sull’istmo che dall’isola madre porta a Sant’Antioco, a pochi metri dalla ferrovia sulla sinistra, all’interno di un campo privato recintato. Realizzati in roccia trachitica, vengono comunemente chiamati Su Para e Sa Mongia ossia il frate e la suora. Questi due menhir sono rozzamente sbozzati, uno ha caratteristiche prettamente femminili, mentre l’altro rappresenta sicuramente l’elemento maschile. Si suppone che lì vicino sorgesse un villaggio di capanne e che i due menhir testimoniassero la presenza degli dei nella comunità. Oppure che si tratti di quello che resta di un gruppo di pietre fitte.
La leggenda popolare ha attribuito alle due pietre una storia curiosa fatta di amori illeciti e di punizione divina. Narra infatti la leggenda che la coppia di menhir sia quello che resta di due religiosi fuggiti per sottrarsi all’immancabile e severo castigo per il loro peccato, pietrificati dal potere divino e collocati in quel punto come monito per coloro che si recavano a Sulci, ad indicare che in questa terra chi sbagliava doveva pagare per le proprie manchevolezze. |
Benvenuti a Sulci
Proseguiamo con la SS126 Sud Occidentale Sarda oltre l’istmo, ed a tre chilometri dalla frazione Is Loddis, dopo aver incontrato il cartello indicatore dell’ingresso nell’abitato di Sant’Antioco, sulla sinistra della strada, in un’aiuola ci accoglie un accattivante Benvenuti a Sulci. Subito più avanti, imbocchiamo il Ponte Nuovo in cemento che ci porterà al paese di Sant’Antioco. Il ponte è stato inaugurato nel 1981, e nel 2017 si è ipotizzata la sua demolizione a favore di un nuovo ponte, che è stato però valutato come sovradimensionato e poco compatibile con i valori storico culturali del sito interessato. Fortemente soggetto ad usura, il ponte, unico accesso all’isola, è stato recentemente messo in sicurezza.
Nella frazione Ponti vediamo i resti del Ponte romano
 duecento metri più avanti, arrivati nella frazione Ponti (altezza indefinita, distanza in linea d’aria 1.54 chilometri dal comune di Sant’Antioco di cui fa parte, non è disponibile il numero di abitanti), vediamo sulla destra della strada il vecchio Ponte romano, uno dei pochi resti del periodo della dominazione romana, che è stato utilizzato fino al 1984 come unica via di accesso all’isola. Il ponte romano di Sant’Antioco, conosciuto da tutti col nome di Ponti Mannu rappresenta, come d’altronde gli altri ponti sardi, un unicum non solo nella sua forma ma anche per la posizione sul territorio. Differentemente dagli altri collega la terraferma con un isola e non il guado di fiumi o dislivelli. Il nome ricorda l’esistenza di altri ponti, più piccoli, che legavano l’isola di Sant’Antioco al continente sardo attraverso l’unione degli isolotti dell’attuale istmo.
duecento metri più avanti, arrivati nella frazione Ponti (altezza indefinita, distanza in linea d’aria 1.54 chilometri dal comune di Sant’Antioco di cui fa parte, non è disponibile il numero di abitanti), vediamo sulla destra della strada il vecchio Ponte romano, uno dei pochi resti del periodo della dominazione romana, che è stato utilizzato fino al 1984 come unica via di accesso all’isola. Il ponte romano di Sant’Antioco, conosciuto da tutti col nome di Ponti Mannu rappresenta, come d’altronde gli altri ponti sardi, un unicum non solo nella sua forma ma anche per la posizione sul territorio. Differentemente dagli altri collega la terraferma con un isola e non il guado di fiumi o dislivelli. Il nome ricorda l’esistenza di altri ponti, più piccoli, che legavano l’isola di Sant’Antioco al continente sardo attraverso l’unione degli isolotti dell’attuale istmo.
Nella frazione Ponti si trovava la Stazione ferroviaria di Sant’Antioco Ponti
 In località Ponti era attiva fino al 1974 la Stazione ferroviaria di Sant’Antioco Ponti situata nel Porto Industriale antiochense, lungo la dismessa linea ferroviaria che collegava Siliqua con San Giovanni Suergiu e da qui proseguiva per Calasetta. La stazione viene edificata prima della fine del primo decennio del Novecento nell’area del vecchio ponte romano, che all’epoca era ancora in uso per scavalcare il canale che divideva in quei decenni l’isola antiochense dalla Sardegna, ed è legata principalmente al traffico merci, sebbene per tutta la sua vita venga impiegata anche come fermata per il servizio viaggiatori. Dando uno sguardo al percorso dei binari, desta grande interesse il ponte girevole costruito vicino al vecchio ponte romano per permettere sia il passaggio delle barche che dei treni.
In località Ponti era attiva fino al 1974 la Stazione ferroviaria di Sant’Antioco Ponti situata nel Porto Industriale antiochense, lungo la dismessa linea ferroviaria che collegava Siliqua con San Giovanni Suergiu e da qui proseguiva per Calasetta. La stazione viene edificata prima della fine del primo decennio del Novecento nell’area del vecchio ponte romano, che all’epoca era ancora in uso per scavalcare il canale che divideva in quei decenni l’isola antiochense dalla Sardegna, ed è legata principalmente al traffico merci, sebbene per tutta la sua vita venga impiegata anche come fermata per il servizio viaggiatori. Dando uno sguardo al percorso dei binari, desta grande interesse il ponte girevole costruito vicino al vecchio ponte romano per permettere sia il passaggio delle barche che dei treni.  Il ponte girevole diventa un punto importante della tratta ferroviaria e naturalmente comporta dei problemi di gestione, finché il prefetto stabilisce che il ponte mobile dovesse essere tenuto sempre chiuso, e potesse essere aperto soltanto al passaggio delle barche. Negli anni trenta del Novecento, con la costruzione di uno stabilimento industriale vicino all’impianto e con l’aumento dell’attività estrattiva della zona, il porto diviene meta di un grosso movimento di treni, ed ancora di più dopo l’avvio dell’attività estrattiva nella miniera carbonifera di Serbariu, alle porte della nuova città di Carbonia. Nell’immediato dopoguerra, crollando per la progressiva dismissione del settore estrattivo sulcitano, si arriva alla riduzione dell’esercizio, ma la stazione rimane attiva nonostante la sua minore strategicità, fino a quando viene chiusa nel 1974. Da allora la stazione di Sant’Antioco Ponti non è più attiva e l’area in cui sorgeva è stata in gran parte disarmata negli anni successivi, tanto che oggi non ne rimane più che qualche traccia.
Il ponte girevole diventa un punto importante della tratta ferroviaria e naturalmente comporta dei problemi di gestione, finché il prefetto stabilisce che il ponte mobile dovesse essere tenuto sempre chiuso, e potesse essere aperto soltanto al passaggio delle barche. Negli anni trenta del Novecento, con la costruzione di uno stabilimento industriale vicino all’impianto e con l’aumento dell’attività estrattiva della zona, il porto diviene meta di un grosso movimento di treni, ed ancora di più dopo l’avvio dell’attività estrattiva nella miniera carbonifera di Serbariu, alle porte della nuova città di Carbonia. Nell’immediato dopoguerra, crollando per la progressiva dismissione del settore estrattivo sulcitano, si arriva alla riduzione dell’esercizio, ma la stazione rimane attiva nonostante la sua minore strategicità, fino a quando viene chiusa nel 1974. Da allora la stazione di Sant’Antioco Ponti non è più attiva e l’area in cui sorgeva è stata in gran parte disarmata negli anni successivi, tanto che oggi non ne rimane più che qualche traccia.
Passato il Ponte romano arriviamo al porto Industriale
La SS126 Sud Occidentale Sarda passa sul nuovo ponte in cemento che attraversa il tratto di istmo, che è stato aperto e viene regolarmente dragato per consentire alle navi provenienti dal mare aperto sulla destra, attraverso la laguna di Sant’Antioco, di accedere al Porto Industriale che si vede sulla sinistra. Oltre il porto Industriale, si apre il Golfo di Palmas ed il mare aperto verso sud est. Il porto Industriale è stato realizzato negli anni trenta del secolo scorso come punto di imbarco per il prodotto dell’attività mineraria estrattiva dell’Iglesiente e del Sulcis.
Entriamo nell’abitato di Sant’Antioco
Dopo aver superato il Porto Industriale, la SS126 Sud Occidentale Sarda è passata sul nuovo ponte in cemento che attraversa il tratto di istmo e che unisce l’isola di Sant’Antioco con l’isola madre. Percorsi ancora settecentocinquanta metri, la strada statale assume in nome di via Nazionale e ci conduce all’interno dell’abitato di Sant’Antioco. Dal Municipio di San Giovanni Suergiu a quello di Sant’Antioco si sono percorsi 9.8 chilometri.
Il comune chiamato Sant’Antioco

 Il comune chiamato Sant’Antioco (nome in lingua sarda Santu Antiogu, altezza metri 7 sul livello del mare, abitanti 10.670 al 31 dicembre 2021) sorge sulla costa sud occidentale della Sardegna affacciata sul golfo di Palmas, collegata alla terraferma da un istmo di circa cinque chilometri, circondata dal mare di Sardegna, ai confini con il comune di Calasetta e con quello di San Giovanni Suergio. È facilmente raggiungibile da San Giovanni Suergiu con la SS126 Sud Occidentale Sarda, e da essa parte la SS126 Sud Occidentale Sarda Diramazione sud Occidentale Sarda che la collega con Calasetta, si tratta di due strade statali che ne attraversano il territorio. Il porto di Sant’Antioco si affaccia su una laguna solcata da appositi canali per consentire l’attracco delle navi, il che fa considerare Sant’Antioco l’unico paese lagunare della Sardegna. Il territorio comunale è classificato di collina, presenta un profilo geometrico irregolare con variazioni altimetriche accentuate, e presenta le caratteristiche morfologiche e naturali dell’intera isola di Sant’Antioco, costituita da rocce vulcaniche, ossia basalti e trachiti, da pietre calcaree, e da ambienti marini e lagunari.
Il comune chiamato Sant’Antioco (nome in lingua sarda Santu Antiogu, altezza metri 7 sul livello del mare, abitanti 10.670 al 31 dicembre 2021) sorge sulla costa sud occidentale della Sardegna affacciata sul golfo di Palmas, collegata alla terraferma da un istmo di circa cinque chilometri, circondata dal mare di Sardegna, ai confini con il comune di Calasetta e con quello di San Giovanni Suergio. È facilmente raggiungibile da San Giovanni Suergiu con la SS126 Sud Occidentale Sarda, e da essa parte la SS126 Sud Occidentale Sarda Diramazione sud Occidentale Sarda che la collega con Calasetta, si tratta di due strade statali che ne attraversano il territorio. Il porto di Sant’Antioco si affaccia su una laguna solcata da appositi canali per consentire l’attracco delle navi, il che fa considerare Sant’Antioco l’unico paese lagunare della Sardegna. Il territorio comunale è classificato di collina, presenta un profilo geometrico irregolare con variazioni altimetriche accentuate, e presenta le caratteristiche morfologiche e naturali dell’intera isola di Sant’Antioco, costituita da rocce vulcaniche, ossia basalti e trachiti, da pietre calcaree, e da ambienti marini e lagunari.
Questo paese fa parte dell’Associazione nazionale Città del Vino
 Questo paese fa parte dell’Associazione nazionale Città del Vino, il cui obiettivo è quello di aiutare i Comuni a sviluppare intorno al vino, ai prodotti locali ed enogastronomici, tutte quelle attività e quei progetti che permettono una migliore qualità della vita, uno sviluppo sostenibile, più opportunità di lavoro. Le Città del Vino in Sardegna sono ad oggi Alghero, Ardauli, Arzachena, Atzara, Badesi, Benetutti, Berchidda, Bonnanaro, Bono, Bosa, Calangianus, Dolianova, Donori, Dorgali, Galtellì, Jerzu, Loceri, Lotzorai, Luogosanto, Luras, Meana Sardo, Modolo, Monti, Neoneli, Olbia, Oliena, Riola Sardo, Samugheo, San Nicolò di Arcidano, Sant’Antioco, Selargius, Sennori, Serdiana, Sorgono, Sorso, Tempio Pausania, Terralba, Tissi, Uri, Urzulei, Usini..
Questo paese fa parte dell’Associazione nazionale Città del Vino, il cui obiettivo è quello di aiutare i Comuni a sviluppare intorno al vino, ai prodotti locali ed enogastronomici, tutte quelle attività e quei progetti che permettono una migliore qualità della vita, uno sviluppo sostenibile, più opportunità di lavoro. Le Città del Vino in Sardegna sono ad oggi Alghero, Ardauli, Arzachena, Atzara, Badesi, Benetutti, Berchidda, Bonnanaro, Bono, Bosa, Calangianus, Dolianova, Donori, Dorgali, Galtellì, Jerzu, Loceri, Lotzorai, Luogosanto, Luras, Meana Sardo, Modolo, Monti, Neoneli, Olbia, Oliena, Riola Sardo, Samugheo, San Nicolò di Arcidano, Sant’Antioco, Selargius, Sennori, Serdiana, Sorgono, Sorso, Tempio Pausania, Terralba, Tissi, Uri, Urzulei, Usini..
Origine del nome
Secondo la tradizione qui ebbe rifugio e trovò la morte il medico Antioco, originario del Medio Oriente, esiliato in Sardegna e martirizzato nel 127 dopo Cristo sull’isola di Sant’Antioco che da lui prese il nome. La cittadina, che era l’erede dell’antica Sulci, ha visto mutato il suo nome col trionfo del cristianesimo in Sardegna, evidentemente dopo che, alla fine del quarto secolo, l’Impero romano si è trasformato da pagano in cristiano, con l’imperatore Teodosio il Grande. Il suo nome è attestato fino nell’anno 1341, quando si trova la definizione di Pro grantitio de Pau rectore S. Antiocu diocesis sulcitane, e ripete, quindi, il nome del Santo titolare della chiesa parrocchiale.
La sua economia
La sua economia si basa su tutti i settori produttivi. Per qaunto riguarda il settore primario, l’agricoltura produce cereali, frumento, ortaggi, foraggi, vite, olivo, agrumi e frutta; si allevano anche bovini, suini, ovini, caprini, equini e avicoli. Nel settore secondario, l’industria è costituita da imprese che operano nei comparti alimentare, della lavorazione e conservazione della frutta e degli ortaggi, della produzione di sale, tessile, dell’estrazione, del vetro, dei materiali da costruzione, dei laterizi, metalmeccanico, cantieristico, dei mobili, della produzione e distribuzione di energia elettrica e dell’edilizia. Interessante in questo settore è anche l’artigianato, soprattutto quello specializzato nella produzione di tappeti e di arazzi, non mancano, inoltre, attività legate all’essiccazione dei giunchi per i cesti, l’intarsio del legno e la produzione di nasse. Ma soprattutto sopravvive oggi, grazie alla maestria di Ciara Vigo, una importante artigiana antiochense, la tecnica della produzione del bisso o seta marina, che è un pregiato e raro tessuto color rame realizzato con i filamenti di una conchiglia triangolare bivalve, la Pinna nobilis setacea. Per quanto riguarda il settore terziario, le strutture ricettive offrono possibilità di ristorazione e di soggiorno. Il ricco patrimonio archeologico unito a un mare splendido con fondali mozzafiato, spiagge lunghe e incantevoli che si alternano a calette rocciose, ne fanno una meta turistica molto ambita. Altro motivo di richiamo è la gastronomia locale che ha due origini, una pastorale, legata ai prodotti della terra e all’allevamento, e una marinaresca, legata all’attività della pesca.
Brevi cenni storici
 L’isola è stata frequentata sino dal periodo nuragico, come attestano i numerosi resti che si trovano nel suo territorio. Il suo principale centro, il paese di Sant’Antioco, sorge sull’antico abitato di Sulci o Sulki, fondato dai Fenici nell’ottavo secolo avanti Cristo che, prima della conquista cartaginese avvenuta nel sesto secolo avanti Cristo, era una delle maggiori città fenicie del Mediterraneo. L’importanza storica di Sant’Antioco ha avuto inizio quando, nel periodo fenicio, è diventata uno dei principali centri di scambio commerciale, ed il suo massimo splendore durante la successiva occupazione cartaginese e più avanti durante l’occupazione romana, quando vi ebbero inizio le attività estrattive. Da allora il nome di Sulci è venuto ad identificare tutta la parte sud occidentale della Sardegna. Secondo il geografo greco alessandrino Tolomeo, L’isola veniva chiamava Molibódes nésos, ossia isola plumbea, di certo per i suoi giacimenti di piombo. Subisce, sucessivamente, invasioni vandaliche e saracene. Dall’undicesimo secolo entra a far parte del Giudicato di Càralis, mentre nei secoli successivi è caratterizzata da un massiccio esodo della popolazione, che termina soltanto nel diciassettesimo secolo. Passata sotto la dominazione sabuda, appartiene ai vescovi di Sulci, per passare, poi, nel 1758 alla commenda dei Santi Maurizio e Lazzaro. Nel 1793 viene occupata dai francesi, che vengono comunque espulsi. Con la costituzione della repubblica, del comune di Sant’Antioco nel 2001, con la riorganizzazione delle province della Sardegna, viene cambiata la Provincia da quella di Cagliari, alla quale precedentemente apparteneva, a quella nuova di Carbonia e Iglesias, ed in seguito, con la sua abolizione, nel 2016, passa alla nuova Provincia del Sud Sardegna.
L’isola è stata frequentata sino dal periodo nuragico, come attestano i numerosi resti che si trovano nel suo territorio. Il suo principale centro, il paese di Sant’Antioco, sorge sull’antico abitato di Sulci o Sulki, fondato dai Fenici nell’ottavo secolo avanti Cristo che, prima della conquista cartaginese avvenuta nel sesto secolo avanti Cristo, era una delle maggiori città fenicie del Mediterraneo. L’importanza storica di Sant’Antioco ha avuto inizio quando, nel periodo fenicio, è diventata uno dei principali centri di scambio commerciale, ed il suo massimo splendore durante la successiva occupazione cartaginese e più avanti durante l’occupazione romana, quando vi ebbero inizio le attività estrattive. Da allora il nome di Sulci è venuto ad identificare tutta la parte sud occidentale della Sardegna. Secondo il geografo greco alessandrino Tolomeo, L’isola veniva chiamava Molibódes nésos, ossia isola plumbea, di certo per i suoi giacimenti di piombo. Subisce, sucessivamente, invasioni vandaliche e saracene. Dall’undicesimo secolo entra a far parte del Giudicato di Càralis, mentre nei secoli successivi è caratterizzata da un massiccio esodo della popolazione, che termina soltanto nel diciassettesimo secolo. Passata sotto la dominazione sabuda, appartiene ai vescovi di Sulci, per passare, poi, nel 1758 alla commenda dei Santi Maurizio e Lazzaro. Nel 1793 viene occupata dai francesi, che vengono comunque espulsi. Con la costituzione della repubblica, del comune di Sant’Antioco nel 2001, con la riorganizzazione delle province della Sardegna, viene cambiata la Provincia da quella di Cagliari, alla quale precedentemente apparteneva, a quella nuova di Carbonia e Iglesias, ed in seguito, con la sua abolizione, nel 2016, passa alla nuova Provincia del Sud Sardegna.
Sant’Antioco in una bella lirica di Salvatore Quasimodo
 Il grande poeta Salvatore Quasimodo, al quale verrà assegnato il premio Nobel per la letteratura nel 1959, ha colto la bellezza del mare di Sant’Antioco, tanto che ad esso ha dedicato una bella lirica dal titolo spiaggia a Sant’Antioco, scritta quando, appena trentenne, avendo intrapreso una scandalosa storia d’amore con una vicina, moglie di un locale direttore d’orchestra, viene costretto a trasferirsi a Cagliari, dove, dal marzo 1933 alla fine del 1934, svolge l’attività di funzionario del Genio Civile. Il suo legame con la Sardegna continuerà anche quando si trasferisce a Milano, dove conosce due dei massimi artisti sardi del Novecento, Costantino Nivola, che studia a Monza prima di trasferirsi negli Stati Uniti e di cui Quasimodo è testimone di nozze, ed Aligi Sassu, che nel 1960 dipinge un acquarello dal titolo Salvatore con le sue ammiratrici di Mosca.
Il grande poeta Salvatore Quasimodo, al quale verrà assegnato il premio Nobel per la letteratura nel 1959, ha colto la bellezza del mare di Sant’Antioco, tanto che ad esso ha dedicato una bella lirica dal titolo spiaggia a Sant’Antioco, scritta quando, appena trentenne, avendo intrapreso una scandalosa storia d’amore con una vicina, moglie di un locale direttore d’orchestra, viene costretto a trasferirsi a Cagliari, dove, dal marzo 1933 alla fine del 1934, svolge l’attività di funzionario del Genio Civile. Il suo legame con la Sardegna continuerà anche quando si trasferisce a Milano, dove conosce due dei massimi artisti sardi del Novecento, Costantino Nivola, che studia a Monza prima di trasferirsi negli Stati Uniti e di cui Quasimodo è testimone di nozze, ed Aligi Sassu, che nel 1960 dipinge un acquarello dal titolo Salvatore con le sue ammiratrici di Mosca.
Le principali principali feste e sagre che si svolgono a Sant’Antioco
A Sant’Antioco svolgono le loro attività l’Associazione Turistica Pro Loco di Sant’Antioco, il Gruppo Folkloristico Città di Sant’Antioco, l’Associazione Culturale Su Forti di Sant’Antioco, ed anche il Gruppo Folk Antica Città di Solki, nelle cui esibizioni è possibile ammirare il costume tradizionale delle donne e degli uomini di Sant’Antioco.
Tra le principali feste e sagre che vi si svolgono, si segnalano la festa del Patrono, ossia la Sagra di Sant’Antioco Martire, che si svolge quindici giorni dopo Pasqua con una festa in onore del Martire africano; il 29 giugno, la Festa di San Pietro, alla quale segue per quattro giorni la Sagra del Gusto, ed in conclusione la Barcolana; a inizio agosto, la Festa estiva di Sant’Antioco Martire; la prima domenica di settembre, la Festa di Nostra Signora Bonaria; il 13 novembre si celebra la Festa religiosa di Sant’Antioco Martire, con processione serale.
Visita del centro di Sant’Antioco
 L’abitato di Sant’Antioco, che si estende attorno ai resti del forte Sabaudo, interessato da un fenomeno di forte espansione edilizia, mostra l’andamento tipico delle località collinari, ed ha l’aspetto caratteristico dei villaggi di pescatori, con le piccole case basse e colorate dai tetti rossi, dalle strade strette ma con una struttura urbana complessa. All’arrivo nel paese dal ponte sull’istmo, a seicento metri dal Ponte Romano, si trova il cartello segnaletico che indica L’ingresso in Sant’Antioco. Qui una deviazione verso destra porta a percorrere tutto il lungomare che era precedentemente dedicato ai Caduti di Nassirya, ed è oggi intestato a Silvio Olla, il trentaduenne sottufficiale della Brigata Sassari rimasto ucciso nella strage di Nassiriya, in Iraq. Il lungomare conduce al Porto Turistico, e proseguendo porta all’estremo del paese, nella zona archeologica. Proseguendo, invece, dritti, la SS126 Sud Occidentale Sarda diventa la via Nazionale, che porta all’interno del centro abitato.
L’abitato di Sant’Antioco, che si estende attorno ai resti del forte Sabaudo, interessato da un fenomeno di forte espansione edilizia, mostra l’andamento tipico delle località collinari, ed ha l’aspetto caratteristico dei villaggi di pescatori, con le piccole case basse e colorate dai tetti rossi, dalle strade strette ma con una struttura urbana complessa. All’arrivo nel paese dal ponte sull’istmo, a seicento metri dal Ponte Romano, si trova il cartello segnaletico che indica L’ingresso in Sant’Antioco. Qui una deviazione verso destra porta a percorrere tutto il lungomare che era precedentemente dedicato ai Caduti di Nassirya, ed è oggi intestato a Silvio Olla, il trentaduenne sottufficiale della Brigata Sassari rimasto ucciso nella strage di Nassiriya, in Iraq. Il lungomare conduce al Porto Turistico, e proseguendo porta all’estremo del paese, nella zona archeologica. Proseguendo, invece, dritti, la SS126 Sud Occidentale Sarda diventa la via Nazionale, che porta all’interno del centro abitato.
Prima di arrivare in centro si trova il Campo comunale da calcio
Proseguendo lungo la via Nazionale, alla sinistra della strada si trova quello che resta degli impianti della Sardamag, una ex fabbrica di ossido di magnesio, che è stata totalmente demolita nella primavera del 2008. Dopo quattrocento metri si vede, alla destra della strada, lo storico ingresso del Campo comunale da calcio, in cui nuovo ingresso si trova però sul suo retro, alla sinistra del lungomare Amerigo Vespucci, al civico numero 36. Questo lungomare è la strada che si trova tra la via Nazionale ed il lungomare Silvio Olla e che, dirigendosi verso nord, ha i suoi numeri civici solo alla sinistra, dato che la destra si affacciava sul mare prima della realizzazione del nuovo lungomare dedicato ai Caduti di Nassirya ed oggi intestato a Silvio Olla. Il Campo comunale da calcio ha un manto in erba sintetica, ed è dotato di tribune in grado di ospitare 1500 spettatori.
Dopo l’uscita di scena nel 2015 dello storico Sant’Antioco calcio, gravato da un’infelice congiuntura finanziaria, nell’isola sono comparse due nuove realtà del pallone, la società Antiochense 2013 e la nuova formazione L’isola di Sant’Antioco, che sono partite nel 2016 dalla seconda categoria.
Gli impianti del Complesso Sportivo Lungomare
All’altro lato della strada, alla destra del lungomare Amerigo Vespucci, si trovano anche gli ingressi secondari degli impianti del Complesso Sportivo Lungomare, i cui ingressi principali si trovano invece alla sinistra del lungomare Silvio Olla. Sono presenti il Campo da calcetto, ossia da calcio a cinque, con fondo in erba sintetica, dotato di tribune per 300 spettatori; due Campi da Tennis, con tribune per 500 spettatori, che sono il Campo da tennis numero 2, con le tribune lato mare, ed il Campo da tennis numero 1 con le tribune lato interno; e dal 2022 anche due Campi da padel, gioco assai simile al tennis dal quale si differenzia per le regole, che sono il Campo da padel numero 1 situato lato mare, ed il Campo da padel numero 2 situato lato interno.
Il Monumento ai Caduti del Mare
 Passati gli ingressi del Complesso Sportivo Lungomare, proseguiamo verso nord lungo il lungomare Silvio Olla. A trecentocinquanta metri dall’ingresso del campo da calcetto, si vedono alla sinistra del lungomare le indicazioni che portano ad un vialetto piastrellato, sul quale è riportata L’immagine di un’ancora, che conduce al Monumento ai Caduti del Mare di Sant’Antioco. Il monumento è stato ideato, progettato, promosso e realizzato dall’Associazione Marinai d’Italia, per assolvere il dettato statutario di perpetuare la memoria dei Marinai caduti e di diffondere e consolidare i comuni valori della cultura e delle tradizioni marinare. Il Monumento rappresenta una grossissima ancora con catena, in bronzo, ed è anche presente il simbolo dell’Associazione Marinai d’Italia sulla lastra laterale.
Passati gli ingressi del Complesso Sportivo Lungomare, proseguiamo verso nord lungo il lungomare Silvio Olla. A trecentocinquanta metri dall’ingresso del campo da calcetto, si vedono alla sinistra del lungomare le indicazioni che portano ad un vialetto piastrellato, sul quale è riportata L’immagine di un’ancora, che conduce al Monumento ai Caduti del Mare di Sant’Antioco. Il monumento è stato ideato, progettato, promosso e realizzato dall’Associazione Marinai d’Italia, per assolvere il dettato statutario di perpetuare la memoria dei Marinai caduti e di diffondere e consolidare i comuni valori della cultura e delle tradizioni marinare. Il Monumento rappresenta una grossissima ancora con catena, in bronzo, ed è anche presente il simbolo dell’Associazione Marinai d’Italia sulla lastra laterale.
Gli impianti sportivi della Scuola primaria di via XXIV Maggio
Proseguendo verso nord lungo il lungomare Silvio Olla, dopo duecento metri si arriva a una rotonda, passata la quale la strada costiera prosegue con il nome di lungomare Cristoforo Colombo. A metà della strada dal Monumento ai Caduti del Mare e la rotonda, alla sinistra della strada parte la via XXIV Maggio lungo la quale, dopo poco più di un centinaio di metri, alla destra della strada al cvico numero 1 si vede l’edificio che ospita la Scuola primaria di via XXIV Maggio. All’interno di questo complesso scolatico è presente anche una Palestra coperta, che non è dotata di tribune per gli spettatori, ed in essa è possibile praticare come disciplina diverse attività ginnico motorie.
Il Palazzetto dello Sport Giacomo Cabras
Proseguendo verso nord lungo il lungomare Silvio Olla, poco dopo la partenza della via XXIV Maggio alla destra della strada si vede l’edificio che ospita il Palazzetto dello Sport di Sant’Antioco che fa anch’esso parte degli impianti del Complesso Sportivo Lungomare. All’interno è presente un capo da gioco dotato di tribune in grado di ospitare 200 spettatori, nel quale è possibile praticare come discipline pallacanestro, pallavolo, e calcetto ossia calcio a cinque.
Il Palazzetto è intestato a Giacomo Cabras, giovane atleta dell’Olimpia Sant’Antioco, a cui la leucemia aveva lasciato un’eredità che lo ha portato a morire nel 2001 all’Ospedale Niguarda di Milano, lontano dagli amici, dai compagni di squadra e dal parquet del Palasport. Le cure che lo avevano salvato dalla leucemia gli hanno lasciato dei problemi che poi si sono aggravati, ed a sfibrarlo è stata una broncopolmonite che gli ha procurato complicazioni cardiache sino a richiedere un trapianto di cuore, ma il cuore che avrebbe potuto salvargli la vita non è arrivato in tempo.
Prendendo per le spiagge si trovano le Cantine Sardus Pater
Ritorniamo sulla via Nazionale. Proseguendo lungo la via Nazionale, passato lo storico ingresso del Campo comunale da calcio, poco più avanti svoltamo tutto a sinistra e prendiamo la via della Rinascita, seguendo le indicazioni per la Polizia Municipale, le Spiagge ed i Carabinieri. Percorsi trecentocinquanta metri, verso l’uscita del paese, si trova alla destra della strada l’ingresso delle Cantine Sardus Pater, le famose Cantine Sociali di Sant’Antioco.
Nella piazza Aldo Moro si trova la chiesa parrochiale della Nostra Signora di Bonaria
Dove dalla via Nazionale parte a sinistra la via della Rinascita, si apre alla destra di questa strada la grande piazza Aldo Moro. Questa piazza ospita la Chiesa di Nostra Signora di Bonaria, che è una delle nuove Chiese parrocchiali di Sant’Antioco. La stotis di questa chesa inizia alla fine degli anni quaranta del Novecento, quando a Sant’Antioco esisteva un magazzino deposito dei lavoratori della Carbonifera. Le maestranze dell’azienda, su richiesta del parroco di allora Monsignor Cavassa, decisero di trasformare quel magazzino in una cappella dedicata alla Madonna di Bonaria, a disposizione della devozione delle famiglie della zona. La cappella è stata poi trasformata in una chiesa, costruita su progetto dell’architetto Angelo Marongiu negli anni novanta del secolo scorso. La facciata principale si presenta alla stregua di un paramento murario non direttamente connesso con l’edificio religioso che, nella veduta frontale, dissimula in gran parte grazie al suo sviluppo orizzontale e all’andamento ad arco ribassato della sua porzione superiore. Si caratterizza per la presenza dell’ampio e profondo spazio ricavato al centro, entro il quale collocato l’ingresso alla chiesa. Sul lato sinistro della facciata ricavato un pulpito, e sul medesimo versante, in posizione sopraelevata e arretrata, posizionato l’originale campanile. Da segnalare anche il prospetto laterale sinistro della chiesa, le cui aperture anticipano uno dei tratti distintivi degli interni, improntati ad una luminositàdiffusa. Dal punto di vista planivolumetrico l’aula in senso stretto si sviluppa su una pianta quadrangolare coperta da falde lignee convergenti al centro, il cui estradosso assume la struttura di una piramide i cui lati risultano solcati, al centro, da prese di luce continue.
Presso questa chiesa, il giovedì che precede la prima domenica di settembre si svolge, per quattro giorni, la Festa di Nostra Signora di Bonaria, patrona dei marinai, che raggiunge il suo culmine la domenica. Si tratta di una festa molto sentita sin dai tempi in cui il rione era abitato dalle famiglie degli operai della Carbonifera, da cui aveva preso il nome. Ricco il programma dei festeggiamenti religiosi e civili, organizzati dal Comitato della festa e dalla parrocchia.
Il nostro soggiorno a Sant’Antioco
Nei nostri soggiorni a Sant’Antioco abbiamo alloggiato più volte in via Nazionale nel simpatico Hotel Moderno, situato al centro del paese. Da dove avevamo preso la via della Rinascita, proseguiamo invece dritti, con la via Nazionale che ci porta nel centro del paese, dopo circa duecentocinquanta metri vediamo, alla sinistra della strada al civico numero 82, l’Hotel Moderno nel quale abbiamo soggiornato spesso nelle nostre permanenze a Sant’Antioco.
Il ristorante Da Achille consigliato dalla Guida Michelin
Il ristorante dell’Hotel Moderno, con la sua ottima cucina, si è ormai reso del tutto autonomo rispetto all’Hotel, ed ha assunto il nome di ristorante Da Achille. Si tratta di un ristorante tipico consigliato dalla Guida Michelin.
Lungo la via Nazionale si incontra la chiesa parrocchiale di Santa Maria Goretti Vergine Martire
Proseguendo lungo la via Nazionale, dopo circa trecento metri vediamo, alla sinistra della strada, la piazza della Repubblica, sulla quale si affaccia la Chiesa di Santa Maria Goretti Vergine Martire che è la seconda chiesa parrocchiale di Sant’Antioco. La storia di questa chiesa inizia nel 1947, quando il parroco dell’allora unica parrocchia di Sant’Antioco, preoccupato dell’espandersi del paese verso il porto, si mettono alla ricerca di un locale da adibire almeno a Cappella per l’assistenza spirituale ai nuovi abitanti della periferia del paese. A loro viene concesso un piccolo magazzino usato come deposito attrezzi degli operai della Carbonifera, che diviene la Cappella della zona Acai, dedicata a Nostra Signora di Bonaria, patrona dei marinai. Ma la Cappella si rivela subito molto ristretta, e si provvede alla costruzione di una nuova chiesa. L’edificio viene terminato nel 1959, e la chiesa viene completata nel 1966 e dedicata a Santa Maria Goretti. La chiesa si presenta, esternamente, come una struttura compatta. La facciata, a sviluppo prevalentemente orizzontale, che segue nella parte alta l’andamento leggermente inclinato delle due falde di copertura, ospita nella parte centrale tre ingressi, ciascuno affiancato da agili colonnine su sui sono posti esili archi a sesto acuto, dal portato prettamente decorativo, ed il motivo ritorna, moltiplicato, anche nelle murature che si ergono al di sopra dell’organismo dell’edificio, superiormente alle numerose finestre che illuminano l’interno. Lo spazio ecclesiale si articola sulla base di una pianta rettangolare, nella quale l’ampio spazio della navata centrale è affiancato, lungo le pareti perimetrali, da più stretti e bassi percorsi.
La navata confluisce in un luminoso presbiterio, sulla cui parete di fondo nel 1965 Filippo Figari ha realizzato un mosaico rappresentante la Santa titolare della chiesa inginocchiata in preghiera davanti alla croce circondata di schiere di angeli.
In piazza della Repubblica si trova l’agenzia di servizi turistici TuttoSantAntioco
In piazza della Repubblica, al civico numero 11, si trova la sede dell’agenzia di servizi turistici TuttoSantAntioco.
In piazza Italia si trovano i resti della fontana Romana di Sant’Antioco
Passata la piazza della Repubblica, la via Nazionale prosegue con la via Roma. Percorsi poco più di centocinquanta metri, alla destra della strada si apre la grande piazza Italia, con al centro la Fontana Romana o Fonte de Is Solus dove il termine Is Solus potrebbe essere il plurale di Su Solu, ad indicare la sorgente, tanto che Vittorio Angius, nel 1849, chiama la fontana Is Quattru Solus. Si tratta di una depressione con scale di accesso, che doveva essere la testa di un acquedotto o di una falda sorgiva, le cui origini sono molto antiche, forse addirittura precedenti alla conquista romana della Sardegna. Dove attualmente si apre la fonte, a tre metri di profondità rispetto all’attuale livello della piazza, si trovava l’antico piano di calpestio praticabile in età punica e romana. Oggi si vede solo la parte ristrutturata agli inizi del diciannovesimo secolo, dato che i resti antichi si trovano al di sotto del piano della piazza e quindi non sono direttamente visibili.
Dall’antichità e sino ai nostri giorni la fontana romana è stata l’unica forma di approvvigionamento idrico per la popolazione. Nella piazza Italia è presente anche una fontana nuova.
La ex Stazione ferroviaria di Sant’Antioco
 Arrivata in piazza Italia, prendiamo a destra la via Trieste passando a piedi un tratto pedonale, la seguiamo per centocinquanta metri ed arriviamo nella piazza Sandro Pertini, nella quale si affaccia quella che è stata la stazione di Sant’Antioco, una stazione ferroviaria situata lungo la dismessa linea ferroviaria da Siliqua a San Giovanni Suergiu ed a Calasetta. La stazione, situata in una zona inizialmente di periferia ed in seguito inglobata nella cinta urbana, viene realizzata negli anni venti del Novecento, nell’ambito del progetto di una rete ferroviaria a scartamento ridotto per il Sulcis Iglesiente portato avanti dalla Ferrovie Meridionali Sarde. I lavori di costruzione della linea e della stazione sono eseguiti tra il 1923 ed il 1926, ed entrambe vengono inaugurate il 13 maggio 1926. Come nelle altre stazioni costruite dalle Ferrovie Meridionali Sarde, il fabbricato viaggiatori dello scalo viene decorato da Stanis Dessy. Nel secondo dopoguerra, l’espansione urbanistica di Sant’Antioco portano ad ipotizzare uno spostamento della stazione in una posizione più vicina al porto commerciale, il che non avviene per la chiusura, L’1 settembre 1974, dell’intera rete delle Ferrovie Meridionali Sarde. Le strutture della stazione vengono quindi riconvertite, il fabbricato viaggiatori ospita abitazioni private, mentre la piazzale di stazione, interamente asfaltato, è diventato la piazza Sandro Pertini.
Arrivata in piazza Italia, prendiamo a destra la via Trieste passando a piedi un tratto pedonale, la seguiamo per centocinquanta metri ed arriviamo nella piazza Sandro Pertini, nella quale si affaccia quella che è stata la stazione di Sant’Antioco, una stazione ferroviaria situata lungo la dismessa linea ferroviaria da Siliqua a San Giovanni Suergiu ed a Calasetta. La stazione, situata in una zona inizialmente di periferia ed in seguito inglobata nella cinta urbana, viene realizzata negli anni venti del Novecento, nell’ambito del progetto di una rete ferroviaria a scartamento ridotto per il Sulcis Iglesiente portato avanti dalla Ferrovie Meridionali Sarde. I lavori di costruzione della linea e della stazione sono eseguiti tra il 1923 ed il 1926, ed entrambe vengono inaugurate il 13 maggio 1926. Come nelle altre stazioni costruite dalle Ferrovie Meridionali Sarde, il fabbricato viaggiatori dello scalo viene decorato da Stanis Dessy. Nel secondo dopoguerra, l’espansione urbanistica di Sant’Antioco portano ad ipotizzare uno spostamento della stazione in una posizione più vicina al porto commerciale, il che non avviene per la chiusura, L’1 settembre 1974, dell’intera rete delle Ferrovie Meridionali Sarde. Le strutture della stazione vengono quindi riconvertite, il fabbricato viaggiatori ospita abitazioni private, mentre la piazzale di stazione, interamente asfaltato, è diventato la piazza Sandro Pertini.
Il corso Vittorio Emanuele nel quale si svolge la passeggiata serale di centinaia di giovani nelle sere d’estate
Passata piazza Italia, parte verso sinistra la via Belvedere, mentre noi prendiamo la prosecuzione della via Roma, che è il corso Vittorio Emanuele. Si tratta di un bel viale alberato, nel quale si svolge la passeggiata serale di centinaia di giovani nelle sere d’estate.
Il palazzo del Municipio
All’inizio del corso Vittorio Emanuele, nello slargo chiamato piazzetta Italo Diana, al civico numero 1, si trova sulla destra il Palazzo del Municipio, nel quale sono ospitata la sua sede e gli uffici che forniscono i loro servizi agli abitanti del paese. Si tratta degli uffici del settore Amministrazione, che comprende gli uffici del Sindaco, del Vicesindaco, del Segretario Generale, e dell’Ufficio Stampa; del settore Lavori Pubblici e Appalti; del settore Politiche Sociali; del settore Servizi Amministrativi, che comprende Servizi Demografici e Cimiteriali, Servizio Affari Generali e Politiche della Casa, Servizio Contenzioso, ed Ufficio Protocollo; del settore Servizi al Cittadino, che comprende Servizio Pubblica Istruzione e Servizio Cultura e Beni Culturali, Turismo, Sport e Servizi Museali; del settore Servizi Finanziari, che comprende Servizi Informatici, Servizio Risorse Umane, e Servizio Ragioneria, Tributi, Economato; del settore Servizi per il Territorio, che comprende Servizio Patrimonio e Demanio, Servizio Suape, Commercio Attività Produttive ed Edilizia Privata, del Servizio Urbanistica; del settore Servizi Tecnici e Ambiente, che comprende il Servizio Ambiente, ed il Servizio Tecnico; ed infine del settore Polizia Locale.
E la piazzetta è un luogo di incontro di ragazzi e giovani, e la sera luogo di esibizione degli appassionati di hip-hop. Fuori dal palazzo del Municipio vediamo le bandiere europea ed italiana, mentre all’interno, qualche anno fa, abbiamo trovato esposta la bandiera della pace (eravamo nell’estate del 2003, il periodo della guerra americana in Iraq).
Proseguendo lungo il corso Vittorio Emanuele
Poco più avanti lungo il corso Vittorio Emanuele, siamo entrati per mangiare un gelato nel Bar centrale, e qui abbiamo trovato alle pareti vecchie foto di una mattanza di delfini avvenuta a Sant’Antioco negli anni trenta, quando erano arrivati in quantità tale da distruggere quasi completamente i pesci della laguna, obbligando i pescatori ad organizzare appunto la mattanza. Mentre bevevo al banco, è entrato e si è messo a svolazzare un uccello che ho fotografato appollaiato tra i bicchieri.
La grande piazza Umberto dove si tengono in estate numerosi spettacoli
Proseguiamo quindi per il corso fino a raggiungere, a trecentocinquanta metri dalla piazza Italia, alla grande piazza Umberto, dove si tengono i diversi spettacoli che allietano le serate estive. La visiteremo, visiteremo anche diverse altre strade del centro, come la via Giuseppe Garibaldi che si dirige verso sud est in direzione del Porto Turistico, la via Eleonora d’Arborea che conduce verso ovest e porta fino sulla costa al lungomare Cristoforo Colombo, la via Regina Margherita che si dirige verso nord ovest in direzione della chiesa parrocchiale.
Il Porto Turistico di Sant’Antioco
Da piazza Umberto parte verso sud est la via Giuseppe Garibaldi, la seguiamo per quattrocentocinquanta metri dove porta sulla costa e sbocca sul lungomare. Verso sinistra parte il lungomare Cristoforo Colombo, verso destra il lungomare Silvio Olla. Di fronte a noi si sviluppa il Porto Turistico di Sant’Antioco una nuova Marina per circa duecento imbarcazioni, con pompa carburante e tutti i servizi più importanti disponibili in banchina. È sede di Circolo Nautico con barche a vela latina per le quali si organizzano importanti regate.
Al Porto Turistico si poteva arrivare anche da sud, dal lungomare Silvio Olla, che avevamo visto entrando in Sant’Antioco, e che, in un chilometro e duecento metri, ci porta a raggiungere il lungomare Cristoforo Colombo, sul quale si affaccia il porticciolo.
La chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo
Dalla piazza Umberto, prendiamo verso destra, in direzione est, la via Eleonora d’Arborea e la seguiamo per duecentocinquanta metri. Si apre sulla destra uno slargo che è la piazzetta San Francesco, prendiamo la strada verso destra nella piazzetta che, in un centinaio di metri, sbocca sulla via Monsignor Salvatore Armeni, lungo la quale, sulla destra, si vede la facciata della Chiesa di San Pietro Apostolo che è una delle nuove Chiese parrocchiali di Sant’Antioco. A questa strada saremmo potuti arrivare dalla via Giuseppe Garibaldi, prendendo, a metà tra la piazza Umberto ed il Porto Turistico, a sinistra la via Monsignor Salvatore Armeni e, in poco più di centocinquanta metri, porta a vedere sulla sinistra la facciata della chiesa.
 Organizzata da questa chiesa e dalla comunità dei pescatori del quartiere Marina di Sant’Antioco, ogni anno il 29 giugno si svolge la Festa di San Pietro Apostolo. Tra le cerimonie di natura religiosa la processione a mare, per la quale a mezzogiorno il simulacro dell’Apostolo che Cristo nomina a capo della chiesa universale, sistemato su una barca da pesca poggiata su un pianale di un trattore, viene portato al porto, in località Ponti. Il pomeriggio il simulacro viene imbarcato su un peschereccio addobbato a festa, che, dopo aver attraversato la laguna, raggiunge la banchina del lungomare cittadino, da dove parte la solenne processione. Ad animare i festeggiamenti numerosi appuntamenti musicali, tante bancarelle, e, al calar del sole, la piazza diventa un grande ristorante per la tradizionale frittura in piazza, organizzata dal comitato dei festeggiamenti.
Organizzata da questa chiesa e dalla comunità dei pescatori del quartiere Marina di Sant’Antioco, ogni anno il 29 giugno si svolge la Festa di San Pietro Apostolo. Tra le cerimonie di natura religiosa la processione a mare, per la quale a mezzogiorno il simulacro dell’Apostolo che Cristo nomina a capo della chiesa universale, sistemato su una barca da pesca poggiata su un pianale di un trattore, viene portato al porto, in località Ponti. Il pomeriggio il simulacro viene imbarcato su un peschereccio addobbato a festa, che, dopo aver attraversato la laguna, raggiunge la banchina del lungomare cittadino, da dove parte la solenne processione. Ad animare i festeggiamenti numerosi appuntamenti musicali, tante bancarelle, e, al calar del sole, la piazza diventa un grande ristorante per la tradizionale frittura in piazza, organizzata dal comitato dei festeggiamenti.
Il Monumento ai Caduti in tutte le guerre
Dalla piazza Umberto, prendiamo verso destra, in direzione est, la via Eleonora d’Arborea e la seguiamo per quattrocento metri, finché questa strada sbocca sul lungomare Cristoforo Colombo. La prendiamo verso sinistra, ossia in direzione nord e, dopo appena una quarantina di metri, vediamo di fonte al civico numero 63 all’altro lato della strada, ossia alla destra il Monumento ai Caduti in tutte le guerre. Si tratta di un monumento costituito da una lastra di cristallo, sopra la quale sono riportati i nomi dei Caduti della Prima e della Seconda guerra mondiale, e i nomi dei civili morti sotto i bombardamenti. Il retro del monumento si presenta alla destra del lungomare, mentre la sua facciata è leggibile nel lato mare.
Gli impianti sportivi delle scuole in via Salvo D'Acquisto
Passato il Monumento ai caduti, proseguiamo verso nord lungo il lungomare Cristoforo Colombo e, dopo quasi duecento metri, arriviamo nel punto dove arriva da sinistra la via Salvo D'Acquisto. Prendiamo la via Salvo D'Acquisto e, percorso circa un centinaio di metri, vediamo alla destra della strada, L’ingresso dell’edificio che ospita la sede di via Sanvo D'Acquisto del Liceo Scientifico e Linguistico Emilio Lussu. All’interno di questo complesso scolatico è presente anche una Palestra coperta, che non è dotata di tribune per gli spettatori, ed in essa è possibile praticare come discipline pallacanestro, pallavolo, e diverse attività ginnico motorie.
Percorsa un’altra cinquantina di metri lungo la via Salvo D'Acquisto, vediamo alla destra della strada L’ingresso dell’edificio che ospita la Scuola secondaria Antioco Mannai di Sant’Antioco. In questo complesso scolastico si trova un Campo sportivo all’aperto, con fondo in cemento, dotato di tribune in grado di ospitare un centinaio di spettatori, nel quale è possibile praticare come discipline pallacanestro, pallavolo, e diverse attività ginnico motorie.
All’interno di questo complesso scolatico è presente anche una Palestra coperta, che non è dotata di tribune per gli spettatori, ed anche in essa è possibile praticare come discipline pallacanestro, pallavolo, e diverse attività ginnico motorie.
Gli impianti sportivi della Scuola primaria di via Virgilio
Torniamo in piazza Umberto. Dalla piazza Umberto, prendiamo verso sinistra, in direzione nord ovest, la via Regina Margherita e la seguiamo per duecento metri e, dove la strada curva a sinistra, si apre una piazzetta dalla quale partono verso destra la via Dante Alighieri e la via Virgilio. Subito alla sinistra della via Virgilio, al civico numero 17, si affaccia l’edificio che ospita le Scuole primarie di Sant’Antioco. Nel complesso scolastico si trova un Campo sportivo all’aperto, con fondo in cemento, ed una Pista da atletica, dotati di tribune in grado di ospitare una cinquantina di spettatori, nei quali è possibile praticare diverse attività ginnico motorie.
All’interno di questo complesso scolatico è presente anche una Palestra coperta, che non è dotata di tribune per gli spettatori, ed anche in essa è possibile praticare diverse attività ginnico motorie.
In piazza Alcide De Gasperi si trova il Palazzo del Capitolo
Dalla piazza Umberto prendiamo verso sinistra, in direzione nord ovest, la via Regina Margherita, che è la prosecuzione della via Eleonora d’Arborea. La seguiamo per trecentocinquanta metri fino a che questa strada sbocca sulla piazza Alcide De Gasperi sulla quale, alla sinistra al civico numero 1, si affaccia il Palazzo del Capitolo.
 Qui esistevano a partire dal Settecento le cumbessias, ossia le dimore di pellegrini ospitati durante la festa di Sant’Antioco. L’edificio assume L’aspetto di palazzo solo intorno all’Ottocento, quando viene aggiunto il secondo piano e viene costruita una scala laterale per raggiungerlo. Diviene residenza del collegio capitolare, nella quale due volte L’anno, in occasione della festa di Sant’Antioco, i vescovi e i prelati si trasferivano da Iglesias per soggiornare nella canonica. A seguito della legge del 1862 di scioglimento degli enti religiosi, il palazzo passa alla proprietà demaniale, ed il comune decide di comprarlo come sistemazione per le classi elementari, la guardia nazionale e la giudicatura mandamentale. Dal primo decennio del Novecento il palazzo viene abbandonato, successivamente nel 1930 viene restaurato, ed in tutto il prospetto frontale e laterale viene adottato lo stile liberty. Dal 1931 ospita uffici comunali sino al 1955, anno in cui il comune viene trasferito in corso Vittorio Emanuele. L’edificio viene quindi riclassificato come sede della scuola d avviamento, del liceo e della biblioteca. Ancora oggi ospita la biblioteca Comunale e il centro culturale, che comprende una sala mostre al pian terreno e una sala convegni al primo piano, sede di diverse iniziative culturali.
Qui esistevano a partire dal Settecento le cumbessias, ossia le dimore di pellegrini ospitati durante la festa di Sant’Antioco. L’edificio assume L’aspetto di palazzo solo intorno all’Ottocento, quando viene aggiunto il secondo piano e viene costruita una scala laterale per raggiungerlo. Diviene residenza del collegio capitolare, nella quale due volte L’anno, in occasione della festa di Sant’Antioco, i vescovi e i prelati si trasferivano da Iglesias per soggiornare nella canonica. A seguito della legge del 1862 di scioglimento degli enti religiosi, il palazzo passa alla proprietà demaniale, ed il comune decide di comprarlo come sistemazione per le classi elementari, la guardia nazionale e la giudicatura mandamentale. Dal primo decennio del Novecento il palazzo viene abbandonato, successivamente nel 1930 viene restaurato, ed in tutto il prospetto frontale e laterale viene adottato lo stile liberty. Dal 1931 ospita uffici comunali sino al 1955, anno in cui il comune viene trasferito in corso Vittorio Emanuele. L’edificio viene quindi riclassificato come sede della scuola d avviamento, del liceo e della biblioteca. Ancora oggi ospita la biblioteca Comunale e il centro culturale, che comprende una sala mostre al pian terreno e una sala convegni al primo piano, sede di diverse iniziative culturali.
La Basilica di Sant’Antioco Martire con le catacombe paleocristiane
Arrivati nella piazza Alcide De Gasperi, si apre alla sinistra la piazza della Parrocchia, sulla quale alla sinistra della strada, si trova la Basilica di Sant’Antioco Martire, che è anche la prima e la principale chiesa parrocchiale di Sant’Antioco, dedicata al Santo patrono della Sardegna. La chiesa ha ricevuto l’appellativo di Basilica Minore, denominazione onorifica che il papa concede a edifici religiosi particolarmente importanti attribuendovi il rango di basilica. Sulci è stata anche sede episcopale, attestata a partire dal 484, quando il suo vescovo Vitalis partecipa al Sinodo di Cartagine. Il primitivo Martyrium, realizzato sulla tomba del Santo, era un semplice edificio con pianta a croce allungata ed a simmetria accentrata. La prima menzione del Monasterium Sancti Antiochi risale al 1089, quando Salusio II de Lacon-Gunale, giudice di Cagliari, dona la chiesa di Sant’Antioco ai monaci beneddettini dell’Abbazia di San Vittore di Marsiglia. Le aggiunte delle absidi del 1089 e del 1102 si devono ai monaci Vittorini di Marsiglia. Nel 1102 la chiesa, ristrutturata, viene riconsacrata dal vescovo sulcitano Gregorio, ed, entro il 1218, la cattedra vescovile di Sulci viene traslata a Tratalias. L’impianto originario della chiesa era quello di una chiesa altomedioevale cruciforme, come si deduce anche dai materiali scultorei che sono ora collocati nell’ingresso laterale e nella Cripta del Santuario, che era a pianta centrale, con quattro bracci voltati a botte e corpo centrale cupolato.
Oggi l’edificio prospetta la piazzetta antistante con una facciata timpanata dalla struttura semplice, scandita, in senso verticale, da tre specchi, di cui i due più esterni, dalle dimensioni assai contenute, appaiono raccordati a quello centrale mediante piccole porzioni murarie che simulano e ricordano volute laterali. La porzione centrale contiene il portale di accesso sormontato, a sua volta, da un timpano appena accennato nelle sue porzioni estreme e da motivi decorativi realizzati a rilievo sulla muratura, ed immediatamente al di sopra è ricavato un oculo finestrato di forma ovale.
Internamente l’edificio presenta una struttura articolata, la cui complessità planimetrica è dovuta alle numerose modifiche intervenute nei secoli. Presenta un impianto longitudinale con aula centrale dotata di transetto e affiancata, su entrambi i lati, da una sequenza di spazi dall’andamento irregolare, parzialmente aperti gli uni sugli altri, che, nel complesso, possono essere considerati alla stregua di navate secondarie. Sul versante di fondo del transetto si innesta centralmente il profondo presbiterio absidato, sopraelevato rispetto all’aula. Sul lato sinistro, invece, mediante un ingresso centinato, si apre uno spazio parallelo a quello del presbiterio, e posto in diretto collegamento con questo, di dimensioni inferiori e concluso, a sua volta, da una piccola abside. Nella porzione destra del transetto è posto L’accesso alle sottostanti catacombe. Per quanto riguarda le coperture, l’edificio è connotato dalla presenza di volte a botte in pietra, ed all’incrocio dei suoi bracci si innalza il tamburo a pianta quadrata con quattro finestrelle, in cui si inscrive la base della cupola emisferica realizzata con blocchetti di arenaria. Nella struttura del tamburo sono inoltre da rilevare le quattro scuffie a quarto di sfera, contraddistinte dalla presenza di mensole dalla singolare decorazione simbolica a zampa di leone rovesciata. Il pavimento è stato realizzato ex novo, in occasione del recente restauro, in lastra di calcare sardo.
Nel Seicento e nel Settecento vengono aggiunte la prima campata e la facciata. Con l’aggiunta delle navate laterali e dei due vani absidali, ne è derivata l’attuale pianta longitudinale, con aula a tre navate ed altrettante campate, transetto largo quanto l’aula, e con l’abside affiancata da un’abside minore, relativa a un vano quadrangolare affacciato, con due arcate, sul capocroce e sul braccio sinisto del transetto. La facciata della chiesa è stata modificata nel tempo, e vedendola non ci si aspetterebbe di trovare il suo interno, del tutto intatto, nell’originale stile romanico con elementi bizantini.
Sotto la chiesa si trovano le Catacombe paleocristiane una necropoli che costituisce la testimonianza più antica del Cristianesimo in Sardegna. Il sito è stato realizzato nel quarto o quinto secolo, mettendo in comunicazione tra loro diverse camere funerarie puniche del quinto secolo avanti Cristo, ed il tutto perché i primi membri della nuova comunità cristiana potessero essere sepolti il più vicino possibile alla tomba di Sant’Antioco.
La Cripta viene definita un Santuario, ossia un luogo ritenuto sacro dalla tradizione religiosa, perché in una Cripta del Cimitero catacombale, nel 1615, sono state rinvenute le presunte spoglie del Santo, e sul luogo del loro rinvenimento è stato eretto il Santuario a lui dedicato. Le spoglie sono attualmente conservate in un reliquiario nel Santuario di Sant’Antioco, reliquiario di età barocca a due scomparti, nello scomparto superiore si trova il teschio del Santo, in quella inferiore altre ossa del corpo. La statua del Santo, che si posiziona al suo interno, viene portata in processione in occasione della sagra patronale.
 Il lunedì che segue la seconda domenica dopo Pasqua, si può assistere alla Sagra di Sant’Antioco Martire, alla cui prima celebrazione, subito dopo il rinvenimento delle spoglie del Santo, secondo le cronache hanno partecipato ben 39.000 persone,4.215 cavalli, 3.000 traccas ossia carri trainati dai buoi, 350 barche e 23.583 sacerdoti. Le reliquie sono state, poi, trasferite a Iglesias per preservarle dai rischi delle incursioni dei pirati arabi, e ritornano a Sant’Antioco nel 1815, quando la festa viene ripristinata e da allora prosegue nella forma attuale, con il pellegrinaggio del sabato e la solenne celebrazione del lunedì, seguita dalla attesissima processione con gruppi folk, cavalieri in costume, traccas e suonatori di launeddas. Dal punto di vista civile vanno segnalati i concerti ed i fuochi d’artificio. La sagra ha anche un’edizione estiva il primo di agosto, anché essa con processione religiosa e parata di gruppi in costume, mentre i 13 novembre si celebra la ricorrenza religiosa con processione serale.
Il lunedì che segue la seconda domenica dopo Pasqua, si può assistere alla Sagra di Sant’Antioco Martire, alla cui prima celebrazione, subito dopo il rinvenimento delle spoglie del Santo, secondo le cronache hanno partecipato ben 39.000 persone,4.215 cavalli, 3.000 traccas ossia carri trainati dai buoi, 350 barche e 23.583 sacerdoti. Le reliquie sono state, poi, trasferite a Iglesias per preservarle dai rischi delle incursioni dei pirati arabi, e ritornano a Sant’Antioco nel 1815, quando la festa viene ripristinata e da allora prosegue nella forma attuale, con il pellegrinaggio del sabato e la solenne celebrazione del lunedì, seguita dalla attesissima processione con gruppi folk, cavalieri in costume, traccas e suonatori di launeddas. Dal punto di vista civile vanno segnalati i concerti ed i fuochi d’artificio. La sagra ha anche un’edizione estiva il primo di agosto, anché essa con processione religiosa e parata di gruppi in costume, mentre i 13 novembre si celebra la ricorrenza religiosa con processione serale.
La pista di pattinaggio comunale
Dalla piazza della Parrocchia, prendiamo in direzione sud ovest, la via Francesco Ignazio Manno, la seguiamo per quasi quattrocento metri, finché arriviamo a una rotonda dove prendiamo la prima uscita che ci porta sulla via Giacomo Matteotti che si dirige verso sud. Dopo centocinquanta metri vediamo, alla destra della strada la Pista di pattinaggio comunale, con una Pista da pattinaggio dotata di tribune in grado di ospitare un centinaio di spettatori, nella quale è possibile praticare pattinaggio a rotelle. Al centro della pista è presente un Campo da hokey, nel quale è possibile praticare anche hokey.
Gli impianti sportivi del Liceo Scientifico di via Bolzano
La via Regina Margherita ci aveva porati in piazza Alcide De Gasperi. Qui prendiamo la sua prosecuzione che è la via Calasetta, la seguiamo per duecento metri poi prendiamo leggermente a destra la via Bolzano e, dopo altri duecento metri, vediamo alla destra della strada gli edifici che ospitano il Liceo Scientifico Emilio Lussu. All’interno di questo complesso scolastico è presente una Palestra coperta, senza tribune per gli spettatori, nella quale è possibile praticare come discipline pallacanestro, pallavolo, calcetto ossia calcio a cinque, e diverse attività ginnico motorie.
Il Cimitero Comunale di Sant’Antioco
Sempre da piazza Umberto, prendiamo verso sinistra la via Regina Margherita, che è la continuazione della via Eleonora d’Arborea. La seguiamo per circa duecento metri, poi prendiamo a destra la via Dante Alighieri, dopo centoventi metri questa strada termina in uno slargo, dove continuerebbe sulla via Benedetto Croce. Allo slargo si trova per prima a sinistra la via Giosuè Carducci, la evitiamo e prendiamo la seconda a sinistra, che è la via dei Pini, la seguiamo per duecento metri, e vediamo alla destra della strada l’ingresso del Cimitero Comunale di Sant’Antioco.
All’interno del Cimitero Comunale estremamente significativa è la monumentale tomba del Maresciallo Capo dell’Esercito Silvio Olla, di Sant’Antioco, caduto a soli 32 anni in missione di pace. Era il 12 novembre del 2003 quando un attacco kamikaze nella base Maestrale di Nassiriya, in Iraq, fece ventotto vittime, di cui diciannove italiane. Tra queste, anche Silvio Olla. Da allora, il 12 novembre di ogni anno si celebra il ricordo dei caduti di Nassiriya, e la cittadina di Sant’Antioco ricorda il suo martire per la pace.
Visita dei numerosi resti archeologici e storici presenti all’interno del paese
Visitiamo, ora, la Sant’Antioco archeologica e storica. Sant’Antioco è stato un importante centro di commercio fenicio, poi occupato dai Cartaginese e successivamente, con il nome di Sulci, dai Romani che vi iniziano le attività estrattive. È possibile effettuare una visita guidata che porta a vedere, dopo il fortino sabaudo, il tophet fenicio, la necropoli punica, il villaggio ipogeo, e gli altri resti archeologici. Nella nostra visita al paese di Sant’Antioco possiamo vedere dall’esterno anche alcune strutture murari della città antica, in un’area nella quale furono rinvenuti i due leoni un tempo posti all’ingresso della città.
Il fortino sabuado chiamato anche forte Su Pisu
Lungo la via Regina Margherita, subito prima di arrivare in piazza della Parrocchia, prendiamo verso destra la via Castello, e, in un centinaio di metri, raggiungiamo su un piccolo colle alto una sessantina di metri il Fortino Sabaudo, chiamato anche Forte Su Pisu o Sa Guardia de Su Pisu. All’epoca l’isola di Sant’Antioco era costantemente minacciata dalle incursioni dei pirati saraceni che, partendo da Tunisi, facevano razzia nei villaggi poco difesi della costa sarda. La struttura militare, di duecentosettanta metri quadri, è stata edificata tra il 1813 ed il 1815 per difesa contro gli attacchi dei pirati saraceni. Nell’ottobre del 1815, il Bey di Tunisi, in crisi per la scarsità dei raccolti di grano, invia una flotta di quindici navi che prendono d’assalto il villaggio di Sant’Antioco. Il comandante degli Artiglieri di Sardegna, Efisio Melis Alagna, insieme ai suoi soldati ed a volontari sardi, oppone una strenua resistenza, che però risulta vana per la scarsezza delle munizioni e per il numero dei nemici. Le mura del fortino vengono prese d’assalto, il fortino viene espugnato, ed i Tunisini portano in patria come bottino 133 prigionieri, mentre Melis e i suoi soldati preferiscono la morte alla schiavitù.
Nel luogo dove è stato costruito il fortino Sabaudo si trovavano allora le mura puniche, per la cui costruzione era stato in parte demolito un nuraghe. Nella seconda metà degli novanta del secolo scorso, il fortino Sabaudo ha subito un restauro ed in seguito è stato inserito nel tour delle aree archeologiche di Sant’Antioco.
Visita del Tophet fenicio
A Sant’Antioco è d’obbligo una visita al Tophet fenicio, ossia il limbo dei bambini perduti, dal quale iniziamo la nostra visita ai siti archeologici presenti all’interno dell’abitato. Subito prima di arrivare in piazza della Parrocchia, prendiamo verso destra la via Castello, la seguiamo per quattrocento metri, fino in fondo, e troviamo proprio di fronte l’ingresso del Parco archeologico, all’interno del quale si trova il Tophet fenicio. Verso nord, ad ovest della strada, si può vedere un’area all’aperto appoggiata su una collina di roccia trachitica, da sempre indicata dalla gente del posto come Sa Guardia de Is Pingiadas, ossia la Vedetta delle Pignatte o la Collina delle Pentole, a causa della gran quantità di urne cinerarie in essa recuperate. Ai piedi tale roccia, ad ovest della strada di accesso, si trova un recinto quadrangolare di età punica, che include quello più piccolo di età fenicia nel quale sono state ritrovate le urne. Più a sud, ad est della strada, si trova un recinto molto più grande, rettangolare, costituito da blocchi trachitici bugnati, che delimita verso sud l’intero Tophet, e costituisce un fortilizio di età punica edificato a difesa dell’area quando, nel quarto secolo avanti Cristo, sono state erette le fortificazioni.
La parola Tophet è un termine di origine biblica che indica una località nei pressi di Gerusalemme, nella quale venivano bruciati e sepolti i bambini, ed oggi, convenzionalmente, indica le aree sacre di età fenicia e punica rinvenute in Sardegna, Sicilia e Tunisia, nella quale sono state recuperate urne contenenti ossa bruciate di bambini e animali. Nel periodo fenicio, e successivamente in quello punico, i bambini non potevano essere sepolti nella necropoli dato che non avevano ancora superato le cerimonie di iniziazione. Venivano quindi sepolti in una località separata, nella nuda terra, nel Tophet, dopo essere stati cremati. |
Il Tophet è stato attivo dall’ottavo al primo secolo avanti Cristo ed è il più importante di tutta la Sardegna ed uno dei principali al mondo, dato che solo quello di Cartagine è ad esso superiore come numero di urne e steli funerarie. Nel Tophet sono stati rinvenuti ben 3250 vasi di terracotta contenenti i resti bruciati di bambini, a volte accompagnati da piccoli animali domestici, ed oltre 1500 steli funerarie. Gli scavi proseguono dato che in gran parte è da portare alla luce, e si pensa esistano ancora almeno 2000 urne da disseppellire. Sulla collina viene oggi riproposto lo stato del Tophet al momento degli scavi, dato che i vasi di terracotta lì presenti sono solo ricostruzioni, tranne qualcuno originale che si vede affiorare dalla terra.
In base ai resoconti degli antichi Romani, che però ne erano avversari e quindi ne davano un giudizio non certo imparziale, si è ritenuto che si trattasse dei sacrifici cruenti dei primogeniti delle più alte classi sociali, per dimostrazione che gli avversari dei Romani erano incivili e crudeli. Ma una interpretazione storica più attendibile porta ad escludere questa interpretazione, dato che si ritiene improbabile che, in un’epoca nella quale solo una minima percentuale dei bambini sopravviva alle malattie della prima infanzia ed arrivava alla maggiore età, venissero offerti in sacrificio i primogeniti, e soprattutto quelli delle famiglie più abbienti. Da analisi effettuate in questi ultimi anni proprio sui reperti del Tophet di Sant’Antioco, si è però visto che molti erano aborti, per cui oggi si tende a ritenere che in gran parte si sia trattato proprio di aborti o di morti premature avvenute prima delle cerimonie di iniziazione. I piccoli animali domestici venivano probabilmente sacrificati alla divinità per scongiurare il ripetersi di un simile luttuoso evento, e la stele funeraria veniva portata sul posto per ringraziare la divinità dopo la nascita di un nuovo figlio.
I resti della necropoli punica in localtà Is Pirixeddus
Dal cancello di accesso al Tophet, riprendiamo all’indietro la via Castello che ci porta verso il forte Su Pisu. Poco più avanti, passata la deviazione a destra nella via della necropoli, alla sinistra della strada si vede il cancello di accesso ai resti della Necropoli punica di Is Pirixeddus. Gli antichi abitanti punici di Sulky, attuale paese di Sant’Antioco, usavano seppellire i loro morti presso la necropoli, che, all’epoca, era ubicata fuori dal centro abitato e le cui tombe venivano scavate su un colle roccioso, come era tipico per i punici e come accadeva anche a Cartagine e a Cagliari. Quella di Sant’Antioco, tra le necropoli di età punica in Sardegna, è la più importante per la vastità dell’impianto funerario, per la complessità architettonica e per i reperti archeologici rinvenuti nelle tombe durante gli scavi. L’estensione delle necropoli, che si sviluppa tra la via Castello ad est, la via Giosuè Carducci ad ovest, ed a sud la scalinata dei Due Leoni che porta alla Scuola elementare di via Virgilio, era in origine di oltre sei ettari. Considerando che in media ogni tomba occupava 40 metri quadrati, si può valutare che il numero di ipogei fosse di circa 1.500, ed, in base a ciò, la popolazione allora residente può essere stimata in circa 9.000 o 10.000 abitanti, e quindi l’antica Sulky si può considerare tra le città pinoche più popolose ed estese del Mediterraneo. In età punica, il rito funebre era soprattutto quello dell’inumazione, ma esistono anche testimonianze successive attribuibili al rito d’incinerazione. Sono presenti numerose tombe a camera ipogeica, alle quali si accedeva da un ingresso a scalinata, ed alcuni rari esempi di tombe a fossa con copertura a lastre di tufo. Le tombe sotterranee sono spesso disposte a profondità differenti, a causa della quantità di tombe già esistenti, che hanno portato, nel tempo, a scavarle a profondità sempre maggiore.
Quello che noi conosciamo oggi, che è ancora visibile e in parte almeno visitabile, è ciò che rimane della necropoli punica, che ebbe una vita compresa tra il settimo ed il terzo secolo avanti Cristo circa. Ho visitato la necropoli molti anni fa, ma da una ventina di anni è purtroppo chiusa per restauri, comunque è stata riaperta gli ultimi anni. Per vedere una necropoli punica ben conservata conviene comunque, oggi, recarsi al Monte Sirai, vicino a Carbonia, dove si trova la necropoli che abbiamo già visitato in una tappa precedente.
I resti dell’acropoli della città punica
 Poco più avanti, alla destra della strada si vedono i resti dell’acropoli della città punica del settimo secolo avanti Cristo, le cui fortificazioni poggiavano sugli affioramenti rocciosi naturali. La zona è stata frequentata tra l’età punica e quella tardo romana. I resti più antichi sono riferibili alle fortificazioni puniche, delle quali si può ancora vedere un tratto delle mura che difendevano L’acropoli, costruite da blocchi di ignimbrite squadrati a doppio paramento: il muro aveva i due prospetti rivestiti dai blocchi, mentre lo spazio interno era riempito da terra e pietre. Rimane in buono stato di conservazione un tratto di muro con direzione da est ad ovest, con i blocchi bugnati. L’altezza massima conservata è di un metro e mezzo. La tipologia delle mura, in assenza di sicuri dati di scavo, consente di datarle al quarto secolo avanti Cristo.
Poco più avanti, alla destra della strada si vedono i resti dell’acropoli della città punica del settimo secolo avanti Cristo, le cui fortificazioni poggiavano sugli affioramenti rocciosi naturali. La zona è stata frequentata tra l’età punica e quella tardo romana. I resti più antichi sono riferibili alle fortificazioni puniche, delle quali si può ancora vedere un tratto delle mura che difendevano L’acropoli, costruite da blocchi di ignimbrite squadrati a doppio paramento: il muro aveva i due prospetti rivestiti dai blocchi, mentre lo spazio interno era riempito da terra e pietre. Rimane in buono stato di conservazione un tratto di muro con direzione da est ad ovest, con i blocchi bugnati. L’altezza massima conservata è di un metro e mezzo. La tipologia delle mura, in assenza di sicuri dati di scavo, consente di datarle al quarto secolo avanti Cristo.
Vicino all’acropoli della città punica si trovano i resti di un tempio romano
 A meridione del complesso fortificato si trovano i resti di una struttura di periodo romano, interpretata come luogo di culto, ossia un Tempio romano. La base della costruzione è composta da un basamento, conservato per una lunghezza di circa dieci metri, su cui si trova un colonnato di cui rimangono nove colonne. Questo piano è stato pavimentato in due tempi successivi. Il pavimento più antico è quello visibile a sud delle colonne, del tipo detto signinum, ossia in cocciopesto frammisto a tesserine bianche. In seguito questo è stato ricoperto da uno strato di cocciopesto più scuro, conservato fra le colonne e il bordo esterno dell’edificio. A sud delle colonne si trova un grande zoccolo costituito da grandi blocchi bugnati di ignimbrite, dal quale si alza un ulteriore livello ad un’altezza di un metro, il cui perimetro è costituito dallo stesso tipo di blocchi, mentre la pavimentazione, di cui rimangono pochi resti, è in mosaico a tesserine bianche. Il tempio aveva la fronte ad est, dal momento che ad ovest la struttura è chiusa.
A meridione del complesso fortificato si trovano i resti di una struttura di periodo romano, interpretata come luogo di culto, ossia un Tempio romano. La base della costruzione è composta da un basamento, conservato per una lunghezza di circa dieci metri, su cui si trova un colonnato di cui rimangono nove colonne. Questo piano è stato pavimentato in due tempi successivi. Il pavimento più antico è quello visibile a sud delle colonne, del tipo detto signinum, ossia in cocciopesto frammisto a tesserine bianche. In seguito questo è stato ricoperto da uno strato di cocciopesto più scuro, conservato fra le colonne e il bordo esterno dell’edificio. A sud delle colonne si trova un grande zoccolo costituito da grandi blocchi bugnati di ignimbrite, dal quale si alza un ulteriore livello ad un’altezza di un metro, il cui perimetro è costituito dallo stesso tipo di blocchi, mentre la pavimentazione, di cui rimangono pochi resti, è in mosaico a tesserine bianche. Il tempio aveva la fronte ad est, dal momento che ad ovest la struttura è chiusa.
Il rinvenimento dei Leoni di Sulci
 Negli anni ottanta del secolo scorso, nei pressi della necropoli punica sono stati trovati i Leoni di Sulci, due grandi animali che oggi sono esposti al Museo Archeologico, scolpiti in posizione accosciata, con la coda rigirata attorno ad una zampa, inquadrati all’interno di un elemento con una base tronco piramidale, rastremata verso l’alto, sormontata da un listello toro, con sopra una gola egizia. Nella parte posteriore c’è una superficie piana con un incasso a sezione triangolare, forse per consentire l’inserimento dei leoni in una struttura monumentale. Al momento del rinvenimento i due leoni si trovavano ai lati di una nicchia chiusa da un muro rettilineo a due filari. La struttura è stata riferita all’età repubblicana, ma i leoni, essendo più antichi, dovevano essere stati utilizzati per decorare un’altra struttura, e di essi si può fare una datazione solo su base stilistica. Sono di tradizione orientale, siriana o siro palestinese, con influenze assire ed ittite. Questo tipo di leoni in oriente erano utilizzati nelle porte dei templi. Una prima datazione li riporta al quarto secolo avanti Cristo, quando la città viene circondata da una cinta muraria fortificata, con alcune torri, con una porta a vestibolo con due leoni monumentali, posti all’ingresso della città, e viene edificata anche una sorta di fortilizio nella zona nella quale è situato il Tophet. Un’altra datazione li riporta al sesto secolo avanti Cristo, e la loro funzione doveva essere legata alla destinazione dell’area nel quale si trovavano, militare perché vicina alle fortificazioni dato che forse erano sistemati ai lati della porta di ingresso, oppure religiosa e quindi all’ingresso di un tempio con i due leoni ai lati dell’ingresso.
Negli anni ottanta del secolo scorso, nei pressi della necropoli punica sono stati trovati i Leoni di Sulci, due grandi animali che oggi sono esposti al Museo Archeologico, scolpiti in posizione accosciata, con la coda rigirata attorno ad una zampa, inquadrati all’interno di un elemento con una base tronco piramidale, rastremata verso l’alto, sormontata da un listello toro, con sopra una gola egizia. Nella parte posteriore c’è una superficie piana con un incasso a sezione triangolare, forse per consentire l’inserimento dei leoni in una struttura monumentale. Al momento del rinvenimento i due leoni si trovavano ai lati di una nicchia chiusa da un muro rettilineo a due filari. La struttura è stata riferita all’età repubblicana, ma i leoni, essendo più antichi, dovevano essere stati utilizzati per decorare un’altra struttura, e di essi si può fare una datazione solo su base stilistica. Sono di tradizione orientale, siriana o siro palestinese, con influenze assire ed ittite. Questo tipo di leoni in oriente erano utilizzati nelle porte dei templi. Una prima datazione li riporta al quarto secolo avanti Cristo, quando la città viene circondata da una cinta muraria fortificata, con alcune torri, con una porta a vestibolo con due leoni monumentali, posti all’ingresso della città, e viene edificata anche una sorta di fortilizio nella zona nella quale è situato il Tophet. Un’altra datazione li riporta al sesto secolo avanti Cristo, e la loro funzione doveva essere legata alla destinazione dell’area nel quale si trovavano, militare perché vicina alle fortificazioni dato che forse erano sistemati ai lati della porta di ingresso, oppure religiosa e quindi all’ingresso di un tempio con i due leoni ai lati dell’ingresso.
Il Villaggio Ipogeo
Ci possiamo fare un’idea di come fossero le tombe ipogeiche scavate tra il sesto e il terzo secolo avanti Cristo dai Cartaginesi, visitando quello che viene chiamato il Villaggio Ipogeo. Ritornati nella piazza della Parrocchia, proseguiamo lungo la via Calasetta, che è la prosecuzione della via Regina Margherita, e che uscirà dall’abitato con il nome di SS126 Diramazione e condurrà al paese di Calasetta. Percorsa sulla via Calasetta qualche decina di metri, prendiamo a destra la via della necropoli, che costeggia il versante occidentale della collina sormontata dal fortino Sabaudo. Lungo questa strada, soprattutto alla destra, vediamo i resti di queste tombe, dato che gran parte delle camere funerarie scavate nel tufo sono state nel tempo riadattate ad abitazioni, spazi di lavoro e magazzini dagli abitanti di Sant’Antioco. La sua origine risale al Medioevo, quando l’isola di Sant’Antioco viene attaccata e saccheggiata dai Saraceni, parte degli abitanti si trasferisce verso luoghi più tranquilli come Iglesias, mentre i pastori e gli agricoltori rimasti sul posto profanano le tombe puniche, che rimangono nascoste agli occhi degli invasori, e le trasformarono in abitazioni. Le tombe trasformate vengono chiamate Is Gruttas, ed i loro abitanti Is Gruttaiusu. Ancora negli anni trenta del secolo scorso dimoravano nelle grotte circa 700 persone, come attestano le relazioni di medici e ingegneri conservate nell’archivio storico. A metà degli anni novanta del Novecento un progetto portato avanti dall’Amministrazione Comunale ha permesso il recupero di queste grotte e la realizzazione del Villaggio Ipogeo, uno dei siti tra i più visitati dell’intero percorso archeologico e storico.
Come già detto, altre tombe ipogeiche scavate tra il sesto e il terzo secolo avanti Cristo dai Cartaginesi, si trovano sotto la Basilica dedicata a Sant’Antioco, con accesso dall’interno della chiesa, e, nei primi secoli del Cristianesimo, sono state poste in comunicazione tra loro e riadattate come catacombe cristiane.
I pochi resti della necropoli romana
Non vi sono molti resti della Necropoli romana. È detto già dall’epoca repubblicana siano state riutilizzate le tombe ipogeiche puniche, in cui vengono deposte le urne dei cremati, pratica molto comune nel secondo secolo avanti Cristo, ma che si è andata riducendo in quello successivo. In Età Imperiale, la necropoli romana continua ad occupare l’area delle tombe puniche a nord dell’abitato moderno, e si sovrappone a queste.
I resti del Cronicario
Dalla piazza della Parrocchia prendiamo la via Regina Margherita in direzione della piazza Umberto, dopo duecentotrenta metri deviamo verso sinistra nella la via Camillo Benso di Cavour, e, dopo un’ottantina di metri, prendiamo a sinistra la via Massimo d’Azeglio. Seguita per un’ottantina di metri, vediamo, alla destra della strada, l’area archeologica del Cronicario scoperta nel 1983, quando L’attività di ristrutturazione di un vecchio edificio costruito negli anni cinquanta per l’edificazione di un Cronicario con annessa capella e giardino, ha portato al rinvenimento dei primi resti del sito che ha restituito le attestazioni più antiche dell’abitato dell’antica Sulky. La prima fase ha restituito livelli di occupazione neolitica, riferibili a un villaggio di Cultura Ozieri testimoniati essenzialmente da materiali ceramici. Attorno ai primi decenni dell’ottavo secolo avanti Cristo l’area viene occupata dai Fenici che vi installano un insediamento costituito da un quartiere abitativo organizzato a terrazze seguendo la naturale pendenza del terreno in senso da ovest ad est. I resti delle strutture si inseriscono all’interno di due strade, in cui si conservano ancora i pozzetti per la raccolta dell’acqua piovana, che si intersecano ad angolo retto indicando che il tessuto urbano doveva essere disposto in modo ortogonale. I resti murari individuati permettono di ricostruire una serie di semplici ambienti rettangolari e quadrangolari, continuamente replicati, costituiti da uno zoccolatura di base in pietre di dimensioni medio piccole legate con malta di fango su cui si elevano gli alzati costruiti in mattoni crudi coesi con malta di fango e intonacati con cenere e calce. I pavimenti sono realizzati con terra pressata e compattata con tritume di tufo e argilla. Insieme agli ambienti originariamente coperti sono stati identificati anche spazi aperti, interpretati come cortili, dotati di un pozzo per l’approvvigionamento dell’acqua necessaria agli usi domestici dato che a circa sei metri di profondità scorre ancora oggi una falda di acqua dolce. Tra gli ambienti indagati, la maggior parte ad uso residenziale, alcuni erano adibiti a impianti produttivi relativi a prodotti alimentari, come sembrano attestare le consistenti tracce di lavorazione e conservazione del tonno e di altri pesci comprovate dai dati di scavo. La presenza di ceramica fenicia arcaica, anche orientale, rinvenuta in quantità considerevole nei vari livelli di vita dell’abitato, unitamente all’associazione con vasellame greco tardo geometrico, consente di inserire Sulky nell’ambito della prima ondata di colonizzazione fenicia dell’Occidente. In età punica l’area mantiene l’originaria funzione abitativa.
Successivamente, tra la fine del terzo secolo ed il primo secolo dopo Cristo, il sito è interessato dalla presenza di un settore dell’abitato romano edificato ai lati di due strade. Relativi a questa fase sono alcuni ambienti adibiti a uso residenziale, altri a impianti produttivi di prodotti alimentari, ed un luogo di culto attestato dal rinvenimento di una statua marmorea femminile panneggiata e di numerosi frammenti di coroplastica riferibili a statuette femminili panneggiate e a protomi muliebri accostabili iconograficamente alla dea Demetra. Dal 2000, a più riprese, gli scavi nell’area continuano in collaborazione con L’Università degli Studi di Sassari sotto la direzione di Piero Bartoloni.
I resti della tomba romana di Sa Presonedda chiamata anche Sa Tribuna
 La principale testimonianza del periodo romano all’interno dell’abitato è costituita dalla piccola tomba romana di Sa Presonedda, una tomba a mausoleo conosciuta come Sa Tribuna, situata lungo la via Eleonora d Arborea, a centotrenta metri dalla piazza Umberto, alla sinistra della strada, subito prima dell’incrocio con la via XX Settembre. Questo edificio, di età presunta tra il secondo secolo avanti Cristo ed il primo secolo dopo Cristo, avvalora l’ipotesi dell’esistenza di un foro romano nella zona, ed oggi si presenta solo come un mucchio di pietre, ma in origine aveva una struttura piramidale costituita da blocchi lavorati e squadrati, che ricopriva una camera funeraria di forma allungata posizionata al di sotto. L accesso avveniva per mezzo di una scalinata discendente di sei gradini, che conduceva alla camera, nella quale sono state realizzate due nicchie di forma quadrangolare in ognuno dei lati lunghi. Questo monumento viene ritenuto di età romana, anche se all’interno sembra siano stati rinvenuti i resti di un individuo identificato come un cittadino sardo-punico. Altri scavi archeologici di resti romani sono tuttora in corso.
La principale testimonianza del periodo romano all’interno dell’abitato è costituita dalla piccola tomba romana di Sa Presonedda, una tomba a mausoleo conosciuta come Sa Tribuna, situata lungo la via Eleonora d Arborea, a centotrenta metri dalla piazza Umberto, alla sinistra della strada, subito prima dell’incrocio con la via XX Settembre. Questo edificio, di età presunta tra il secondo secolo avanti Cristo ed il primo secolo dopo Cristo, avvalora l’ipotesi dell’esistenza di un foro romano nella zona, ed oggi si presenta solo come un mucchio di pietre, ma in origine aveva una struttura piramidale costituita da blocchi lavorati e squadrati, che ricopriva una camera funeraria di forma allungata posizionata al di sotto. L accesso avveniva per mezzo di una scalinata discendente di sei gradini, che conduceva alla camera, nella quale sono state realizzate due nicchie di forma quadrangolare in ognuno dei lati lunghi. Questo monumento viene ritenuto di età romana, anche se all’interno sembra siano stati rinvenuti i resti di un individuo identificato come un cittadino sardo-punico. Altri scavi archeologici di resti romani sono tuttora in corso.
I musei nell’abitato di Sant’Antioco
Iniziamo, ora, la visita degli importanti musei di Sant’Antioco, partendo dal Museo Archeologico, per poi visitare il Museo Etnografico, ed una visita al Museo del Bisso di Chiara Vigo. Faremo anche un’intervista a Chiara Vigo, l’ultima tessitrice del bisso, la seta di mare che tanto importante è stata per i Fenici e per i Caldei. Chiuderemo con una visita al Il MuMA ossia al Museo del Mare e dei Maestri d’Ascia.
Il Museo Archeologico Comunale

 Gli originali dei vasi rinvenuti nel Tophet fenicio si trovano nel Museo Archeologico Comunale Ferruccio Barreca che si trova vicino al Tophet fenicio. Per raggiungerlo, arrivati con la via Castello all’ingresso dell’area archeologica, prendiamo verso destra la via Giosuè Carduccu, la seguiamo per quasi centocinquanta metri poi prendiamo a sinistra la via Kalaris, dopo poco più di duecento metri prendiamo a sinistra nella via Insulla Plumbaria, che in un’ottantina di metri ci porta al parcheggio vicino al Museo. La visita al Museo inizia da moltissimi reperti preistorici del Neolitico recente, ossia della Cultura di Ozieri, restituiti dagli scavi dell’area dell’Ospizio cittadino e dal grande insediamento all’aperto di Canai. La fase successiva del periodo nuragico ha una presentazione minima, soprattutto a causa delle poche indagini in questo campo, ed è costituito da una serie di piccoli vasi e ciotole d’impasto dell’Età del Bronzo provenienti da una località sconosciuta e pochi frammenti rinvenuti negli scavi dell’Ospizio. Il periodo fenicio è illustrato dai materiali provenienti dal Tophet, per la cui illustrazione è stato ricostruito un angolo nel quale, su piani artificiali di terra, sabbia e pietre, sono state collocate solo una parte delle migliaia di urne, che contenevano le ceneri di bambini e animali, e stele raffiguranti rappresentazioni divine simboliche, antropomorfe o animali da attribuire al rito che si svolgeva in tale area. Segue, poi, il periodo punico, rappresentato dai corredi funerari provenienti dalla grande necropoli ipogea in localtà Is Pirixeddus. Tra i reperti di origine punica ci sono anche le due splendide statue gemelle raffiguranti i Leoni di Sulci, che abbiamo già descritte. Alla sezione punica segue quella relativo al periodo dell’occupazione romana, quando, dal terzo secolo avanti Cristo, Sulky entra a far parte del dominio di Roma con il nome di Sulci.
Gli originali dei vasi rinvenuti nel Tophet fenicio si trovano nel Museo Archeologico Comunale Ferruccio Barreca che si trova vicino al Tophet fenicio. Per raggiungerlo, arrivati con la via Castello all’ingresso dell’area archeologica, prendiamo verso destra la via Giosuè Carduccu, la seguiamo per quasi centocinquanta metri poi prendiamo a sinistra la via Kalaris, dopo poco più di duecento metri prendiamo a sinistra nella via Insulla Plumbaria, che in un’ottantina di metri ci porta al parcheggio vicino al Museo. La visita al Museo inizia da moltissimi reperti preistorici del Neolitico recente, ossia della Cultura di Ozieri, restituiti dagli scavi dell’area dell’Ospizio cittadino e dal grande insediamento all’aperto di Canai. La fase successiva del periodo nuragico ha una presentazione minima, soprattutto a causa delle poche indagini in questo campo, ed è costituito da una serie di piccoli vasi e ciotole d’impasto dell’Età del Bronzo provenienti da una località sconosciuta e pochi frammenti rinvenuti negli scavi dell’Ospizio. Il periodo fenicio è illustrato dai materiali provenienti dal Tophet, per la cui illustrazione è stato ricostruito un angolo nel quale, su piani artificiali di terra, sabbia e pietre, sono state collocate solo una parte delle migliaia di urne, che contenevano le ceneri di bambini e animali, e stele raffiguranti rappresentazioni divine simboliche, antropomorfe o animali da attribuire al rito che si svolgeva in tale area. Segue, poi, il periodo punico, rappresentato dai corredi funerari provenienti dalla grande necropoli ipogea in localtà Is Pirixeddus. Tra i reperti di origine punica ci sono anche le due splendide statue gemelle raffiguranti i Leoni di Sulci, che abbiamo già descritte. Alla sezione punica segue quella relativo al periodo dell’occupazione romana, quando, dal terzo secolo avanti Cristo, Sulky entra a far parte del dominio di Roma con il nome di Sulci.
Altri vasi e steli funerarie rinvenuti a Sant’Antioco, oltre a reperti del periodo punico e romano, li possiamo vedere al Museo Archeologico Nazionale di Cagliari uno dei più completi e meglio organizzati musei d’Italia.
Il Museo è intestato a Ferruccio Barreca, studioso e archeologo di fama mondiale nato a Roma nel 1923, che è stato un instancabile ricercatore ed animatore degli studi Fenici e punici in Sardegna. Considerato il grande archeologo dei Fenici, per vent’anni è stato Soprintendente ai Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari e docente di archeologia fenicio punica nell’Università di Cagliari.
Il Museo Etnografico di Sant’Antioco

 Seguendo la via della necropoli per quasi centocinquanta metri dopo aver visitato il villaggio ipogeo, possiamo visitare, alla destra della strada, il Museo Etnografico chiamato anche Su Magasinu de Su Binu ospitato in uno spazioso e caratteristico magazzino del diciottesimo secolo, completo di Lolla, ossia del cortile parzialmente coperto nel quale si svolgevano le attività domestiche della famiglia. Nel Museo sono esposti gli oggetti che testimoniano gli usi e i costumi dell’isola, soprattutto in relazione alla lavorazione della palma nana per la produzione di scope, corde, borse, pennelli, vari tipi di intrecci, alla lavorazione del bisso, ed alle modalità di colorazione naturale dei tessuti. Nel Museo sono esposti, inoltre, gli strumenti per la produzione del pane, in particolare si illustra il pane votivo offerto al Santo Patrono Sant’Antioco, e per la produzione del formaggio, per la coltivazione della vite e per la vinificazione, per il lavoro nei campi. Sono esposti, anche, gli strumenti utilizzati per le attività del falegname, del bottaio e del maniscalco. Nel cortile sono esposti diversi tipi di carretti sardi, ossia il carro a buoi, il carretto per l’asino e per il cavallo. Il Museo, in questi anni di intensa attività, si è inserito nel circuito dell’interscambio con altri musei e centri di studio sparsi nel mondo.
Seguendo la via della necropoli per quasi centocinquanta metri dopo aver visitato il villaggio ipogeo, possiamo visitare, alla destra della strada, il Museo Etnografico chiamato anche Su Magasinu de Su Binu ospitato in uno spazioso e caratteristico magazzino del diciottesimo secolo, completo di Lolla, ossia del cortile parzialmente coperto nel quale si svolgevano le attività domestiche della famiglia. Nel Museo sono esposti gli oggetti che testimoniano gli usi e i costumi dell’isola, soprattutto in relazione alla lavorazione della palma nana per la produzione di scope, corde, borse, pennelli, vari tipi di intrecci, alla lavorazione del bisso, ed alle modalità di colorazione naturale dei tessuti. Nel Museo sono esposti, inoltre, gli strumenti per la produzione del pane, in particolare si illustra il pane votivo offerto al Santo Patrono Sant’Antioco, e per la produzione del formaggio, per la coltivazione della vite e per la vinificazione, per il lavoro nei campi. Sono esposti, anche, gli strumenti utilizzati per le attività del falegname, del bottaio e del maniscalco. Nel cortile sono esposti diversi tipi di carretti sardi, ossia il carro a buoi, il carretto per l’asino e per il cavallo. Il Museo, in questi anni di intensa attività, si è inserito nel circuito dell’interscambio con altri musei e centri di studio sparsi nel mondo.
Il Museo del Bisso dove nelle mani di Chiara Vigo sopravvive la tradizione della tessitura del bisso

 Solo a Sant’Antioco, in tutto il Mediterraneo, sopravvive l’antica arte della Tessitura del bisso, la Seta di mare tanto preziosa per Fenici, Caldei ed antichi Ebrei, il bisso del quale si narra fosse vestito il Re Salomone. La storia del bisso e delle fasi della sua lavorazione, vengono ampliamente illustrati, con esempi, nelle sale del Museo Etnografico, che abbiamo già visitato. Nelle mani di Chiara Vigo sopravvive la tradizione della tessitura del prezioso bisso, che ci ospita nel Museo del Bisso situato presso la sua abitazione in via Regina Margherita, al civico numero 168, a un centinaio di metri dalla piazza della Parrocchia in direzione della piazza Umberto.
Solo a Sant’Antioco, in tutto il Mediterraneo, sopravvive l’antica arte della Tessitura del bisso, la Seta di mare tanto preziosa per Fenici, Caldei ed antichi Ebrei, il bisso del quale si narra fosse vestito il Re Salomone. La storia del bisso e delle fasi della sua lavorazione, vengono ampliamente illustrati, con esempi, nelle sale del Museo Etnografico, che abbiamo già visitato. Nelle mani di Chiara Vigo sopravvive la tradizione della tessitura del prezioso bisso, che ci ospita nel Museo del Bisso situato presso la sua abitazione in via Regina Margherita, al civico numero 168, a un centinaio di metri dalla piazza della Parrocchia in direzione della piazza Umberto.
Della sua lavorazione ci parla Chiara Vigo l’ultima erede delle antiche tessitrici di bisso, che ne ha appreso il segreto dalla nonna e lo tramanderà a sua volta alla figlia Maddalena. Nel mare dell’isola cresce e si sviluppa, in fondali da 3 a 5 metri, la Pinna Nobilis Setacea, che solo a maggio è possibile sollevare dal fango per tagliarne il bioccolo di seta, facendolo possibilmente solo da animali anziani e nella quantità minima necessaria a tramandare la tradizione. La fibra viene dissalata nello stagno di Santa Caterina, la cui salinità è inferiore a quella marina, aggiungendo di tanto in tanto acqua dolce, in modo da non ridurre drasticamente la salinità per non irrigidirla, il che la renderebbe non più cardabile, e viene quindi asciugata all’ombra. Dalla cardatura con un cardo a spilli si ottiene una specie di bambagia setosa, scura al buio ma dorata alla luce del sole. Viene quindi filata ed il filato viene messo su una spola di canna, con la quale si passa alla tessitura, per la quale Chiara usa ancora oggi un telaio a tavola, che ci ricorda essere stato il modo più antico di tessere, perché la donna poteva portare la tavola sempre con se ovunque andasse. Il colore dorato dei tessuti più importanti si ottiene schiarendolo in un bagno di limone. Così Chiara ha fatto per il suo lavoro più noto, il Leone di Tiro, che ha dedicato a tutte le donne del mondo, al cui silenzioso lavoro nessuno da il giusto riconoscimento.
E nel salutare e ringraziare Chiara Vigo per il tempo che ci ha dedicato, ricordiamo i tanti riconoscimenti che ha ricevuto per la conservazione di un’arte antica che senza di lei sarebbe andata persa. Che porta avanti con amore, sempre disposta a realizzare e donare un suo lavoro a qualsiasi Museo che voglia esporlo per raccontare ai giovani le antiche tradizioni.
Il MuMA ossia Museo del Mare e dei Maestri d’Ascia

 Lungo il lungomare Cristofo Colombo, al civico numero 25, nell’edificio che ospitava il mattatoio di Sant’Antioco, oggi è presente il MuMA, ossia il Museo del Mare e dei Maestri d Ascia, che ha l’obiettivo di rivalutare il patrimonio culturale legato alla storia e alla figura dei Maestri d Ascia, valorizzandone l’eccellenza e conservandone la memoria attraverso le testimonianze dei protagonisti, raccolte negli oggetti in esposizione, e i racconti contenuti nei testi e nelle immagini. Per anni, in Sardegna, i Maestri d Ascia hanno progettato, costruito e riparato le imbarcazioni dedicate alla navigazione attorno all’isola. Cagliari, Stintino, Alghero, Carloforte, La Maddalena e Sant’Antioco ospitavano i più importanti cantieri dove venivano impostati gli scafi destinati alla pesca o al traffico locale. I Maestri d Ascia erano storicamente considerati dei professionisti di spicco all’interno dei vecchi cantieri navali, veri e propri esperti nello scegliere il legname più adatto con cui realizzare le imbarcazioni. La loro maestria consisteva nel saper adattare il ceppo di legno originale alla sua destinazione, sagomandolo con un attrezzo chiamato, appunto, ascia. L allestimento espositivo del MuMA un percorso esperienziale che racconta la laguna, i maestri d ascia e le segnalazioni in mare come fari, semafori e torri di vedetta, attraverso immagini, video e testi.
Lungo il lungomare Cristofo Colombo, al civico numero 25, nell’edificio che ospitava il mattatoio di Sant’Antioco, oggi è presente il MuMA, ossia il Museo del Mare e dei Maestri d Ascia, che ha l’obiettivo di rivalutare il patrimonio culturale legato alla storia e alla figura dei Maestri d Ascia, valorizzandone l’eccellenza e conservandone la memoria attraverso le testimonianze dei protagonisti, raccolte negli oggetti in esposizione, e i racconti contenuti nei testi e nelle immagini. Per anni, in Sardegna, i Maestri d Ascia hanno progettato, costruito e riparato le imbarcazioni dedicate alla navigazione attorno all’isola. Cagliari, Stintino, Alghero, Carloforte, La Maddalena e Sant’Antioco ospitavano i più importanti cantieri dove venivano impostati gli scafi destinati alla pesca o al traffico locale. I Maestri d Ascia erano storicamente considerati dei professionisti di spicco all’interno dei vecchi cantieri navali, veri e propri esperti nello scegliere il legname più adatto con cui realizzare le imbarcazioni. La loro maestria consisteva nel saper adattare il ceppo di legno originale alla sua destinazione, sagomandolo con un attrezzo chiamato, appunto, ascia. L allestimento espositivo del MuMA un percorso esperienziale che racconta la laguna, i maestri d ascia e le segnalazioni in mare come fari, semafori e torri di vedetta, attraverso immagini, video e testi.
La prossima tappa del nostro viaggio
Nella prossima tappa del nostro viaggio, racconteremo i resti archeologici presenti nell’isola di Sant’Antioco, per poi recarci a visitare le Coste e spiagge presenti sull’isola di Sant’Antioco ed appartenenti al comune di Sant’Antioco.
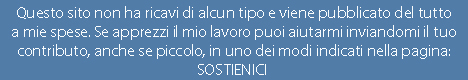
Tutte le foto e riprese sono state effettuate da privati a scopo amatoriale per uso personale e per motivi di studio, senza fini di lucro. Alle nostre foto della Sardegna, se ne aggiungono molte inviateci da amici, alcune tratte da wikipedia.org in base ai termini della GNU Free Documentation license, ed altre sono tratte da Internet. Alcune informazioni sulle descrizioni dei comuni sono tratte dal sito Italiapedia.it, informazioni sui siti archeologici da Tharros.info, foto sono tratte da Viaggioinsardegna.it, descrizoni e foto di Chiese dai siti Chiesedisardegna.weebly.com e Chiesecampestri.it, foto di stazioni ferroviarie dal sito Lestradeferrate.it, foto di impianti sportivi dal sito Sardegnasport.it, altre da siti differenti. Se viene segnalata l’eventuale violazione del copyright, provvederemo a rimuoverle. È consentito scaricare testi, foto e riprese dell’autore per uso privato senza eliminare i riferimenti. È vietato qualsiasi utilizzo commerciale del materiale pubblicato in assenza di apposita autorizzazione. Non è consentita la riproduzione delle foto e riprese di terzi, dei libri e di altro materiale non realizzato dall’autore. |
© Claudio de Tisi 2002-2023 - Codice Fiscale DTSCLD44M23F132W














































































































































































