Un sito di oltre 450 pagine che descrive tutta l’Isola e che pur non vendendo niente riceve da 300 a oltre 1400 visitatori ogni giorno

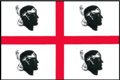

Usini con il suo centro e nei dintorni i siti archeologici con la tomba di Chercos e le necropoli tra cui quella di S’Elighe Entosu
In questa tappa del nostro viaggio, nel Logudoro Turritano ci recheremo a visitare Usini con il suo centro ed i suoi dintorni, con la tomba di Chercos e le necropoli tra le quali quella di S’Elighe Entosu.
La regione storica del Sassarese chiamata anche Logudoro Turritano
 Il Logudoro è stato, nel periodo medioevale, uno dei quattro Giudicati che ha avuto come capoluogo prima Porto Torres, in seguito Ardara, ed infine Sassari. Oggi possiamo dividere questa regione in tre parti: Logudoro Turritano, il cosiddetto Sassarese, a nord; il Logudoro Meilogu a ovest; ed il Logudoro Montacuto a est. Più in particolare, il Sassarese (nome in lingua sarda Su Tataresu) è tutta un’area con una forte impronta agropastorale, con splendidi panorami, dominati da rilievi d’origine vulcanica, ampi tratti pianeggianti, scarse foreste che interrompono le grandi distese di pascoli. L’antico popolamento della zona, territorio ideale per i popoli preistorici dal punto di vista ambientale, è testimoniato dai cospicui resti archeologici, cui si aggiungono alcuni notevoli monumenti medioevali. I comuni che fanno parte del Sassarese sono Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Monteleone Rocca Doria, Muros, Osilo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Romana, Sassari, Tissi, Uri, Usini, Villanova Monteleone. Oggi alcuni considerano in questa ragione anche Porto Torres, che però attribuiamo alla Nurra. Si parla il Sassarese o Turritano, una lingua romanza nata intorno al dodicesimo secolo da una base toscano corsa, evolutasi poi autonomamente con influenze liguri, iberiche e soprattutto sardo logudoresi.
Il Logudoro è stato, nel periodo medioevale, uno dei quattro Giudicati che ha avuto come capoluogo prima Porto Torres, in seguito Ardara, ed infine Sassari. Oggi possiamo dividere questa regione in tre parti: Logudoro Turritano, il cosiddetto Sassarese, a nord; il Logudoro Meilogu a ovest; ed il Logudoro Montacuto a est. Più in particolare, il Sassarese (nome in lingua sarda Su Tataresu) è tutta un’area con una forte impronta agropastorale, con splendidi panorami, dominati da rilievi d’origine vulcanica, ampi tratti pianeggianti, scarse foreste che interrompono le grandi distese di pascoli. L’antico popolamento della zona, territorio ideale per i popoli preistorici dal punto di vista ambientale, è testimoniato dai cospicui resti archeologici, cui si aggiungono alcuni notevoli monumenti medioevali. I comuni che fanno parte del Sassarese sono Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Monteleone Rocca Doria, Muros, Osilo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Romana, Sassari, Tissi, Uri, Usini, Villanova Monteleone. Oggi alcuni considerano in questa ragione anche Porto Torres, che però attribuiamo alla Nurra. Si parla il Sassarese o Turritano, una lingua romanza nata intorno al dodicesimo secolo da una base toscano corsa, evolutasi poi autonomamente con influenze liguri, iberiche e soprattutto sardo logudoresi.
In viaggio verso Usini
Da Sassari, dalla piazza Santa Maria di Betlem prendiamo in direzione sud ovest ed imbocchiamo la via dei Gremi. Dopo 350 metri, alla rotonda che incontriamo, imbocchiamo la SP15M, che è la strada provinciale che collega Sassari a Ittiri. La seguiamo per sette chilometri e mezzo, dopo di che troviamo sulla sinistra l’uscita verso Usini, che raggiungiamo a circa dieci chilometri dal centro di Sassari.
Il comune chiamato Usini

 Il comune chiamato Usini (nome in lingua sarda Ùsini, altezza metri 200 sul livello del mare, abitanti 4.222 al 31 dicembre 2021) costituisce un importante centro agricolo, che si trova immerso in un paesaggio che si presenta con abbondanti coltivazioni. Il territorio comunale presenta un profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche accentuate, che vanno da un minimo di 36 a un massimo di 287 metri sul livello del mare. Il paesaggio circostante presenta oliveti, carciofaie e rigogliosi vigneti, il cui prodotto è da sempre motivo di orgoglio per i viticoltori usinesi. Il clima di Usini tipicamente mediterraneo, le estati sono calde e gli inverni miti ed umidi.
Il comune chiamato Usini (nome in lingua sarda Ùsini, altezza metri 200 sul livello del mare, abitanti 4.222 al 31 dicembre 2021) costituisce un importante centro agricolo, che si trova immerso in un paesaggio che si presenta con abbondanti coltivazioni. Il territorio comunale presenta un profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche accentuate, che vanno da un minimo di 36 a un massimo di 287 metri sul livello del mare. Il paesaggio circostante presenta oliveti, carciofaie e rigogliosi vigneti, il cui prodotto è da sempre motivo di orgoglio per i viticoltori usinesi. Il clima di Usini tipicamente mediterraneo, le estati sono calde e gli inverni miti ed umidi.
Questo paese fa parte dell’Associazione nazionale delle città dell’Olio
 Questo paese fa parte dell’Associazione nazionale città dell’Olio, che ha tra i suoi compiti principali quello di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità, tutelare e promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell’olivicoltura, e garantire il consumatore attraverso le denominazioni di origine. Le città dell’Olio in Sardegna sono ad oggi Alghero, Berchidda, Bolotana, Bosa, Cuglieri, Dolianova, Escolca, Genuri, Gergei, Giba, Gonnosfanadiga, Ilbono, Ittiri, Masainas, Olbia, Oliena, Orgosolo, Orosei, Osini, Riola Sardo, Samatzai, Santadi, Seneghe, Serrenti, Siddi, Sini, Uri, Usini, Ussaramanna, Vallermosa, Villacidro, Villamassargia.
Questo paese fa parte dell’Associazione nazionale città dell’Olio, che ha tra i suoi compiti principali quello di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità, tutelare e promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell’olivicoltura, e garantire il consumatore attraverso le denominazioni di origine. Le città dell’Olio in Sardegna sono ad oggi Alghero, Berchidda, Bolotana, Bosa, Cuglieri, Dolianova, Escolca, Genuri, Gergei, Giba, Gonnosfanadiga, Ilbono, Ittiri, Masainas, Olbia, Oliena, Orgosolo, Orosei, Osini, Riola Sardo, Samatzai, Santadi, Seneghe, Serrenti, Siddi, Sini, Uri, Usini, Ussaramanna, Vallermosa, Villacidro, Villamassargia.
Questo paese fa parte dell’Associazione nazionale Città del Vino
 Questo paese fa parte dell’Associazione nazionale Città del Vino, il cui obiettivo è quello di aiutare i Comuni a sviluppare intorno al vino, ai prodotti locali ed enogastronomici, tutte quelle attività e quei progetti che permettono una migliore qualità della vita, uno sviluppo sostenibile, più opportunità di lavoro. Le Città del Vino in Sardegna sono ad oggi Alghero, Ardauli, Arzachena, Atzara, Badesi, Benetutti, Berchidda, Bonnanaro, Bono, Bosa, Calangianus, Dolianova, Donori, Dorgali, Galtellì, Jerzu, Loceri, Lotzorai, Luogosanto, Luras, Meana Sardo, Modolo, Monti, Neoneli, Olbia, Oliena, Riola Sardo, Samugheo, San Niccolò di Arcidano, Sant’Antioco, Selargius, Sennori, Serdiana, Sorgono, Sorso, Tempio Pausania, Terralba, Tissi, Uri, Urzulei, Usini.
Questo paese fa parte dell’Associazione nazionale Città del Vino, il cui obiettivo è quello di aiutare i Comuni a sviluppare intorno al vino, ai prodotti locali ed enogastronomici, tutte quelle attività e quei progetti che permettono una migliore qualità della vita, uno sviluppo sostenibile, più opportunità di lavoro. Le Città del Vino in Sardegna sono ad oggi Alghero, Ardauli, Arzachena, Atzara, Badesi, Benetutti, Berchidda, Bonnanaro, Bono, Bosa, Calangianus, Dolianova, Donori, Dorgali, Galtellì, Jerzu, Loceri, Lotzorai, Luogosanto, Luras, Meana Sardo, Modolo, Monti, Neoneli, Olbia, Oliena, Riola Sardo, Samugheo, San Niccolò di Arcidano, Sant’Antioco, Selargius, Sennori, Serdiana, Sorgono, Sorso, Tempio Pausania, Terralba, Tissi, Uri, Urzulei, Usini.
Origine del nome
Nei documenti antichi il suo nome compare quasi sempre come Usune. Esso è quasi certamente di origine sardiana o protosarda e trova riscontro negli altri nomi Osinavà o Usinavá. Trova anche riscontro nel nome etrusco Usuna. Nel Condaghe di San Pietro di Silki compare come Urin, che probabilmente è da leggere Usin. Alcuni studiosi ritengono che sia da rintracciare nella voce fenicia Uz che indica una fortezza ricca. Il villaggio, appartenente al Giudicato e alla diocesi di Torres, è citato molto per tempo e numerose volte nei documenti medievali e cioè nei Condaghi di Silki e di Trullas, nel Codice Diplomatico delle relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna, nel Codex Diplomaticus Sardiniae. Inoltre figura tra le parrocchie della diocesi di Torres che nella metà del quattrodicesimo secolo versavano le decime alla curia romana. E risulta anche nella Chorographia Sardiniae di Giovanni Francesco Fara come oppidum Usinis.
La sua economia
Il settore primario, che svolge tuttora un ruolo importante nell’economia locale, presente con la coltivazione di cereali, frumento, ortaggi, foraggi, uva da vino, ulivi e frutteti e con l’allevamento di suini, ovini, equini e avicoli. L’economia è, infatti, caratterizzata da un’agricoltura specializzata, con oliveti, carciofaie e rigogliosi vigneti. La sua produzione vinicola vanta, tra gli altri, vini come il Cagnulari, il Cannonau e il Vermentino Usinese, dal gusto deciso e generoso. L’industria , invece, poco sviluppata, dato che le poche aziende presenti operano solamente nei comparti alimentare, edile e della lavorazione del legno. Il terziario non assume dimensioni rilevanti. Sebbene non registri un significativo movimento di turisti, offre a quanti vi si rechino la possibilità di effettuare piacevoli escursioni, godendo dell’aria salubre e delle bellezze dell’ambiente naturale, poco distante da interessanti siti archeologici di età nuragica. L’apparato ricettivo offre possibilitàdi ristorazione ma non di soggiorno. A Usini, soprattutto negli ultimi anni, è iniziato un costante processo di rivalutazione delle tradizioni, delle produzioni enogastronomiche locali e di salvaguardia della loro specificità.
Brevi cenni storici
Le testimonianze più antiche di insediamenti umani riferibili al territorio comunale di Usini risalgono al neolitico recente e sono ascrivibili a quel variegato e complesso insieme di manifestazioni culturali comunemente denominato cultura di Ozieri. Il territorio conosce col tempo altre vicissitudini. Si tratta di alcuni stanziamenti del periodo di dominazione punica e di numerosi insediamenti di etàromana repubblicana e imperiale. Tracce evidenti di abitati sorti in etàpunica e romana sono desumibili dai materiali archeologici rinvenuti sul territorio. Anche il sito nel quale nasce e si sviluppa il primordiale villaggio di Usini di origine antichissima, come dimostrano il materiale litico ed i manufatti ceramici di etàromana e medioevale rinvenuti nell’area che costituisce indubbiamente la parte più antica dell’abitato. In epoca medievale appartiene al Giudicato di Torres e viene annesso alla Curatoria di Coros, con altri villaggi. Quando avviene lo spopolamento e il progressivo abbandono dei villaggi confinanti, Usini riesce comunque a sopravvivere, resistendo alle micidiali epidemie di peste che falcidiano i Sardi del Medioevo. Tutto ci grazie alla proverbiale caparbiet dei suoi abitanti e alla loro incrollabile fede religiosa, che li conduce, tra il dodicesimo ed il tredicesimo secolo, sotto la spinta dei monaci benedettini inviati in Sardegna su richiesta dei Giudici di Torres, alla edificazione di numerose Chiese. Nel 1259, alla morte di Adelasia di Torres, i suoi territori entrano a far parte dei possedimenti dei Doria, signoria che regge il governo locale fino al quindicesimo secolo, quando passa sotto il controllo aragonese.  Durante la dominazione spagnola, nel 1421 il villaggio di Usini viene concesso in feudo da Alfonso V d’Aragona al nobile valenzano Galcerando Centelles, altrimenti chiamato Bernardo di Rivosecco, con il titolo di barone di Osilo. La Baronia di Osilo comprendeva a quel tempo, oltre al Castello e al borgo di Osilo, anche i villaggi di Usini, Ittiri, Ossi, Tissi, Muros ed Uri. Nel 1544 i Cedrelles cedono la Baronia di Usini e Tissi a don Giacomo Manca.
Durante la dominazione spagnola, nel 1421 il villaggio di Usini viene concesso in feudo da Alfonso V d’Aragona al nobile valenzano Galcerando Centelles, altrimenti chiamato Bernardo di Rivosecco, con il titolo di barone di Osilo. La Baronia di Osilo comprendeva a quel tempo, oltre al Castello e al borgo di Osilo, anche i villaggi di Usini, Ittiri, Ossi, Tissi, Muros ed Uri. Nel 1544 i Cedrelles cedono la Baronia di Usini e Tissi a don Giacomo Manca.  A partire dal 1643, la Baronia di Usini viene trasformata nella Contea di San Giorgio, dal nome della chiesa campestre di San Giorgio di Oleastreto. Le pesanti tasse imposte dal duca dell’Asinara don Antonio Manca Amat portano i paesi del Logudoro alla ribellione, ed anche il Magazzino del Fattore baronale di Usini viene assalito più volte dai contadini usinesi negli anni della rivolta antifeudale per protestare contro i soprusi del duca. Rifiutandosi di pagare i balzelli feudali, gli Usinesi partecipano alla rivolta angioiana nel 1795 che porta all’assalto di Sassari. A don Vincenzo Manca Amat, duca dell’Asinara e di Vallombrosa, nel 1839 i suoi territori, ed in particolare anche Usini, vengono riscattati a seguito della soppressione del sistema feudale. Nella seconda met dell’Ottocento, dopo il riscatto delle aree feudali, il territorio di Usini viene frazionato in lotti da due ettari ciascuno, che vengono assegnati ai privati mediante atto di estrazione a sorte. Viene cos soppressa la forma di gestione comunitaria della terra, che da secoli aveva caratterizzato l’economia agraria dell’Isola.
A partire dal 1643, la Baronia di Usini viene trasformata nella Contea di San Giorgio, dal nome della chiesa campestre di San Giorgio di Oleastreto. Le pesanti tasse imposte dal duca dell’Asinara don Antonio Manca Amat portano i paesi del Logudoro alla ribellione, ed anche il Magazzino del Fattore baronale di Usini viene assalito più volte dai contadini usinesi negli anni della rivolta antifeudale per protestare contro i soprusi del duca. Rifiutandosi di pagare i balzelli feudali, gli Usinesi partecipano alla rivolta angioiana nel 1795 che porta all’assalto di Sassari. A don Vincenzo Manca Amat, duca dell’Asinara e di Vallombrosa, nel 1839 i suoi territori, ed in particolare anche Usini, vengono riscattati a seguito della soppressione del sistema feudale. Nella seconda met dell’Ottocento, dopo il riscatto delle aree feudali, il territorio di Usini viene frazionato in lotti da due ettari ciascuno, che vengono assegnati ai privati mediante atto di estrazione a sorte. Viene cos soppressa la forma di gestione comunitaria della terra, che da secoli aveva caratterizzato l’economia agraria dell’Isola.
Personaggi famosi nati a Usini
Verso la fine del diciottesimo secolo, nelle campagne del Logudoro e in altre zone del Sassarese avvengono sanguinosi episodi conflittualità, culminati nelle tragiche vicende che hanno come protagonista il bandito Francesco Derosas.
Le principali feste e sagre che si svolgono a Usini
A Uri svolgono la loro attività, tra gli altri, il Gruppo Folk San Giorgio di Usini, il Gruppo Folk Maria Bambina di Usini, il Coro di Usini, il Coro Logudoro di Usini, nelle cui esibizioni nel paese ed in altre località dell’isola è possibile ammirare il costume tradizionale degli uomini e delle donne di Usini.
Tra le principali feste e sagre che si svolgono a Usini vanno citati l’1 maggio, la Festa di San Giorgio nella chiesa di San Giorgio di Oleastreto; sempre a maggio il Concorso Enologico; a fine luglio, la Sagra de Sos Andarinos, un particolare tipo di pasta fatta a mano; da metà luglio a metà settembre, la Sagra E...state a Usini; ad agosto, il Festival Internazionale del Folklore A Manu Tenta; l’8 settembre, la Festa in onore di Santa Maria Bambina; a dicembre, la degustazione itinerante Ajò a Ippuntare, ossia andiamo a spillare, che è un significativo evento dedicato alla degustazione dei vini novelli dei produttori locali.
Il recupero del centro storico del paese
Negli ultimi anni sulle pareti delle case del paese sono stati realizzati pregevoli murales, dei quali la maggior parte opera dell’artista Pina Monne, la muralista più nota in tutta la Sardegna, di cui ha decorato con i suoi murales numerosi paesi.
Visita del centro di Usini
L’abitato, interessato da forte espansione edilizia, è circondato da lievi colline coperte di vigneti e oliveti. Un ordinato sistema viario consente di osservare nel suo centro storico costruzioni civili di architettura essenziale che rivelano le origini contadine dei suoi abitanti. Provenendo da Sassari entriamo in Usini, prendiamo lo svincolo a destra dalla SP15M che, in duecentocinquanta metri dal cartello segnaletico che indica l’ingresso all’interno dell’abitato, ci porta a una rotonda, dopo la quale prosegue verso sud la via Enrico Berlinguer, mentre a destra e sinistra ci si immette sulla via San Giorgio.
Il Campo Sportivo di Usini
Passato il cartello segnaletico che indica l’ingresso nell’abitato, seguiamo la strada verso la rotonda e, dopo appena circa centocinquanta metri, troviamo la deviazione in un’area di sosta alla destra della strada, dalla quale si arriva all’ingresso del Campo Sportivo Comunale Peppino Sau. Si tratta di un campo da calcio ad 11 con fondo in erba sintetica, dotato di tribune in grado di ospitare un migliaio di spettatori.
La struttura è utilizzata principalmente da quattro società locali per il gioco del calcio. La principale squadra di calcio della cittàl’U.S.D. Usinese 1961, nata nel 1961, i cui colori sociali sono il rosso e il blu, che milita nel girone B sardo di Promozione.
L’Azienda Vitivinicola Chessa con due vini inseriti nella guida 5StarWines di Vinitaly
Dallo svincolo, arrivati alla rotonda prendiamo la prima uscita che ci porta sulla via San Giorgio la quale si dirige in direzione ovest, e quasi subito, alla destra della strada, si trova l’edifico che ospita l’Azienda Vitivinicola Chessa di Usini.
In via San Giorgio si trova il murale intitolato La Cantina
 Dallo svicolo, arrivati alla rotonda prendiamo la terza uscita che ci porta sulla via San Giorgio la quale si dirige in direzione est, la seguiamo per circa un centinaio di metri, ed arriviamo nel punto dove parte a sinistra la via Emilio Lussu. Proprio di fronte alla via Emilio Lussu, alla destra della via San Giorgio, sulla parete di una casa privata si trova il murale intitolato La Cantina. L’opera si articola dentro una cornice che inquadra una finta architettura, ed all’interno del cortile sono raffigurate delle figure maschili intente a preparare il vino. Il murale è stato realizzato nel 2012 dall’artista Pina Monne, la muralista più nota in Sardegna nata a Irgoli in provincia di Nuoro nel 1971. Il suo lavoro si traduce in una rappresentazione dei valori identitari della comunità di Usini. In particolare, si riferisce ad attività e mestieri locali descritti attraverso una raffigurazione immediata, forse troppo monumentale e retorica, volta ad esaltare le tipicità locali.
Dallo svicolo, arrivati alla rotonda prendiamo la terza uscita che ci porta sulla via San Giorgio la quale si dirige in direzione est, la seguiamo per circa un centinaio di metri, ed arriviamo nel punto dove parte a sinistra la via Emilio Lussu. Proprio di fronte alla via Emilio Lussu, alla destra della via San Giorgio, sulla parete di una casa privata si trova il murale intitolato La Cantina. L’opera si articola dentro una cornice che inquadra una finta architettura, ed all’interno del cortile sono raffigurate delle figure maschili intente a preparare il vino. Il murale è stato realizzato nel 2012 dall’artista Pina Monne, la muralista più nota in Sardegna nata a Irgoli in provincia di Nuoro nel 1971. Il suo lavoro si traduce in una rappresentazione dei valori identitari della comunità di Usini. In particolare, si riferisce ad attività e mestieri locali descritti attraverso una raffigurazione immediata, forse troppo monumentale e retorica, volta ad esaltare le tipicità locali.
L’Istituto Comprensivo Grazia Deledda con i suoi impianti sportivi
 Dallo svicolo, arrivati alla rotonda abbiamo preso la terza uscita che ci ha portati sulla via San Giorgio. La seguiamo per circa centocinquanta metri e troviamo alla sinistra della strada, in corrispondenza del civico numero 1 della via San Giorgio, l’ingresso dell’Istituto Comprensivo Grazia Deledda, che comprende due plessi di Scuola dell’Infanzia, due plessi di Scuola Primaria e due plessi di Scuola Secondaria di primo grado. All’interno di questo complesso scolastico è presente una Palestra, nella quale si trova un Campo sportivo polivalente, che non è dotato di tribune per gli spettatori, e nel quale è possibile praticare come discipline la Ginnastica, la pallacanestro ed il Mini basket, la pallavolo.
Dallo svicolo, arrivati alla rotonda abbiamo preso la terza uscita che ci ha portati sulla via San Giorgio. La seguiamo per circa centocinquanta metri e troviamo alla sinistra della strada, in corrispondenza del civico numero 1 della via San Giorgio, l’ingresso dell’Istituto Comprensivo Grazia Deledda, che comprende due plessi di Scuola dell’Infanzia, due plessi di Scuola Primaria e due plessi di Scuola Secondaria di primo grado. All’interno di questo complesso scolastico è presente una Palestra, nella quale si trova un Campo sportivo polivalente, che non è dotato di tribune per gli spettatori, e nel quale è possibile praticare come discipline la Ginnastica, la pallacanestro ed il Mini basket, la pallavolo.
La chiesa della Santa Croce chiamata anche della Madonna de S’Ena Frisca
Passato il civico numero 1 della via San Giorgio raggiungiamo un’altra rotonda, dove prendiamo la terza uscita che ci porta nella via Roma la quale si dirige verso nord. Percorsa appena una cinquantina di metri lungo la via Roma troviamo, alla destra della strada, l’antichissima Chiesa della Santa Croce, nota anche come Chiesa di Santa Maria di Usune o anche Chiesa di Santa Maria del Cimitero, che è stata per secoli la chiesa parrocchiale del paese. Edificata sotto l’invocazione della Madonna di S’Ena Frisca, della sorgente fresca, viene per questo chiamata comunemente dagli usinesi con il nome di Chiesa della Madonna de S’Ena Frisca. L’edificio è ubicato vicino al complesso scolastico ed a pochi metri di distanza dalla parrocchiale ed ha subito in seguito parecchi rifacimenti. La sua data di costruzione incerta, ma a detta di coloro che hanno eseguito i lavori di restauro, su un concio della parete esterna della prima costruzione, vi era incisa la data del 1150. La costruzione sarebbe avvenuta in diversi tempi. La prima risale al dodicesimo secolo, quando era una piccola cappella rettangolare, che i monaci cistercensi dell’abbazia di Paulis, avevano costruito come punto di appoggio durante il viaggio per Sassari. La chiesa nella parte del presbiterio e dell’abside, presenta elementi che fanno pensare ad una costruzione nel quattordicesimo secolo, quando l’edificio, realizzato in conci di pietra calcarea, costituito da abside, presbiterio e sacrestia e navata centrale, con cappelle laterali.
La facciata a capanna si presenta sobria e con semplici forme geometriche. Il quadrato di base e il triangolo del timpano, sono raccordati da una cornice. Il portale presenta stipiti sagomati e nella parte superiore, coronato da un architrave su mensole di foggia classica e sormontato da un arco a tutto sesto. La superficie definita da due pilastri d angolo divisi da uno zoccolo in conci. Ad abbellire l’edificio, si trova una serie di archetti pensili ciechi a sesto acuto, con peducci sagomati decorati, inseriti sotto gli spioventi corniciati dal timpano. Il campanile, ricavato in un lato del presbiterio, svetta sull’edificio ed composto da una canna quadrata, divisa in tre parti da cornici marcapiano. Gli archi delle campane hanno una struttura a tutto sesto, e la cella campanaria risulta chiusa da una cupola emisferica e adornata da una cornice mediana.
Di particolare interesse risultano gli arredi all’interno della chiesa, come ad esempio l’altare maggiore in legno policromo, proveniente dall’Oratorio del Rosario, di stile barocco nei colori predominanti dell’azzurro e dell’oro, che ospita il simulacro della Madonna della Misericordia. Sono degni di nota anche l’altare di San Giorgio, risalente al diciassettesimo o diciottesimo secolo, in legno e decorato di verde e oro. L altare del Crocifisso, del diciottesimo secolo, proveniene dall’antico Oratorio di Santa Croce. Si segnala inoltre la presenza dello splendido pulpito ligneo proveniente dalla chiesa delle Monache Isabelliane di Sassari, arrivato a Usini dopo la soppressione dell’ordine nel 1855. Le pareti della chiesa ospitano numerosi dipinti, tra cui quattordici olii su tela, raffiguranti la Via Crucis e attribuibili ad un ignoto pittore piemontese del diciannovesimo secolo.
I sotterranei della chiesa sono stati usati come Cimitero. Attraverso una botola si accedeva ad un Oratorio interno, detto Cappella di purgatorio, dove ogni lunedì si scendeva in processione cantando il miserere in memoria dei defunti.
Il Complesso Sportivo di Santa Croce
Alla sinistra della chiesa è presente anche il Complesso Sportivo di Santa Croce, nel quale si trova un Campo da calcetto, dotato di tribune in grado di ospitare un centinaio di spettatori, dove è possibile praticare il Calcetto ossia il Calcio a cinque.
In via Roma si trova il murale intitolato Sos Andarinos
 Proseguendo con la via Roma, dopo una ventina di metri vediamo a destra partire la via Giuseppe Mazzini. subito prima della via Giuseppe Mazzini, sull’edificio all0 destra della via Roma sulla parete di una casa privata si trova il murale intitolato Sos Andarinos, che descrive la lavorazione artigianale di pasta tipica locale chiamata appunto Sos Andarinos. L’opera si articola dentro una cornice di pietra lunettata entro la quale una donna e due bambine, sull’uscio, mettono ad essicare la pasta lavorata artigianalmente. Una donna in costume tradizionale sardo assiste alla scena da un balcone. Il murale è stato realizzato dall’artista Pina Monne, la muralista più nota in Sardegna, e fa parte di una serie di murales realizzati da Pina Monne, su commissione del Comune a partire dal 2008. Il suo lavoro si traduce in una rappresentazione dei valori identitari della comunità di Usini. In particolare, si riferisce ad attività e mestieri locali descritti attraverso una raffigurazione immediata, forse troppo monumentale e retorica, volta ad esaltare le tipicità locali.
Proseguendo con la via Roma, dopo una ventina di metri vediamo a destra partire la via Giuseppe Mazzini. subito prima della via Giuseppe Mazzini, sull’edificio all0 destra della via Roma sulla parete di una casa privata si trova il murale intitolato Sos Andarinos, che descrive la lavorazione artigianale di pasta tipica locale chiamata appunto Sos Andarinos. L’opera si articola dentro una cornice di pietra lunettata entro la quale una donna e due bambine, sull’uscio, mettono ad essicare la pasta lavorata artigianalmente. Una donna in costume tradizionale sardo assiste alla scena da un balcone. Il murale è stato realizzato dall’artista Pina Monne, la muralista più nota in Sardegna, e fa parte di una serie di murales realizzati da Pina Monne, su commissione del Comune a partire dal 2008. Il suo lavoro si traduce in una rappresentazione dei valori identitari della comunità di Usini. In particolare, si riferisce ad attività e mestieri locali descritti attraverso una raffigurazione immediata, forse troppo monumentale e retorica, volta ad esaltare le tipicità locali.
La chiesa parrocchiale della Natività di Santa Maria Vergine o di Santa Maria Bambina
Proseguendo lungo la via Roma che ci porta nel centro del paese, a un centinaio di metri dalla chiesa della Santa Croce troviamo alla sinistra della strada la Chiesa della Natività di Santa Maria Vergine o anche Chiesa di Santa Maria Bambina, che è la parrocchiale di Usini, affacciata sulla piazza della Conciliazione che si sviluppa alla destra della strada. Dove oggi sorge la chiesa parrocchiale della Natività di Santa Maria Vergine, sorgeva un tempo la chiesa di San Pietro, la prima chiesa parrocchiale di Usini, citata nei Condaghi di San Pietro in Silki e di San Nicola di Trullas per le donazioni di terre che le furono fatte nel dodicesimo secolo. Sembrerebbe che questa chiesa fino dal Settecento fosse inserita in un complesso ecclesiastico nel quale sorgevano anche i due Oratori di Santa Croce e del Santissimo Rosario, forse comunicanti con la chiesa, al servizio delle due Confraternite. Ma poi era caduta in rovina, e nei primi decenni dell’Ottocento, è stata demolita per lasciare spazio alla costruzione della attuale chiesa parrocchiale, dedicata alla Natività di Maria Vergine, che è stata aperta al culto nel 1825. Della chiesa di San Pietro restano solo alcuni riferimenti, desumibili da fonti storiche, ma non si sono trovate tracce dei ruderi e non si conosce la data della sua costruzione, ma si suppone fosse contemporanea della vecchia chiesa di S’Ena Frisca.
Edificata in stile tardo barocco, l’attuale chiesa parrocchiale è caratterizzata da una alternanza di linee concave e convesse, che movimentano la facciata. La facciata, suddivisa in due registri compositivi, ha una parte inferiore delimitata agli angoli da lesene e chiusa da una trabeazione aggettante. Al centro, anche il portone d’ingresso è incorniciato da lesene, sormontate da un timpano curvilineo. Al centro del registro superiore si apre una finestra centinata. La costruzione del campanile, progettato per essere costruito alla sinistra della facciata, a causa della mancanza di roccia è stata sospesa. Sarà costruito nel 1900 alla destra della facciata.
L’interno dell’edificio, a un unica navata, presenta l’abside con cupola che copre il presbiterio ed è dotato di sei cappelle laterali. L’altare maggiore è appoggiato alla parete dell’abside, costruito in pietra e rifinito con stucchi e nicchia al centro, dove si trova la statua di Santa Maria de S’Ena Frisca, la cui denominazione si deve ad un culto locale per la Vergine. Ka statua raffigura la Madonna con capo e mani in legno intagliato e montati su un corpo costituito da supporti in ferro e legno rivestiti di ovatta, e con abiti in stoffa. Realizzata da un intagliatore sardo assai rozzo ed incolto, appartiene al genere delle statue manichino di tradizione ispanica, assai diffuso nell’isola tra la seconda metà del Settecento e la prima metà dell’Ottocento. Tra gli arredi presenti all’interno della chiesa, risultano particolarmente interessanti i due altari gemelli della Madonna del Carmelo e di Santa Anastasia. Il primo altare, donato alla chiesa della Natività nel 1857, presenta forme architettoniche classicheggianti successive al barocco. Anche l’acquasantiera in marmo è di notevole pregio, reca infatti un’iscrizione del 1599 fatta apporre dal pievano Matheus Vargius. Il pavimento della chiesa è in mattoni di ardesia.
La più importate festa religiosa del paese è la festa patronale in onore di Santa Maria Bambina, che si svolge ogni anno l’8 settembre e che esercita un importante richiamo per la popolazione, con le celebrazioni caratterizzata, dopo le cerimonie religiose, da una processione attraverso le vie del centro.
Affacciati sulla piazza Conciliazione i resti del Magazzino del Fattore divenuto poi il Monte Granatico
 Nella piazza della Conciliazione, che è ubicata di fronte alla parrocchiale, sul lato sinistro guardando la facciata della chiesa, rimangono i resti di un antico fabbricato che, nonostante sia da anni abbandonato a se stesso, sembra sopportare bene il suo carico di storia. Si tratta di un edificio chiuso chiamato il Magazzino del Fattore, ossia Su Magasinu 'e Su Fattore, che veniva utilizzato come deposito dal fattore baronale, ed è situato sulla via Roma, quasi di fronte alla chiesa di Santa Maria facendo angolo con la via Gabriele D'Annunzio. L’edificio è stato assalito più volte dai contadini usinesi negli anni della rivolta antifeudale per protestare contro i soprusi del duca dell’Asinara don Antonio Manca, marchese di Mores e signore di Usini.
Nella piazza della Conciliazione, che è ubicata di fronte alla parrocchiale, sul lato sinistro guardando la facciata della chiesa, rimangono i resti di un antico fabbricato che, nonostante sia da anni abbandonato a se stesso, sembra sopportare bene il suo carico di storia. Si tratta di un edificio chiuso chiamato il Magazzino del Fattore, ossia Su Magasinu 'e Su Fattore, che veniva utilizzato come deposito dal fattore baronale, ed è situato sulla via Roma, quasi di fronte alla chiesa di Santa Maria facendo angolo con la via Gabriele D'Annunzio. L’edificio è stato assalito più volte dai contadini usinesi negli anni della rivolta antifeudale per protestare contro i soprusi del duca dell’Asinara don Antonio Manca, marchese di Mores e signore di Usini.
In seguito il Magazzino del Fattore perde la sua funzionalità, e l’edificio viene adibito durante il regno di Carlo Emanuele III, con una legge del ministro Giovanni Battista Lorenzo Bogino, a casa del Monte Granatico. L’istituzione dei Monti Granatici o Frumentari in Sardegna ha origini antichissime, ma il loro uso è stato largamente ripreso nel tardo settecento. I Monti venivano utilizzati come scorta di sementi in favore degli agricoltori più poveri e maggiormente colpiti dalle carestie.
Affacciato sulla piazza Conciliazione ad angolo con la via Roma i resti della Casa del Pievano
 Poco distante dal precedente, sull’altro lato della piazza della Conciliazione, e quindi sul lato destro gardando la facciata della chiesa, si trova un altro palazzo che è conosciuto come la Casa del Pievano, ossia Sa Domu 'e Su Frebanu, che era la vecchia casa parrocchiale. Si tratta di un edificio storico del diciassettesimo secolo affacciato sulla piazza, ancora ben conservato, ed il cui ingresso si trova sulla via Roma al civico numero 44. Sulle sue mura esterne, fino ad anni addietro, era ancora possibile vedere lo stemma della famiglia di don Antonio Manca, marchese di Mores e signore di Usini, che con ogni probabilità fece costruire il fabbricato.
Poco distante dal precedente, sull’altro lato della piazza della Conciliazione, e quindi sul lato destro gardando la facciata della chiesa, si trova un altro palazzo che è conosciuto come la Casa del Pievano, ossia Sa Domu 'e Su Frebanu, che era la vecchia casa parrocchiale. Si tratta di un edificio storico del diciassettesimo secolo affacciato sulla piazza, ancora ben conservato, ed il cui ingresso si trova sulla via Roma al civico numero 44. Sulle sue mura esterne, fino ad anni addietro, era ancora possibile vedere lo stemma della famiglia di don Antonio Manca, marchese di Mores e signore di Usini, che con ogni probabilità fece costruire il fabbricato.
In via Roma la Casa Derosas con il Centro documentale Casa Derosas
 Dalla piazza della Conciliazione prendiamo la via Roma verso est. Una quarantina di metri più avanti, sul lato della strada sul quale è affacciata la casa del Pievano, prima del civico numero 36, si trova il palazzo signorile che prende il nome di Casa Derosas, risalente alla fine dell’Ottocento o ai primi anni del Novecento, un tempo abitazione di Achille Derosas, uno dei principali proprietari terrieri del paese e primo sindaco di Usini. La struttura della casa, costruita da maestranze di Bosa che le conferirono alcuni suggestivi elementi architettonici, tra i quali spicca la nicchia decorata ad archi che si trova all’ingresso, è suddivisa in due piani abitabili e presenta un seminterrato utilizzato come cantina, scavato nella roccia. Al suo interno si possono ammirare alcuni affreschi su volte e pareti con ritratti, scene mitologiche e paesaggi. Recentemente l’edificio è stato oggetto di un completo restauro, eseguito al fine di riportare la casa al suo aspetto originario.
Dalla piazza della Conciliazione prendiamo la via Roma verso est. Una quarantina di metri più avanti, sul lato della strada sul quale è affacciata la casa del Pievano, prima del civico numero 36, si trova il palazzo signorile che prende il nome di Casa Derosas, risalente alla fine dell’Ottocento o ai primi anni del Novecento, un tempo abitazione di Achille Derosas, uno dei principali proprietari terrieri del paese e primo sindaco di Usini. La struttura della casa, costruita da maestranze di Bosa che le conferirono alcuni suggestivi elementi architettonici, tra i quali spicca la nicchia decorata ad archi che si trova all’ingresso, è suddivisa in due piani abitabili e presenta un seminterrato utilizzato come cantina, scavato nella roccia. Al suo interno si possono ammirare alcuni affreschi su volte e pareti con ritratti, scene mitologiche e paesaggi. Recentemente l’edificio è stato oggetto di un completo restauro, eseguito al fine di riportare la casa al suo aspetto originario.
Il palazzo, acquisito dal comune di Usini, oggi è sede del Centro documentale Casa Derosas, gestito attualmente dall’Associazione Culturale Sardòs, per raccogliere tutte quelle testimonianze materiali che fanno parte del patrimonio etnografico locale.
Al termine della via Roma si apre la piazza Castello

 Proseguendo lungo la via Roma, al termine della strada, al suo angolo destro, si trovano i resti della bella Fontana di via Roma. Passata la fontana, al termine della strada arriviamo in Piazza Castello, che si sviluppa verso sinistra, e che costituisce il cuore del centro abitato. Si tratta di una bella piazza rettangolare alberata. Antichissime origini doveva avere il Casteddu, il castello che dominava il villaggio in periodo medioevale, del quale si ha memoria soltanto nel nome della piazza principale dell’attuale abitato di Usini. Solo successivamente, dalla seconda met del diciottesimo secolo, si sono sviluppati nuovi quartieri attorno all’odierna piazza Castello, ossia attorno al castello.
Proseguendo lungo la via Roma, al termine della strada, al suo angolo destro, si trovano i resti della bella Fontana di via Roma. Passata la fontana, al termine della strada arriviamo in Piazza Castello, che si sviluppa verso sinistra, e che costituisce il cuore del centro abitato. Si tratta di una bella piazza rettangolare alberata. Antichissime origini doveva avere il Casteddu, il castello che dominava il villaggio in periodo medioevale, del quale si ha memoria soltanto nel nome della piazza principale dell’attuale abitato di Usini. Solo successivamente, dalla seconda met del diciottesimo secolo, si sono sviluppati nuovi quartieri attorno all’odierna piazza Castello, ossia attorno al castello.
Nella piazza Castello si affaccia la Corte di Casa Diaz
Sulla piazza Castello si affaccia la Corte di Casa Diaz, realizzata nel 1874 dal proprietario terriero Giuseppe Derosas, e successivamente ampliata dalla famiglia Diaz, grazie al matrimonio tra don Giovanni Antonio Diaz e donna Giovanna Maria Derosas, figlia di Giuseppe Derosas, che ha portato avanti l’attività agricola raggiungendo notevoli risultati e dando lavoro a gran parte degli abitanti del paese.  L’ingresso principale della casa è costituito da un alto portale che si apre su un ampio cortile fiancheggiato da vari ambienti. Oltre all’aia e alle stalle, vi si affacciano l’officina per i mezzi meccanici, il ripostiglio per le granaglie e il frantoio per la molitura delle olive, che conserva intatti gli antichi macchinari. Dal termine del cortile si accede alle cantine nelle quali avveniva la conservazione dei vini che si producevano. Attualmente anche questi ambienti sono stati acquisiti dal comune di Usini e la corte diventerà, a seguito di importanti lavori di riqualificazione nell’ambito della Programmazione Territoriale dell’Unione dei Comuni del Coros, Corte e cantina del Cagnulari per eccellenza e sarà una vetrina del vino e delle Aziende operanti nel territorio. Il progetto prevede il restauro, la riqualificazione e la messa a norma delle strutture e degli spazi della Corte di Casa Diaz.
L’ingresso principale della casa è costituito da un alto portale che si apre su un ampio cortile fiancheggiato da vari ambienti. Oltre all’aia e alle stalle, vi si affacciano l’officina per i mezzi meccanici, il ripostiglio per le granaglie e il frantoio per la molitura delle olive, che conserva intatti gli antichi macchinari. Dal termine del cortile si accede alle cantine nelle quali avveniva la conservazione dei vini che si producevano. Attualmente anche questi ambienti sono stati acquisiti dal comune di Usini e la corte diventerà, a seguito di importanti lavori di riqualificazione nell’ambito della Programmazione Territoriale dell’Unione dei Comuni del Coros, Corte e cantina del Cagnulari per eccellenza e sarà una vetrina del vino e delle Aziende operanti nel territorio. Il progetto prevede il restauro, la riqualificazione e la messa a norma delle strutture e degli spazi della Corte di Casa Diaz.
Il Municipio di Usini
 Al termine di via Roma, prendiamo invece a destra la via Guglielmo Marconi. La seguiamo verso sud per un centinaio di metri, poi svoltiamo a destra nella via del Risorgimento. La prendiamo e dopo una sessantina di metri, alla destra della strada, al civico numero 70, troviamo l’edificio che ospita il Municipio di Usini, nel quale si trovano la sua sede e gli uffici che forniscono i loro servizi agli abitanti del paese. La struttura organizzativa è suddivisa in aree di competenze che gestiscono i servizi erogati alla comunità. Si tratta dell’Area Amministrativa, dell’Area Tecnico-Manutentiva, dell’Area Socio-Culturale, e l’Area Economico-Finanziaria. Il palazzo che attualmente ospita il Municipio è stato edificato ai primi del Novecento in forme classiche e, in passato, è stato sede dell’antica Scuola Elementare e sede della Biblioteca. Gli ambienti che attualmente ospitano la Sala Consiliare e l’ufficio della Polizia Municipale locale, che si trovano alla sinistra dell’edificio principale al civico numero 68, un tempo ospitavano l’antico Mercato, la cui costruzione per le caratteristiche tecniche e stilistiche potrebbe farsi risalire al primo quarto del Novecento.
Al termine di via Roma, prendiamo invece a destra la via Guglielmo Marconi. La seguiamo verso sud per un centinaio di metri, poi svoltiamo a destra nella via del Risorgimento. La prendiamo e dopo una sessantina di metri, alla destra della strada, al civico numero 70, troviamo l’edificio che ospita il Municipio di Usini, nel quale si trovano la sua sede e gli uffici che forniscono i loro servizi agli abitanti del paese. La struttura organizzativa è suddivisa in aree di competenze che gestiscono i servizi erogati alla comunità. Si tratta dell’Area Amministrativa, dell’Area Tecnico-Manutentiva, dell’Area Socio-Culturale, e l’Area Economico-Finanziaria. Il palazzo che attualmente ospita il Municipio è stato edificato ai primi del Novecento in forme classiche e, in passato, è stato sede dell’antica Scuola Elementare e sede della Biblioteca. Gli ambienti che attualmente ospitano la Sala Consiliare e l’ufficio della Polizia Municipale locale, che si trovano alla sinistra dell’edificio principale al civico numero 68, un tempo ospitavano l’antico Mercato, la cui costruzione per le caratteristiche tecniche e stilistiche potrebbe farsi risalire al primo quarto del Novecento.  Per la sua posizione al centro del paese, l’edificio era luogo di ritrovo e di comunicazione tra i cittadini, dato che dagli stessi locali veniva infatti emanato Su Bandu, utilizzato soprattutto dai venditori fino agli anni essanta del secolo scorso per informare la popolazione sui prodotti presenti al mercato e spesso anche per comunicazioni, da parte delle Autorità, sugli eventi importanti del paese.
Per la sua posizione al centro del paese, l’edificio era luogo di ritrovo e di comunicazione tra i cittadini, dato che dagli stessi locali veniva infatti emanato Su Bandu, utilizzato soprattutto dai venditori fino agli anni essanta del secolo scorso per informare la popolazione sui prodotti presenti al mercato e spesso anche per comunicazioni, da parte delle Autorità, sugli eventi importanti del paese.  All’interno dell’atrio d’ingresso dell’edificio è presente una Lapide commemorativa dei Caduti della prima guerra mondiale, realizzata nel 1921 da S. Saba, scultore attivo in Sardegna nella prima metà del ventesimo secolo, autore anche della lapide di Orani eseguita l’anno prima. Si tratta di una elegante lapide in marmo abbellita con diversi motivi decorativi e fitomorfi, con rami di quercia e di alloro, festoni a nastri pendenti. I nomi dei Caduti sono riportati suddivisi su tre colonne. Passato l’edificio che ospita il Municipio, alla destra della via Risorgimento parte la via Mercato, e sulla parete dell’edificio ad angolo tra la via Risorgimento e la via Mercato è presente, alla destra della via Mercato, il murale intitolato La Pigiatura dell’uva, realizzato anch’esso dall’artista Pina Monne e finanziato dall’amministrazione comunale di Usini.
All’interno dell’atrio d’ingresso dell’edificio è presente una Lapide commemorativa dei Caduti della prima guerra mondiale, realizzata nel 1921 da S. Saba, scultore attivo in Sardegna nella prima metà del ventesimo secolo, autore anche della lapide di Orani eseguita l’anno prima. Si tratta di una elegante lapide in marmo abbellita con diversi motivi decorativi e fitomorfi, con rami di quercia e di alloro, festoni a nastri pendenti. I nomi dei Caduti sono riportati suddivisi su tre colonne. Passato l’edificio che ospita il Municipio, alla destra della via Risorgimento parte la via Mercato, e sulla parete dell’edificio ad angolo tra la via Risorgimento e la via Mercato è presente, alla destra della via Mercato, il murale intitolato La Pigiatura dell’uva, realizzato anch’esso dall’artista Pina Monne e finanziato dall’amministrazione comunale di Usini.
La piazza Eleonora d’Arborea
 Dalla via Risorgimento torniamo sulla via Guglielmo Marconi. Dall’incrocio con la via Guglielmo Marconi, percorriamo verso sud appena una trentina di metri, fino a dove la via Guglielmo Marconi incrocia la via Eleonora d’Arborea, che è una strada parallela della via Risorgimento. Alla sinistra della via Guglielmo Marconi, prima del suo incrocio con la via Eleonora d’Arborea, ad angolo con quest'ultima strada, si sviluppa la bella Piazza Eleonora d’Arborea. Si tratta di una delle più belle piazze del paese, con diverse attività commerciali. È un’ampia piazza alberata, con panchine sulle quali è possibile sedersi, nella quale si svolgono diverse attività nell’ambito delle manifestazioni che si tengono ad Usini. Ed al centro della piazza è presente una bella decorazione, realizzata sulla sua pavimentazione.
Dalla via Risorgimento torniamo sulla via Guglielmo Marconi. Dall’incrocio con la via Guglielmo Marconi, percorriamo verso sud appena una trentina di metri, fino a dove la via Guglielmo Marconi incrocia la via Eleonora d’Arborea, che è una strada parallela della via Risorgimento. Alla sinistra della via Guglielmo Marconi, prima del suo incrocio con la via Eleonora d’Arborea, ad angolo con quest'ultima strada, si sviluppa la bella Piazza Eleonora d’Arborea. Si tratta di una delle più belle piazze del paese, con diverse attività commerciali. È un’ampia piazza alberata, con panchine sulle quali è possibile sedersi, nella quale si svolgono diverse attività nell’ambito delle manifestazioni che si tengono ad Usini. Ed al centro della piazza è presente una bella decorazione, realizzata sulla sua pavimentazione.
Il Parco delle Rimembranze con il Monumento ai Caduti di tutte le guerre
Passata la piazza Eleonora d’Arborea, seguiamo la via Guglielmo Marconi per trecentocinquanta metri, ed arriviamo alla periferia del paese, a un incrocio dove arriva da sinistra la via Sebastiano Satta, mentre parte a destra la via Aldice De Gasperi. Passato questo incrocio, proseguiamo con la via Guglielmo Marconi e dopo un centinaio di metri arriviamo a una rotonda, dove la strada attraversa la SP28 che esce dal paese verso sud est. Alla destra di questo ultimo tratto della via Guglielmo Marconi si sviluppano i giardini pubblici chiamati il Parco delle Rimembranze, la cui area è collocata in una zona periferica del paese, in prossimità del cimitero comunale. L’area ha uno sviluppo triangolare, ed è circondata su tre lati da percorsi viabilistici, la via Guglielmo Marconi a sud est, la via Alcide De Gasperi a nord ovest, e via Piave a sud ovest. L’area è caratterizzata dalla presenza del Monumento ai Caduti di tutte le guerre, del quale i lavori di sistemazione del giardino con vialetti, aiuole e recinzione risalgono agli anni Ottanta del Novecento. Il monumento ai caduti di tutte le guerre risale allo stesso periodo.
Non sono state rinvenute le targhe commemorative dei Caduti, e molti degli alberi presenti sono stati piantati di recente. Non è stata rinvenuta alcuna notizia riguardo quelli originari, tuttavia qualche cipresso della zona sembrerebbe di non recente piantumazione.
All’estremo meridionale dell’abitato si trova il Cimitero Comunale di Usini
Alla rotonda al termine della via Guglielmo Marconi, la prosecuzione della via Guglielmo Marconi è il viale del Riposo, mentre la prosecuzione della via Piave che è diventata il viale Pietro Nenni è la via Sos Paris, che diventa la SP28 e si dirige verso Ittiri. Passata la rotonda, alla destra della via del Riposo si sviluppa il Cimitero Comunale di Usini. Passato il cancello di ingresso che si affaccia sulla via Sos Paris, alla destra si trova la chiesa del Cimitero, mentre subito più avanti si incontra l’arco che introduce all’interno del Cimitero, al cui interno si trovano ancora diverse tombe antiche, in stile neoclassico, risalenti alla seconda metà dell’ottocento. Di particolare interesse, proprio appena passato l’ingresso, è la tomba della famiglia Diaz, con l’imponente scultura di marmo a memoria di Giuseppe Derosas. L’opera raffigura un bambino dietro un aratro tirato da buoi, intento nel lavoro dei campi. Probabilmente attraverso la scultura si intendeva rappresentare non solo la ricchezza della famiglia, che ha dato lustro e benessere a Usini, ma anche la loro grande umiltà nell’essere lavoratori della terra, come ancora testimoniato dai tesori custoditi nella Corte di Casa Diaz.
In via Alessandro Volta il parco comunale Su Trogliu con i ruderi della chiesa di San Giovanni Battista
Ci rechiamo, ora, a visitare la parte dell’abitato che si svilippa più a nord rispetto alla via Roma. Guardando la facciata della chiesa parrocchiale della Natività di Santa Maria Vergine, alla destra della chiesa vediamo che parte, dalla via Roma, verso nord il vicolo Roma. Seguito il vicolo Roma per una cinquantina di metri, svoltiamo a sinistra nella via Alessandro Volta che si dirige verso ovest e la seguiamo per un centinaio di metri, fino ad arrivare a vedere alla destra della strada un ingresso secondario del Parco Comunale Su Trogliu, ossia la fonte.
Presso questo ingresso sono presenti i pochi ruderi della Chiesa di San Giovanni Battista, che potrebbe essere stata costruita tra gli anni che seguirono il 1073 e quelli che precedettero il 1113 o, in ultima ipotesi, proprio nel 1113, anno nel quale a Mariano I succedette alla guida del giudicato di Torres il figlio Costantino. Nel 2024 è crollata la facciata dell’antica chiesa di San Giovanni Battista, che registrava da tempo problemi di tipo strutturale ed era transennato. Era rimasta visibile solo la facciata, mentre gli altri lati della chiesa erano stati occultati da abitazioni private. In seguito è iniziato il lavoro per un suo parziale restauro.
In via Giuanne Cuccuru è presente il murale intitolato I Melograni
 Dalla via Roma seguito il vicolo Roma per una cinquantina di metri, svoltiamo invece a destra nella via Alessandro Volta che si dirige verso est, la seguiamo per una cinquantina di metri e poi vediamo a sinistra partire la via Giuanne Cuccuru, così chiamata in ricordo del tenore e poeta usinese Giuanne Cuccuru, nato a Usini nel 1891 e morto a Sassari nel 1982, considerato una delle voci più belle e famose del canto sardo in Sardegna del secolo scorso. Sulla parete del primo edificio alla destra della via Giuanne Cuccuru e che si affaccia sulla via Alessandro volta al civico numero 51, è presente il bel murale intitolato I Melograni, nel quale sono rappresentate due donne, una con sia il costume sardo di Usini e l’altra quello di Ittiri, entrambi molto belli, davanti a un piatto contenente melograni, e nel quale è riportata anche la tenera frase di una mamma che ha perso un figlio.
Dalla via Roma seguito il vicolo Roma per una cinquantina di metri, svoltiamo invece a destra nella via Alessandro Volta che si dirige verso est, la seguiamo per una cinquantina di metri e poi vediamo a sinistra partire la via Giuanne Cuccuru, così chiamata in ricordo del tenore e poeta usinese Giuanne Cuccuru, nato a Usini nel 1891 e morto a Sassari nel 1982, considerato una delle voci più belle e famose del canto sardo in Sardegna del secolo scorso. Sulla parete del primo edificio alla destra della via Giuanne Cuccuru e che si affaccia sulla via Alessandro volta al civico numero 51, è presente il bel murale intitolato I Melograni, nel quale sono rappresentate due donne, una con sia il costume sardo di Usini e l’altra quello di Ittiri, entrambi molto belli, davanti a un piatto contenente melograni, e nel quale è riportata anche la tenera frase di una mamma che ha perso un figlio.
Nel parco comunale Su Trogliu si trovano i resti del Vecchio Lavatoio
 Subito all’inizio della via Giuanne Cuccuru, alla sinistra, si trova il cancello dell’ingresso principale del Parco comunale Su Trogliu. Nel 2008 sono iniziati i lavori di restauro dell’intera area, che è stata trasformata in parco giochi per bambini, nella quale sono presenti un campo da calcetto e diversi percorsi di attività fisica. I lavori di sistemazione sono stati completati nel 2010. Subito all’ingresso, alla sinistra, si trovano i resti del Vecchio Lavatoio, chiamato in lingua Su Trogliu Ezzu, ossia la fonte vecchia. Fino alla seconda metà dell’Ottocento un lavatoio si trovava a ridosso della fonte pubblica, ma gli inconvenienti causati dall’uso della cenere per lavare i panni, portarono nel 1880 l’amministrazione comunale a decidere che il pubblico lavatoio doveva essere rifabbricato. Il nuovo lavatoio comunale, il cui progetto fu affidato all’ingegnere sassarese Silvio Gandino nel 1912, venne terminato nel 1914. La vasca centrale, di forma rettangolare con lati corti absidati, è realizzata in blocchi di trachite locale ed è suddivisa in vasche più piccole.
Subito all’inizio della via Giuanne Cuccuru, alla sinistra, si trova il cancello dell’ingresso principale del Parco comunale Su Trogliu. Nel 2008 sono iniziati i lavori di restauro dell’intera area, che è stata trasformata in parco giochi per bambini, nella quale sono presenti un campo da calcetto e diversi percorsi di attività fisica. I lavori di sistemazione sono stati completati nel 2010. Subito all’ingresso, alla sinistra, si trovano i resti del Vecchio Lavatoio, chiamato in lingua Su Trogliu Ezzu, ossia la fonte vecchia. Fino alla seconda metà dell’Ottocento un lavatoio si trovava a ridosso della fonte pubblica, ma gli inconvenienti causati dall’uso della cenere per lavare i panni, portarono nel 1880 l’amministrazione comunale a decidere che il pubblico lavatoio doveva essere rifabbricato. Il nuovo lavatoio comunale, il cui progetto fu affidato all’ingegnere sassarese Silvio Gandino nel 1912, venne terminato nel 1914. La vasca centrale, di forma rettangolare con lati corti absidati, è realizzata in blocchi di trachite locale ed è suddivisa in vasche più piccole.  Per l’approvvigionamento idrico viene utilizzata l’acqua di scolo della fonte, opportunamente incanalata in una conduttura sotterranea. Nel 1934 venne installato l’impianto di illuminazione elettrica e fu venduto un tratto del terreno comunale retrostante, poiché col vento numerosi rifiuti andavano a finire dentro il lavatoio, con gravi conseguenze per l’igiene pubblica. Rimase in funzione sino alla metà degli anni settanta, divenendo oltretutto un importante luogo di incontro e socializzazione per le donne del paese, un luogo che ha ascoltato storie di vita, le chiacchiere delle massaie e le voci di quei bambini che le mamme dovevano portare in giro. Questa immagine di quotidianità trova eco persino nel lessico, si pensi al detto sardo parimus in su trogliu per indicare una situazione rumorosa e confusa. Versava in stato di abbandono sino al restauro concluso nel 1997. Oggi la copertura lignea conserva ancora delle travi originali.
Per l’approvvigionamento idrico viene utilizzata l’acqua di scolo della fonte, opportunamente incanalata in una conduttura sotterranea. Nel 1934 venne installato l’impianto di illuminazione elettrica e fu venduto un tratto del terreno comunale retrostante, poiché col vento numerosi rifiuti andavano a finire dentro il lavatoio, con gravi conseguenze per l’igiene pubblica. Rimase in funzione sino alla metà degli anni settanta, divenendo oltretutto un importante luogo di incontro e socializzazione per le donne del paese, un luogo che ha ascoltato storie di vita, le chiacchiere delle massaie e le voci di quei bambini che le mamme dovevano portare in giro. Questa immagine di quotidianità trova eco persino nel lessico, si pensi al detto sardo parimus in su trogliu per indicare una situazione rumorosa e confusa. Versava in stato di abbandono sino al restauro concluso nel 1997. Oggi la copertura lignea conserva ancora delle travi originali.
Nella via Alessandro Volta rimangono i ruderi delle vecchie Carceri Baronali
 In via Alessandro Volta, un tempo chiamata via del Duca, all’altezza del vecchio lavatoio proprio di fronte alla via Giuanne Cuccuru, trovavano posto le antiche Carceri Baronali.
In via Alessandro Volta, un tempo chiamata via del Duca, all’altezza del vecchio lavatoio proprio di fronte alla via Giuanne Cuccuru, trovavano posto le antiche Carceri Baronali.  Ricorda Ignazio Delogu che «Nella grotta che fu orrendo carcere feudale era ancora possibile vedere, anni addietro, gli anelli di pietra dentro i quali scorrevano le catene, gli alloggi del trave centrale per la tortura e, graffiti nella roccia viva, i disperati messaggi dei detenuti...». Attualmente, l’interno delle vecchie Carceri Baronali si presenta quasi completamente ostruito da materiale edilizio di scarto. Uno stemma della famiglia Manca è visibile, in tutta la sua grazia cinquecentesca, scolpito su una delle pareti che circondavano le antiche Carceri. Il bassorilievo rappresenta un braccio sinistro armato d’argento movente dal fianco destro e impugnante una spada alta in palio, nel quale in punta dello scudo un elmo d’argento, di fronte, semiaperto, ornato di tre penne di struzzo.
Ricorda Ignazio Delogu che «Nella grotta che fu orrendo carcere feudale era ancora possibile vedere, anni addietro, gli anelli di pietra dentro i quali scorrevano le catene, gli alloggi del trave centrale per la tortura e, graffiti nella roccia viva, i disperati messaggi dei detenuti...». Attualmente, l’interno delle vecchie Carceri Baronali si presenta quasi completamente ostruito da materiale edilizio di scarto. Uno stemma della famiglia Manca è visibile, in tutta la sua grazia cinquecentesca, scolpito su una delle pareti che circondavano le antiche Carceri. Il bassorilievo rappresenta un braccio sinistro armato d’argento movente dal fianco destro e impugnante una spada alta in palio, nel quale in punta dello scudo un elmo d’argento, di fronte, semiaperto, ornato di tre penne di struzzo.
L’Auditorium Comunale
 Dalla via Alessandro Volta prendiamo la via Giuanne Cuccuru che si dirige verso nord, la seguiamo per centotrenta metri finché la strada incrocia la via Admondo De Amicis e proseguiamo dritti su questa per un’ottantina di metri, poi svoltiamo a destra nella via Niccolò Paganini. Seguita la via Niccolò Paganini per una cinquantina di metri, troviamo alla sinistra della strada, in corrispondenza del civico numero 2, l’ingresso delle Scuole dell’infanzia e primaria, dal quale si raggiunge l’Auditorium Comunale, che ospita il laboratorio teatarale e musicale. L’Auditorium è stato intestato dal 2018 a Mario Cuccuru, figura poliedrica di cantore, poeta improvvisatore, suonatore di chitarra e mandolino, abile recitatore, uomo di cultura dotato di uno spiccato senso dell’umorismo, arti e virtù che lo hanno reso celebre, amato e stimato tra i suoi compaesani in maniera trasversale e unanime, e che è stato il primo presidente del Coro di Usini dal 1992 al 2005, e poi presidente onorario sino alla sua morte nel 2007.
Dalla via Alessandro Volta prendiamo la via Giuanne Cuccuru che si dirige verso nord, la seguiamo per centotrenta metri finché la strada incrocia la via Admondo De Amicis e proseguiamo dritti su questa per un’ottantina di metri, poi svoltiamo a destra nella via Niccolò Paganini. Seguita la via Niccolò Paganini per una cinquantina di metri, troviamo alla sinistra della strada, in corrispondenza del civico numero 2, l’ingresso delle Scuole dell’infanzia e primaria, dal quale si raggiunge l’Auditorium Comunale, che ospita il laboratorio teatarale e musicale. L’Auditorium è stato intestato dal 2018 a Mario Cuccuru, figura poliedrica di cantore, poeta improvvisatore, suonatore di chitarra e mandolino, abile recitatore, uomo di cultura dotato di uno spiccato senso dell’umorismo, arti e virtù che lo hanno reso celebre, amato e stimato tra i suoi compaesani in maniera trasversale e unanime, e che è stato il primo presidente del Coro di Usini dal 1992 al 2005, e poi presidente onorario sino alla sua morte nel 2007.
La Scuola Primaria e dell’Infanzia con i suoi impianti sportivi
 Percorsa un’altra trentina di metri lungo la via Niccolò Paganini, troviamo alla sinistra della strada l’ingresso principale del plesso ospitante la Scuola Primaria e dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale Grazia Deledda. Prima del 1974 le due scuole erano ubicate in via Risorgimento, nella sede attuale del Municipio, successivamente la Scuola Primaria è stata trasferita nei locali di via Niccolò Paganini dove opera tuttora, e dove in un secondo tempo parte del caseggiato è stata destinato alla Scuola dell’Infanzia. All’interno di questo complesso scolastico si trova una Palestra, nella quale è presente un Campo Sportivo Polivalente, che non è dotato di tribune per gli spettatori, dove si possono praticare come discipline Ginnastica, pallacanestro e Mini basket, pallavolo.
Percorsa un’altra trentina di metri lungo la via Niccolò Paganini, troviamo alla sinistra della strada l’ingresso principale del plesso ospitante la Scuola Primaria e dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale Grazia Deledda. Prima del 1974 le due scuole erano ubicate in via Risorgimento, nella sede attuale del Municipio, successivamente la Scuola Primaria è stata trasferita nei locali di via Niccolò Paganini dove opera tuttora, e dove in un secondo tempo parte del caseggiato è stata destinato alla Scuola dell’Infanzia. All’interno di questo complesso scolastico si trova una Palestra, nella quale è presente un Campo Sportivo Polivalente, che non è dotato di tribune per gli spettatori, dove si possono praticare come discipline Ginnastica, pallacanestro e Mini basket, pallavolo.
Il Palazzetto dello Sport di Usini Sa Maja con i suoi impianti sportivi
 Proseguiamo verso est lungo la via Niccolò Paganini e, dopo poco meno di un centinaio di metri, svoltiamo a destra nella via Primo Maggio e, dopo una cinquantina di metri, prendiamo a sinistra la via Nove Maggio che si dirige verso nord. Seguendo la via Nove Maggio, dopo una trentina di metri vediamo alla destra della strada in cancello che permette di accedere al Palazzetto dello Sport di Usini Sa Maja. Si tratta di un campo polifunzionale che si sviluppa lungo la via Primo Maggio, e che contiene al suo interno una Campo Sportivo Polivalente, dotato di tribune in grado di ospitare 300 spettatori, nel quale è possibile praticare come discipline Calcio e Calcetto ossia Calcio a cinque, Handball’ossia Pallamano, pallacanestro, e pallavolo.
Proseguiamo verso est lungo la via Niccolò Paganini e, dopo poco meno di un centinaio di metri, svoltiamo a destra nella via Primo Maggio e, dopo una cinquantina di metri, prendiamo a sinistra la via Nove Maggio che si dirige verso nord. Seguendo la via Nove Maggio, dopo una trentina di metri vediamo alla destra della strada in cancello che permette di accedere al Palazzetto dello Sport di Usini Sa Maja. Si tratta di un campo polifunzionale che si sviluppa lungo la via Primo Maggio, e che contiene al suo interno una Campo Sportivo Polivalente, dotato di tribune in grado di ospitare 300 spettatori, nel quale è possibile praticare come discipline Calcio e Calcetto ossia Calcio a cinque, Handball’ossia Pallamano, pallacanestro, e pallavolo.
La Funtana Ozzanu
Passato l’ingresso del Palazzetto dello Sport di Usini Sa Maja, proseguiamo verso nord lungo la via Nove Maggio per un centinaio di metri, fino ad arrivare al termine della strada, dove si trova la Funtana Ozzanu, una fontana con abbeveratoio, collegata al circuito Ippovia Mediterraneo.
Visita dei dintorni di Usini
Vediamo ora che cosa si trova di più sigificativo nei dintorni dell’abitato che abbiamo appena descritto. Per quanto riguarda le principali ricerche archeologiche effettuate nei dintorni di Usini, sono stati portati alla luce i resti della fonte sacra S'Iscia 'e Su Puttu; della necropoli di S’Elighe Entosu; della tomba ipogeica a prospetto di Chercos, delle tombe di giganti S'Elighe Entosu VII, Molineddu II, Molineddu III, Molineddu IV, Molineddu V, S'Abbadosu Sa Tanca, S'Iscia 'e Sas Piras I, S'Iscia 'e Sas Piras II, S'Iscia 'e Sas Piras III, Tomestighes; del nuraghe complesso ’e Filighe; del nuraghe semplice del Monte Franzischeddu; ed anche del nuraghe Tomestighes, di tipologia indefinita.
L’Azienda Vinicola Cherchi
Dal centro di Usini ci reimmettiamo sulla SP15M verso Sassari e la seguiamo per un paio di chilometri fino alla deviazione sulla destra verso la SP3. Evitiamo questa deviazione, e proseguiamo dritto sul sovrapasso in direzione seguendo le indicazioni per la SS127bis, e, appena scesi dal sovrapasso, prendiamo una deviazione in una stretta strada sulla destra, che porta alle cantine della Vinicola Cherchi.
La Stazione ferroviaria di Tissi e Usini
Seguendo la deviazione della SP15M per cinquecento metri, prendiamo la SP3 verso ovest, che ci porta in altri cinquecento metri alla Stazione ferrroviaria di Tissi e Usini sulla linea che da Ozieri Chilivani conduce a Porto Torres Marittima. Lo scalo viene realizzato dalla Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde come stazione nella seconda metà dell’Ottocento, nell’ambito della fase di realizzazione della linea tra Chilivani e Porto Torres, e viene aperto il 15 agosto 1874 insieme al tronco ferroviario tra Sassari e Ploaghe. Viene gestita la stazione sino al passaggio della rete ferroviaria sarda a scartamento ordinario alle Ferrovie dello Stato nel 1920.
Tra gli anni novanta del Novecento ed il 2000 si registra la progressiva chiusura della stazione ai vari servizi di trasporto, con la trasformazione dell’impianto in fermata nel 2003, quando vengono dismessi i servizi merci e viaggiatori. Da allora la fermata, gestita da RFI dal 2001, permane attiva esclusivamente come località di servizio.
Il Campo Sportivo San Mauro
Dal centro di Usini prendiamo la via San Giorgio che si dirige verso ovest e la seguiamo fino alla rotonda dalla quale eravamo entrati nell’abitato provenendo da Sassari con la SP15M. Alla rotonda prendiamo la seconda uscita e continuiamo sulla via San Giorgio per poco più di duecento metri, per poi uscire dall’abitato con la traversa San Giorgio. Percorso circa un chilometro e seicento metri svoltiamo a destra e prendiamo la SS127bis, percorso circa un chilometro svoltiamo a sinistra seguendo le indicazioni e, percorsi novecento metri, vediamo alla destra della strada l’ingresso del Campo Sportivo San Mauro. Di tratta di un Campo da calcio con fondo in terra battuta, dotato di tribune in grado di ospiare una cinquantina di spettatori.
La tomba ipogeica a prospetto architettonico di Chercos
 Dal centro di Usini prendiamo la via San Giorgio che si dirige verso ovest e la seguiamo fino alla rotonda dalla quale eravamo entrati nell’abitato provenendo da Sassari con la SP15M. Alla rotonda prendiamo la seconda uscita e continuiamo sulla via San Giorgio per poco più di duecento metri, per poi uscire dall’abitato verso ovest con la traversa San Giorgio. Percorso circa un chilometro e mezzo incrociamo la SS127bis, superiamo l’incrocio e proseguiamo dritti sulla traversa San Giorgio per poco più di due chilometri fino ad arrivare di fronte al cancello di una proprietà privata. Alla destra di questo cancello, proseguiamo verso nord nelle campagne per circa trecento metri e raggiungiamo la tomba di Chercos, che si apre su una parete calcarea a ottantotto metri di altezza, ai piedi di una collina, infossata in una vallecola che digrada verso quella del Rio Mascari, affluente del Mannu. Si tratta di una tomba a prospetto architettonico, riutilizzo di una domu de janas, che all’esterno presenta, scolpita nella roccia, la stele centinata del tipo a specchio ribassato, che ne sovrasta l’ingresso. La stele è visibile. All’interno, la tomba è formata da una camera unica a pianta ovale, con la forma di scafo di barca rovesciato, e fornita di una nicchia assiale, con all’interno un bancone, mentre nella parete di fondo, sulle pareti e sulla volta sono presenti numerosi graffiti ed incisioni schematiche, raffiguranti elementi vegetali. Ciò che colpisce maggiormente è che il suo ingresso, a luce ogivale, è rimarcato nel profilo superiore ma non nella base, da una fascia decorata con tre scanalature in rilievo. Le numerose incisioni simboliche sono databili ad epoca storica, o comunque ad una fase di riuso dell’ipogeo.
Dal centro di Usini prendiamo la via San Giorgio che si dirige verso ovest e la seguiamo fino alla rotonda dalla quale eravamo entrati nell’abitato provenendo da Sassari con la SP15M. Alla rotonda prendiamo la seconda uscita e continuiamo sulla via San Giorgio per poco più di duecento metri, per poi uscire dall’abitato verso ovest con la traversa San Giorgio. Percorso circa un chilometro e mezzo incrociamo la SS127bis, superiamo l’incrocio e proseguiamo dritti sulla traversa San Giorgio per poco più di due chilometri fino ad arrivare di fronte al cancello di una proprietà privata. Alla destra di questo cancello, proseguiamo verso nord nelle campagne per circa trecento metri e raggiungiamo la tomba di Chercos, che si apre su una parete calcarea a ottantotto metri di altezza, ai piedi di una collina, infossata in una vallecola che digrada verso quella del Rio Mascari, affluente del Mannu. Si tratta di una tomba a prospetto architettonico, riutilizzo di una domu de janas, che all’esterno presenta, scolpita nella roccia, la stele centinata del tipo a specchio ribassato, che ne sovrasta l’ingresso. La stele è visibile. All’interno, la tomba è formata da una camera unica a pianta ovale, con la forma di scafo di barca rovesciato, e fornita di una nicchia assiale, con all’interno un bancone, mentre nella parete di fondo, sulle pareti e sulla volta sono presenti numerosi graffiti ed incisioni schematiche, raffiguranti elementi vegetali. Ciò che colpisce maggiormente è che il suo ingresso, a luce ogivale, è rimarcato nel profilo superiore ma non nella base, da una fascia decorata con tre scanalature in rilievo. Le numerose incisioni simboliche sono databili ad epoca storica, o comunque ad una fase di riuso dell’ipogeo.
La chiesa campestre di San Giorgio di Oleastreto
 Usciti dall’abitato verso ovest con la traversa San Giorgio, percorso circa un chilometro e mezzo incrociamo la SS127bis, superiamo l’incrocio e proseguiamo dritti sulla traversa San Giorgio per quattro chilometri e settecento metri arrivando nella piana di San Giorgio, con la strada in buone condizioni, tranne l’ultimo chilometro, sterrato con tante buche. Qui, passato un cancello sulla sinistra, si raggiunge il punto dove svetta solitaria la Chiesa campestre di San Giorgio di Oleastreto, dal nome Oleastretum ossia piccolo olivastro, che era la parrocchiale dell’antico villaggio medievale. Fatta edificare nel dodicesimo secolo dal giudice Costantino II di Torres in stile romanico, con blocchi di calcare chiaro di dimensioni omogenee, è molto accurata. Nel tredicesimo è stata adibita a ricovero per i lebbrosi, affidata alle monache pisane dell’Ospedale di San Leonardo di Stagno, una struttura ospedaliera ubicata a Stagno, una località posta a nord di Livorno. La donazione comprende anche alcune pertinenze dato che veniva indicato «... cum terris, vineis, silvis, servi set ancili, bobus, equi set iumentis, porcis, ovibus etàcapris omnibusque pertinentiis suis». Il duca dell’Asinara, che tra i suoi numerosi titoli annoverava anche quello di conte di San Giorgio, organizzava a sue spese la festa del Santo Guerriero, che si teneva nei primi giorni di maggio, ed alla processione, preceduta dalle cavallerie di Tissi e Usini, partecipavano numerosi fedeli dei villaggi vicini. In seguito la chiesa è stata assegnata ai Frati Francescani di San Lorenzo alle Rivolte di Pisa, poi verso la fine del diciannovesimo secolo è stata abbandonata. Nel corso della sua storia ha subito parecchi crolli, negli anni Trenta del Novecento è crollata la copertura, e nel 1971 ha subito gravi danni con il crollo di parte della facciata. La chiesa, lasciata incustodita per lungo tempo era diventata ormai un rudere, fino a quando nel 1998 vennero intrapresi i lavori di restauro riportandola al suo antico splendore.
Usciti dall’abitato verso ovest con la traversa San Giorgio, percorso circa un chilometro e mezzo incrociamo la SS127bis, superiamo l’incrocio e proseguiamo dritti sulla traversa San Giorgio per quattro chilometri e settecento metri arrivando nella piana di San Giorgio, con la strada in buone condizioni, tranne l’ultimo chilometro, sterrato con tante buche. Qui, passato un cancello sulla sinistra, si raggiunge il punto dove svetta solitaria la Chiesa campestre di San Giorgio di Oleastreto, dal nome Oleastretum ossia piccolo olivastro, che era la parrocchiale dell’antico villaggio medievale. Fatta edificare nel dodicesimo secolo dal giudice Costantino II di Torres in stile romanico, con blocchi di calcare chiaro di dimensioni omogenee, è molto accurata. Nel tredicesimo è stata adibita a ricovero per i lebbrosi, affidata alle monache pisane dell’Ospedale di San Leonardo di Stagno, una struttura ospedaliera ubicata a Stagno, una località posta a nord di Livorno. La donazione comprende anche alcune pertinenze dato che veniva indicato «... cum terris, vineis, silvis, servi set ancili, bobus, equi set iumentis, porcis, ovibus etàcapris omnibusque pertinentiis suis». Il duca dell’Asinara, che tra i suoi numerosi titoli annoverava anche quello di conte di San Giorgio, organizzava a sue spese la festa del Santo Guerriero, che si teneva nei primi giorni di maggio, ed alla processione, preceduta dalle cavallerie di Tissi e Usini, partecipavano numerosi fedeli dei villaggi vicini. In seguito la chiesa è stata assegnata ai Frati Francescani di San Lorenzo alle Rivolte di Pisa, poi verso la fine del diciannovesimo secolo è stata abbandonata. Nel corso della sua storia ha subito parecchi crolli, negli anni Trenta del Novecento è crollata la copertura, e nel 1971 ha subito gravi danni con il crollo di parte della facciata. La chiesa, lasciata incustodita per lungo tempo era diventata ormai un rudere, fino a quando nel 1998 vennero intrapresi i lavori di restauro riportandola al suo antico splendore.
Secondo una tradizione consolidata la Festa in onore di San Giorgio di Oleastreto viene celebrata nella chiesa campestre dedicata appunto al Santo Guerriero il giorno del 1 maggio.  Un festa che era caduta nel dimenticatoio per lunghi anni, la quale ha tradizioni antichissime, e che dopo essere stata rinverdita grazie alla Pro Loco, da circa vent’anni è diventato un punto fermo per tutti i fedeli. Secondo un programma prestabilito, la sera della vigilia nel piazzale antistante la chiesa si tiene uno spettacolo musicale, ed a seguire balli. I giorno successivo, la festa di San Giorgio inizia con il raduno dei fedeli nella chiesa di Santa Croce, con partenza in auto a seguito del simulacro del Santo. Segue la processione a piedi dalla strada sterrata fino a raggiungere la chiesa campestre, dove viene celebrata la Santa Messa animata dai canti del Coro Logudoro. A tutti i convenuti il comitato offre il pranzo a base di pecora. Si prosegue con le musiche, ed in serata è previsto il rientro in paese del simulacro del Santo.
Un festa che era caduta nel dimenticatoio per lunghi anni, la quale ha tradizioni antichissime, e che dopo essere stata rinverdita grazie alla Pro Loco, da circa vent’anni è diventato un punto fermo per tutti i fedeli. Secondo un programma prestabilito, la sera della vigilia nel piazzale antistante la chiesa si tiene uno spettacolo musicale, ed a seguire balli. I giorno successivo, la festa di San Giorgio inizia con il raduno dei fedeli nella chiesa di Santa Croce, con partenza in auto a seguito del simulacro del Santo. Segue la processione a piedi dalla strada sterrata fino a raggiungere la chiesa campestre, dove viene celebrata la Santa Messa animata dai canti del Coro Logudoro. A tutti i convenuti il comitato offre il pranzo a base di pecora. Si prosegue con le musiche, ed in serata è previsto il rientro in paese del simulacro del Santo.
I ruderi della ottocentesca vecchia Stazione ferroviaria di San Giorgio
Nelle campagne all’estremità nord occidentale del territorio comunale è attiva la Stazione di San Giorgio, impianto situato lungo la ferrovia che collega Sassari con Alghero, gestita oggi da ARST. Dal punto dove abbiamo visto il cancello per la chiesa di San Giorgio di Oleastreto, proseguiamo verso nord ovest lungo la strada che ci ha portati fin qui e che presto diventa una strada bianca, e più avanti un sentiero. Percorsi circa cinquecento metri, si vede alla sinistra della strada, l’edificio che ospita la ottocentesca vecchia Stazione ferroviaria di San Giorgio, che era situata nelle campagne a nord est dell’abitato di Usini, lungo la linea che collegava Sassari con Alghero. Questa stazione viene realizzata alla fine dell’Ottocento dalla Società per le Strade Ferrate Secondarie della Sardegna, azienda che realizza ed ha inizialmente in gestione le prime ferrovie pubbliche a scartamento ridotto dell’Isola, compresa quella tra Sassari e Alghero.
L’impianto di San Giorgio viene inaugurato insieme alla linea nel 1889 ed inizialmente adibito a fermata facoltativa. Nonostante situato in aperta campagna, lo scalo di San Giorgio assume man mano una certa importanza per la gestione del movimento nella prima parte della linea, essendo diventato l’unico scalo abilitato agli incroci ferroviari tra Sassari e Olmedo. Poi con il passare degli anni l’impianto cambia più volte la gestione, passando nel 1921 alle Ferrovie Complementari della Sardegna e nel 1941 alle Strade Ferrate Sarde. Nel 1989 alle Strade Ferrate Sarde subentra la gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna, e nel lustro successivo questo ente porta avanti vari lavori di rettifica del tracciato della linea, alcuni dei quali concentrati nelle vicinanze della stazione di San Giorgio la quale viene isolata dalla linea con l’attivazione di una delle varianti realizzate in quegli anni, variante passante su un viadotto, il che porta alla dismissione della ottocentesca stazione.
La nuova Stazione ferroviaria di San Giorgio
La nuova Stazione ferroviaria di San Giorgio si può raggiungere dalla vecchia Stazione proseguendo verso nord lungo il sentiero che poi curva verso est, e ci si arriva in trecentocinquanta metri. La nuova stazione sorge negli anni Novanta del Novecento, periodo in cui lungo la linea ferroviaria tra Sassari e Alghero, gestita all’epoca dalle Ferrovie della Sardegna, vengono eseguiti vari interventi di rettifica di tracciato, in particolare nella zona dell’ottocentesca stazione di San Giorgio. Per mantenere la possibilità di incrocio dei treni tra Sassari e Olmedo viene allora realizzata una nuova stazione portante lo stesso nome, posizionata a poco più di trecento metri di distanza dall’originale, un poco più a nord all’altezza del punto in cui ha inizio la nuova parte di tracciato che aggira il vecchio scalo. Completata e inaugurata a metà di quello stesso decennio, la stazione di San Giorgio dal 2010 è gestita dall’ARST.
Abbiamo descritto qui la Stazione di San Giorgio dato che si trova in territorio di Usini, ma ad essa si arriva meglio da Caniga, borgata di Sassari, con la Strada vicinale Monti di Jesgia. Dal centro di Usini prendiamo la via San Giorgio che si dirige verso ovest e la seguiamo fino alla rotonda dalla quale eravamo entrati nell’abitato provenendo da Sassari con la SP15M. Alla rotonda prendiamo la seconda uscita e continuiamo sulla via San Giorgio per poco più di duecento metri, per poi uscire dall’abitato con la traversa San Giorgio. Percorso circa un chilometro e seicento metri svoltiamo a destra e prendiamo la SS127bis che si dirige verso nord in direzione di Caniga, e dopo sei chilometri e duecento metri svoltando a sinistra seguendo le indicazioni sulla Strada vicinale Monti di Jesgia. Su questa strada si percorrono circa quattro chilometri fino ad arrivare al suo termine, di fronte alla Stazione ferroviaria di San Giorgio.
Il Centro Sportivo Calaresu in località Pirapeglias
Dal centro di Usini prendiamo la via San Giorgio che si dirige verso ovest e la seguiamo fino alla rotonda dalla quale eravamo entrati nell’abitato provenendo da Sassari con la SP15M. Alla rotonda prendiamo la seconda uscita e continuiamo sulla via San Giorgio per circa duecentotrenta metri e, subito prima di uscire dall’abitato con la traversa San Giorgio, svoltiamo a sinistra. Dopo quattrocentocinquanta metri svoltiamo a destra e, percorsi poco più di duecento metri, raggiungiamo in località Pirapeglias il Centro Sportivo Calaresu. In questo Centro Sportivo si trova un Campo Calcetto, ossia da calcio a cinque, con fondo in erba sintetica, senza tribune per gli spettatori. Sono in seguito stati realizzati anche due Campi da Padel, sport che si pratica con una racchetta dal piatto rigido con cui ci si scambia una pallina uguale a quella da tennis, ma con una pressione interna inferiore, che permette un maggior controllo dei colpi e dei rimbalzi sulle sponde.
Lungo la prosecuzione del viale del Riposo si raggiungono i resti della necropoli di S'Iscia 'e Sas Piras

 Dal centro di Usini ci rechiamo fino alla rotonda che porta al Cimitero Comunale. Qui prendiamo il viale del Riposo che esce dall’abitato in direzione sud ovest, lo seguiamo e, dopo ottocento metri arriviamo a un bivio dove proseguiamo verso sinistra. Percorsi altri circa duecento metri, alla destra della strada si trovano i resti della Necropoli di S'Iscia 'e Sas Piras, conosciuta anche come Necropoli di Mereu. Si tratta di un sito funerario nuragico situato nelle vicinanze di una strada romana nota in lingua sarda come S'Istrada de Sos Padres, ossia la strada dei padri, in quanto collegava l’Abbazia cistercense di Santa Maria di Corte in territorio di Sindia, all’Abbazia di Santa Maria di Paulis Paulis in territorio di Ittiri. La necropoli è composta da tre domus de janas a prospetto architettonico, la tomba II e la tomba III situate a breve distanza fra loro, mentre la tomba I è situata più a sud ovest, a circa duecento metri di distanza.
Dal centro di Usini ci rechiamo fino alla rotonda che porta al Cimitero Comunale. Qui prendiamo il viale del Riposo che esce dall’abitato in direzione sud ovest, lo seguiamo e, dopo ottocento metri arriviamo a un bivio dove proseguiamo verso sinistra. Percorsi altri circa duecento metri, alla destra della strada si trovano i resti della Necropoli di S'Iscia 'e Sas Piras, conosciuta anche come Necropoli di Mereu. Si tratta di un sito funerario nuragico situato nelle vicinanze di una strada romana nota in lingua sarda come S'Istrada de Sos Padres, ossia la strada dei padri, in quanto collegava l’Abbazia cistercense di Santa Maria di Corte in territorio di Sindia, all’Abbazia di Santa Maria di Paulis Paulis in territorio di Ittiri. La necropoli è composta da tre domus de janas a prospetto architettonico, la tomba II e la tomba III situate a breve distanza fra loro, mentre la tomba I è situata più a sud ovest, a circa duecento metri di distanza.
La tomba I presenta una pianta rettangolare con sviluppo longitudinale e angoli arrotondati, due gradini verso l’ingresso, un bancone lungo le pareti e una nicchia a pianta semicircolare in ciascuna delle due pareti laterali. A livello della facciata è visibile la parte rettangolare inferiore della stele. Al motivo del falso architrave sembrerebbe rimandare la curiosa lavorazione del listello orizzontale che separa riquadro e lunetta, nella stele della tomba I di S’Iscia ’e sas Piras, la fascia, infatti, è fortemente rilevata rispetto al filo della parete di prospetto, ma è difficile interpretare lo specifico simbolismo di questo particolare, che non deve essere necessariamente ricondotto alla sfera delle riproduzioni di elementi architettonici. All’interno di questa tomba Editta Castaldi non ha eseguito saggi nell’esedra, ma si è limitata a vagliare, nell’area antistante il portello, un mucchio di terra prodotto da scavatori clandestini che avevano violato l’ipogeo. Se ne deduce, quindi, che di questa tomba conosciamo solamente i materiali dell’interno, sia trovati nel luogo che recuperati dalla terra rimossa ed accumulata all’esterno. Si tratta prevalentemente di vasi potori, ossia ciotole o tazze carenate o pseudocarenate, di piccole dimensioni, salvo una grande ciotola carenata monoansata di ventitre centimetri di diametro. Presenti anche rari i frammenti di grossi vasi, tegami o scodelloni. Il quadro ceramico, unitamente alla presenza di oggetti d’ornamento come un elemento di collana in pietra, ed una collana di vaghi di conchiglia composta da 1909 elementi oggi conservata nel Museo Giovanni Antonio Sanna di Sassari, o comunque personali come due punteruoli in bronzo, contribuisce a delineare un tipico corredo funerario. In base ai dati archeologici e radiocarbonici la datazione di questa tomba era stata collocata tra il Bronzo Medio ed il Bronzo Finale, ma assume una grande importanza la recente datazione al Bronzo Antico al tempo della Cultura di Bonnanaro della tomba I, che intercetta una fase d’uso anteriore a quella che era stata precedentemente individuata.
 Nella tomba I, durante gli scavi diretti da Editta Castaldi negli anni Sessanta del Novecento, sono stati rinvenuti i resti scomposti di nove uomini, tre donne e due bambini, oltre allo scheletro quasi completo di una adolescente deceduta in tempi assai recenti, nel ventesimo secolo. Le analisi antropologiche condotte da Franco Germanà nel 1975 hanno notato lo stato di frantumazione delle ossa, con tracce di usure e solchi post-mortem dovuti a «cause meccaniche piuttosto efficienti». A suo giudizio, le ossa erano da riferire a deposizioni secondarie, con scarnificazione di tipo meccanico e non per combustione, probabilmente con l’utilizzo di «taglienti coltelli per staccare le parti molli dalle ossa». I maschi mostravano un’età da giovanile a senile, mentre le donne da giovanile ad adulta. L’altezza oscillava fra i 163 e 173 centimetri per i maschi e fra i 154 e 158 centimetri per le donne. Il quadro paleopatologico evidenziava «una situazione igienicosanitaria di gruppo piuttosto ottimale». L’unico caso di porosi iperostosica, legata a patologie anemizzanti, come la talassemia o la malaria, riguarda un individuo senile ed è messo in relazione a normali fenomeni trasformativi tipici della vecchiaia, ed anche i fatti artrosici sono da mettere in relazione all’età senile, mentre è assai rara la carie dei denti. In due reperti femminili era tuttavia presente il rachitismo, indiziato dal fenomeno della coxa valga, ossia deformità dell’anca tra testa e collo del femore e lo stesso corpo del femore. In alcuni reperti ossei maschili, invece, la presenza di malformazioni dovute a microtraumi ripetuti o continui, è probabilmente da mettere in relazione con attività che comportavano «lunghe marce in luoghi erti, abitudine a cavalcare bestie da soma, buoi nel particolare». L’economia si ritiene fosse basata, quindi, sulla caccia e sulla pastorizia.
Nella tomba I, durante gli scavi diretti da Editta Castaldi negli anni Sessanta del Novecento, sono stati rinvenuti i resti scomposti di nove uomini, tre donne e due bambini, oltre allo scheletro quasi completo di una adolescente deceduta in tempi assai recenti, nel ventesimo secolo. Le analisi antropologiche condotte da Franco Germanà nel 1975 hanno notato lo stato di frantumazione delle ossa, con tracce di usure e solchi post-mortem dovuti a «cause meccaniche piuttosto efficienti». A suo giudizio, le ossa erano da riferire a deposizioni secondarie, con scarnificazione di tipo meccanico e non per combustione, probabilmente con l’utilizzo di «taglienti coltelli per staccare le parti molli dalle ossa». I maschi mostravano un’età da giovanile a senile, mentre le donne da giovanile ad adulta. L’altezza oscillava fra i 163 e 173 centimetri per i maschi e fra i 154 e 158 centimetri per le donne. Il quadro paleopatologico evidenziava «una situazione igienicosanitaria di gruppo piuttosto ottimale». L’unico caso di porosi iperostosica, legata a patologie anemizzanti, come la talassemia o la malaria, riguarda un individuo senile ed è messo in relazione a normali fenomeni trasformativi tipici della vecchiaia, ed anche i fatti artrosici sono da mettere in relazione all’età senile, mentre è assai rara la carie dei denti. In due reperti femminili era tuttavia presente il rachitismo, indiziato dal fenomeno della coxa valga, ossia deformità dell’anca tra testa e collo del femore e lo stesso corpo del femore. In alcuni reperti ossei maschili, invece, la presenza di malformazioni dovute a microtraumi ripetuti o continui, è probabilmente da mettere in relazione con attività che comportavano «lunghe marce in luoghi erti, abitudine a cavalcare bestie da soma, buoi nel particolare». L’economia si ritiene fosse basata, quindi, sulla caccia e sulla pastorizia.
La tomba II ha un ambiente interno a pianta circolare, con bancone addossato alla parete e una nicchia semiellittica a destra dell’ingresso. La facciata di questa tomba è fortemente degradata.
Nella tomba III, situata a breve distanza dalla tomba II, è presente un solo ambiente interno a pianta rettangolare con sviluppo longitudinale. Anche la facciata di questa tomba è fortemente degradata, ma gli elementi planimetrici depongono a favore di un suo inserimento nella classe delle domus a prospetto.
I resti della necropoli di Su Pianu 'e Sas Piras
 Dal centro di Usini ci rechiamo fino alla rotonda che porta al Cimitero Comunale. Qui prendiamo il viale del Riposo che esce dall’abitato in direzione sud ovest, lo seguiamo per circa un chilometro e troviamo, alla destra della strada, il punto dove si possono raggiungere i resti della necropoli di S'Iscia 'e Sas Piras. Proseguiamo con la strada che svolta a sinistra e, dopo quattrocentocinquanta metri, questa strada si immette in un’altra, che a sinistra porta verso la necropoli di S'Elighe Entosu, mentre la prendiamo verso destra e, in circa cinquecento metri, arriviamo nel punto dove, alla destra della strada, si trovano i resti della Necropoli di Su Pianu 'e Sas Piras. Si tratta di un sito funerario nuragico composto da quattro domus de janas.
Dal centro di Usini ci rechiamo fino alla rotonda che porta al Cimitero Comunale. Qui prendiamo il viale del Riposo che esce dall’abitato in direzione sud ovest, lo seguiamo per circa un chilometro e troviamo, alla destra della strada, il punto dove si possono raggiungere i resti della necropoli di S'Iscia 'e Sas Piras. Proseguiamo con la strada che svolta a sinistra e, dopo quattrocentocinquanta metri, questa strada si immette in un’altra, che a sinistra porta verso la necropoli di S'Elighe Entosu, mentre la prendiamo verso destra e, in circa cinquecento metri, arriviamo nel punto dove, alla destra della strada, si trovano i resti della Necropoli di Su Pianu 'e Sas Piras. Si tratta di un sito funerario nuragico composto da quattro domus de janas.
Le indagini svolte hanno appurato che la tomba IV di Su Pianu 'e Sas Piras, costruita presumibilmente al tempo della Cultura di San Michele che si sviluppa nel Neolitico Finale, il periodo che si sviluppa secondo la cronologia calibrata tra il 4000 ed il 3200 avanti Cristo e secondo la datazione tradizionale tra il 3200 ed il 2800 avanti Cristo, come attestato dallo schema della sua pianta a T. La tomba è stata in seguito violata e riutilizzata nell’Eneolitico Finale, la fase cronologica che si sviluppa secondo la cronologia calibrata tra il 2400 ed il 2200 avanti Cristo, e secondo una datazione più tradizionale tra il 2100 ed il 1900 avanti Cristo. E la sua importanza deriva dal rinvenimento suo interno di un reperto in ceramica prodotto dalle genti del Vaso Campaniforme, il che permette di attestare anche nel territorio di Usini di questa manifestazione culturale.
Lungo la SP28 si raggiunge la fonte Su Trogliu Nou
Dal centro di Usini ci rechiamo fino alla rotonda che porta al Cimitero Comunale. Qui prendiamo la via Sos Paris, che diventa la SP28 e si dirige verso Ittiri. Percorsi circa cinquecento metri, si trovano le indicazioni per prendere una deviazione sulla destra in una strada bianca che in duecentocinquanta metri porta a raggiungere la fonte Su Trogliu Nou, ossia la fonte nuova. Si tratta di una fonte di Usini con annesso un lavatoio coperto, collegata al circuito Ippovia Mediterraneo.
I resti della necropoli di S’Elighe Entosu

 Dal centro di Usini prendiamo la SP28 e si dirige verso sud in direzione di Ittiri e percorriamo settecento metri. Quindi, seguendo le indicazioni, svoltiamo a destra, dopo cinquecento metri svoltiamo a sinistra, ed il duecento metri raggiungiamo il parcheggio di ghiaia. Lasciamo qui il nostro mezzo per recarci ad esplorare la Necropoli di S'Elighe Entosu, ossia l’elce ventoso, un sito archeologico costituito da tombe ipogeiche del tipo a domus de janas scavate in grossi blocchi isolati di roccia calcarea, staccatisi a suo tempo dalla sovrastante parete rocciosa. Le sette domus di S’Elighe Entosu sono localizzate sulle pendici della collina posizionataimmediatamente sotto l’altipiano di Sos Paris de Fummosas e vengono qui indicate secondo la recente numerazione di Maria Grazia Melis. La necropoli è costituita da sette ipogei tardo neolitici, ai quali si aggiungono una grotticella mal conservata in località S'Abbadosu 'e Sa Tanca, recentemente denominata come tomba I, ed una tomba che si inquadra nell’ambito degli ipogei a prospetto architettonico in località Funtana 'e Sa Ide, che è stata recentemente denominata come tomba VII. Il sito, appartenente cronologicamente al Neolitico, è stato oggetto di indagini archeologiche durante gli anni settanta del Novecento.
Dal centro di Usini prendiamo la SP28 e si dirige verso sud in direzione di Ittiri e percorriamo settecento metri. Quindi, seguendo le indicazioni, svoltiamo a destra, dopo cinquecento metri svoltiamo a sinistra, ed il duecento metri raggiungiamo il parcheggio di ghiaia. Lasciamo qui il nostro mezzo per recarci ad esplorare la Necropoli di S'Elighe Entosu, ossia l’elce ventoso, un sito archeologico costituito da tombe ipogeiche del tipo a domus de janas scavate in grossi blocchi isolati di roccia calcarea, staccatisi a suo tempo dalla sovrastante parete rocciosa. Le sette domus di S’Elighe Entosu sono localizzate sulle pendici della collina posizionataimmediatamente sotto l’altipiano di Sos Paris de Fummosas e vengono qui indicate secondo la recente numerazione di Maria Grazia Melis. La necropoli è costituita da sette ipogei tardo neolitici, ai quali si aggiungono una grotticella mal conservata in località S'Abbadosu 'e Sa Tanca, recentemente denominata come tomba I, ed una tomba che si inquadra nell’ambito degli ipogei a prospetto architettonico in località Funtana 'e Sa Ide, che è stata recentemente denominata come tomba VII. Il sito, appartenente cronologicamente al Neolitico, è stato oggetto di indagini archeologiche durante gli anni settanta del Novecento.
 Dal parcheggio, ritornati indietro verso nord ovest, a poco più di un centinaio di metri di distanza di trova la Fonte S'Abbadosu 'e Sa Tanca, una fontana di recente valorizzata nel quadro della sistemazione dell’area di sosta da cui parte il sentiero che conduce alla necropoli di S’Elighe Entosu. A breve distanza si trova la tomba di S'Abbadosu 'e Sa Tanca, che è stata successivamente annoverata come tomba I della necropoli ipogeica di S’Elighe Entosu. Si presenta completamente priva dell’intero prospetto, come se la tomba fosse stata sezionata circa a metà e fosse stata asportata di netto tutta la parte anteriore, e presenta un tale stato di rovina da non consentire una sua attribuzione tipologica se non in via ipotetica, dato che gli elementi planimetrici depongono a favore di un suo inserimento nella classe delle domus a prospetto. Quel che resta è una parte di un vano all’incirca quadrangolare, con soffitto lievemente incurvato al centro. Nel lato sinistro, verso il fondo, si apre una sorta di nicchia irregolare alla base della parete, ma potrebbe tuttavia trattarsi di una scasso nella roccia dovuto all’usura della pietra calcarea.
Dal parcheggio, ritornati indietro verso nord ovest, a poco più di un centinaio di metri di distanza di trova la Fonte S'Abbadosu 'e Sa Tanca, una fontana di recente valorizzata nel quadro della sistemazione dell’area di sosta da cui parte il sentiero che conduce alla necropoli di S’Elighe Entosu. A breve distanza si trova la tomba di S'Abbadosu 'e Sa Tanca, che è stata successivamente annoverata come tomba I della necropoli ipogeica di S’Elighe Entosu. Si presenta completamente priva dell’intero prospetto, come se la tomba fosse stata sezionata circa a metà e fosse stata asportata di netto tutta la parte anteriore, e presenta un tale stato di rovina da non consentire una sua attribuzione tipologica se non in via ipotetica, dato che gli elementi planimetrici depongono a favore di un suo inserimento nella classe delle domus a prospetto. Quel che resta è una parte di un vano all’incirca quadrangolare, con soffitto lievemente incurvato al centro. Nel lato sinistro, verso il fondo, si apre una sorta di nicchia irregolare alla base della parete, ma potrebbe tuttavia trattarsi di una scasso nella roccia dovuto all’usura della pietra calcarea.
Dal parcheggio verso sud est si raggiunge la parte orientale della necropoli. Dirigendosi verso sud, si trovano le Tombe II, IX e un poco più a sud la tomba VI. L’ingresso alla tomba II è rialzato rispetto al piano di calpestio attuale, ma il deterioramento della parete calcarea non consente ulteriori approfondimenti. Durante le ricerche, in questa tomba è stato rinvenuto un inedito motivo inciso, appena visibile ad occhio nudo, relativo alla rappresentazione del tetto ligneo.
L’ingresso della tomba IX è totalmente crollato. All’interno sono presenti due vani residui, ed uno dei vani, originariamente circolare, è stato successivamente allargato verso destra.
L’ingresso della tomba VI è rialzato rispetto al piano di calpestio attuale, ma il deterioramento della parete calcarea non consente ulteriori approfondimenti. La parete laterale destra in epoca successiva al primo impianto ha subito uno sfondamento, che ha portato alla realizzazione di una cavità aperta delimitato da un setto in rilievo.
Piu a sud rispetto alla tomba VI si trovano le Tombe V e VIII. Totalmente crollato l’ngresso alla tomba V. Si tratta di una tomba pluricellulare con diverse camere accessibili da quella principale, e con una bella sala caratterizzata da un tetto a doppio spiovente, completo di trave di colmo e travetti laterali, lesene ed un motivo scalariforme, peculiare del territorio di Usini e di quelli limitrofi. Sul lato breve opposto all’ingresso sono scolpite le linee di contorno del trave di colmo e di quelli laterali che vogliono riprodurre gli elementi architettonici in legno delle abitazioni di allora. Sul pavimento, al centro della sala, è ben visibile il motivo circolare del focolare domestico.
Anche la tomba VIII ha un ingresso a corridoio, il quale, nonostante sia parzialmente crollato nel primo tratto, invaso dalla vegetazione e delimitato da un muretto a secco recente che lo taglia trasversalmente in prossimità della parte crollata, è leggibile per una buona parte. In esso sono inoltre presenti quattro nicchiette, due per parete laterale. La loro posizione ad un’altezza di circa un metro e mezzo e la possibilità che almeno una di esse fosse scavata al di sotto di una sporgenza del muro o in corrispondenza di una parte coperta del corridoio, porterebbe ad escludere un utilizzo come pedarole.
Dal parcheggio, raggiunta la parte orientale della necropoli, dirigendo verso nord si trovano la tomba III e la tomba IV, che presentano caratteri di maggiore monumentalità rispetto alle altre, anche a causa della presenza di un lungo corridoio di ingresso. Alla tomba III, chiamata anche tomba delle sette stanze, si accede mediante un lungo corridoio d’ingresso, seguito da una camera rettangolare e da un’anticella che conduce alla camera principale, intorno alla quale si aprono, a corona, altre sette celle. Anche in questa tomba è di particolare rilievo l’imitazione di elementi tratti dall’architettura domestica in uso all’epoca come il focolare in pietra al centro della camera principale, i pilastri modellati a ricordo dei pali lignei che sostenevano i tetti delle case, le cornici che inquadrano alcuni dei portelli d’ingresso alle celle. La tomba è stata in seguito utilizzata nelle fasi del campaniforme, nuragica, punica e romana. All’interno di questa tomba, al centro della camera principale, è rappresentata scolpita sul pavimento, la riproduzione del focolare. Le colonne, ricavate dalla roccia, sembrano reggere la volta piana dell’ipogeo e rappresentano le strutture lignee, che nella casa dei vivi sostenevano il trave di colmo del tetto. Inoltre le cellette da deposizione, che fanno da corona al vano centrale, risultano rialzate rispetto al piano di terra, in modo che i loro portelli di ingresso rappresentino le vere aperture laterali, che servivano da finestre nelle capanne prenuragiche. La tomba III ha restituito lembi del deposito archeologico nel corridoio, anche se la maggior parte dei materiali è stata rinvenuta all’esterno, come i resti delle deposizioni e dei corredi, nel corso dei ripetuti riutilizzi. Risultano molto rari i materiali relativi al primo utilizzo, tra questi è presente un frammento di statuina in marmo.
Anche la tomba IV spicca per la presenza di elementi architettonici tipici delle coeve abitazioni, quali travi e travetti a riprodurre un tetto a doppio spiovente, cornici, lesene, zoccolature, gradini e false porte, scolpiti a bassorilievo nella roccia, tendenti a ricreare un ambiente dall’aspetto simile al luogo in cui il defunto aveva trascorso la sua esistenza. Questa tomba si contraddistingue per il lunghissimo corridoio d’ingresso, di evidente funzione cerimoniale. La struttura architettonica e il deposito culturale, sono stati fortemente danneggiati a causa dei ripetuti utilizzi, in particolar modo quelli di epoca contemporanea. Presenta riprodotto nella parte alta del portello d’ingresso, il disegno del doppio spiovente, che doveva coprire la struttura portante della dimora dei vivi.
La tomba di Funtana 'e Sa Ide prende il nome da una fontana che si trovava nelle vicinanze e, nonostante la relativa distanza, viene annoverata fra quelle della necropoli di S’Elighe Entosu, con la denominazione di tomba VII. È una tomba a prospetto archtettonico, l’area del prospetto è completamente rovinata anche a seguito dell’ampliamento della porta di accesso, si riconoscono a fatica, nella parte superiore, pochissime e incerte tracce del motivo della stele, forse un lembo della base della lunetta, realizzata a specchio ribassato. L’accesso è dato oggi da un ampio squarcio irregolare, che introduce in una camera di pianta rettangolare con soffitto piano. Alle pareti sono presenti due nicchie sopraelevate, di pianta semiellittica, non simmetriche fra loro. In questa stessa parete sinistra, ad appena dieci centimetri dal piano di calpestio costituito da uno strato di terra e pietrame, è presente un incavo in forma di nicchia semicircolare, che si ritiene possa trattarsi di un tentativo di ampliamento in una fase di riuso dell’ipogeo.
I resti della necropoli di Molineddu

 Dal centro di Usini abbiamo preso la SP28 e si dirige verso sud in direzione di Ittiri e, dopo aver percorso settecento metri, abbiamo trovato la deviazione a destra per la necropoli di S’Elighe Entosu. Proseguiamo verso sud con la SP28 e, dopo altri due chilometri e seicento metri, parte tutta a sinistra la deviazione sulla SP97 che torna indietro e si dirige verso Banari. Poco prima della deviazione, verso nord si sviluppa la parete calcarea sulla quale sono state scavate in grossi blocchi isolati di roccia, staccatisi a suo tempo dalla sovrastante parete rocciosa, le domus de janas che costituiscono la Necropoli di Molineddu. Questa necropoli è costituita da cinque ipogei riferibili all’età del rame, dei quali di cui almeno due a prospetto architettonico, che si aprono alla base del versante della collina sulle cui pendici si distende la necropoli di S’Elighe Entosu. Le tombe vengono qui indicate non secondo la numerazione tradizionale, ma secondo la recente numerazione proposta da Paolo Melis e da Maria Grazia Melis, derivante dallo studio di Gianfranco Ghiani.
Dal centro di Usini abbiamo preso la SP28 e si dirige verso sud in direzione di Ittiri e, dopo aver percorso settecento metri, abbiamo trovato la deviazione a destra per la necropoli di S’Elighe Entosu. Proseguiamo verso sud con la SP28 e, dopo altri due chilometri e seicento metri, parte tutta a sinistra la deviazione sulla SP97 che torna indietro e si dirige verso Banari. Poco prima della deviazione, verso nord si sviluppa la parete calcarea sulla quale sono state scavate in grossi blocchi isolati di roccia, staccatisi a suo tempo dalla sovrastante parete rocciosa, le domus de janas che costituiscono la Necropoli di Molineddu. Questa necropoli è costituita da cinque ipogei riferibili all’età del rame, dei quali di cui almeno due a prospetto architettonico, che si aprono alla base del versante della collina sulle cui pendici si distende la necropoli di S’Elighe Entosu. Le tombe vengono qui indicate non secondo la numerazione tradizionale, ma secondo la recente numerazione proposta da Paolo Melis e da Maria Grazia Melis, derivante dallo studio di Gianfranco Ghiani.
Partendo da sud, a nord della SP28 si trova per prima la tomba V, che era chiamata tomba I da Giovanni Sanna. La tomba, ubicata a 120 metri di altezza poco sopra la SP28, è ricavata alla base di un’alta parte calcarea, che guarda direttamente la valle attraversata dal Rio Mannu. Si tratta di una tomba a prospetto architettonico, che si apre a mezza costa di un pendio calcareo piuttosto scosceso, ma è comunque raggiungibile abbastanza agevolmente. Non conserva ormai quasi niente del motivo a stele, andato perso a causa della scarsa consistenza della roccia, fortemente dilavata e consumata dall’esposizione agli agenti atmosferici, ma in tempi relativamente recenti era ancora possibile apprezzare nella facciata la regolarizzazione della parete calcarea, e nel 1997 era visibile la linea della base della stele. Sul lato sinistro, rispetto a chi dall’esterno guarda l’ingresso, parrebbe notarsi il profilo inferiore dell’esedra, mentre sul prospetto, un taglio semilunato nella fronte rocciosa, è ciò che resta della stele centinata. Da un portello si accede ad un vano di forma trapezoidale, con pavimento piano e ben lavorato nelle superfici. Quasi centrale al pavimento è ricavata una fossetta circolare che richiama l’idea del focolare riprodotto spesso al centro delle domus de janas, anche se tale elemento è rarissimo nel contesto delle tombe a prospetto architettonico. Sul lato meridionale, in corrispondenza dell’ingresso, è presente un bancone sedile, mentre nella parete destra si apre una nicchia reniforme.
A centocinquanta metri di distanza, sempre un poco al di sopra della SP28, si trova quella che veniva precedentemente chiamata tomba I e che oggi chiamiamo tomba II, Questa tomba presenta al suo interno una sola stanza, nella quale si trova una nicchia sulla parete destra.
Ad altri centocinquanta metri di distanza, a sud della SP28 ed a nord della SP97, si trova quella che veniva precedentemente chiamata tomba III e che oggi chiamiamo tomba IV, che era chiamata tomba di Sas Iscias III da Giovanni Sanna. Presenta un’architettura di difficile lettura a causa del pessimo stato di conservazione, forse anche a seguito di stacchi di roccia dovuti ad attività di cava, sono infatti scomparsi l’intero prospetto e l’area del tumulo superiore. Residua all’interno una camera rettangolare fortemente interrata con il soffitto piano, nella quale sul lato destro è presente una nicchia semiellittica, con apertura quadrangolare. Una possibile articolazione planimetrica più complessa è suggerita dalla presenza di una seconda camera, individuata durante il censimento del 1997. L’approfondimento dell’indagine sul campo potrà chiarire se si tratti di un ipogeo risalente all’età del Bronzo medio, come supposto da Paolo Melis, di una semplice domu de janas o di una domu de janas con facciata architettonica.
A quasi duecento metri di distanza, a nord della SP97 che è la moderna strada che conduce a Banati e corre parallela al corso del Rio Mannu, si trovano vicine tra di loro la tomba I e la tomba III.
Quella che veniva precedentemente chiamata tomba II e che oggi chiamiamo tomba I, che era chiamata tomba di Sas Iscias II da Giovanni Sanna, ubicata a 98 metri di altezza poco sopra la SP97, è stata sicuramente oggetto di riutilizzo in tempi recenti, come dimostra l’ampia porta rettangolare ottenuta ingrandendo il portello originario, provvista anche di cardini metallici. Si tratta di una tomba a prospetto architettonico, ed anche in questo caso il prospetto appare notevolmente dilavato, tanto che non si riconosce il motivo della stele centinata, ed analogamente anche l’area del tumulo non è più individuabile. Dl portello a luce rettangolare rivolto a sud, si accede all’interno di un vano di pianta rettangolare che, nelle stagioni piovose, è solitamente ricolmo d’acqua. Il portello è stato manomesso nei tempi recenti, impiegando cemento e cardini in ferro per alloggiare una porta. Le pareti del vano funerario sono ben lavorate nelle superfici, e appaiono leggermente inclinate verso l’interno. Il pavimento è piano e presenta al centro un setto divisorio in parte rovinato, impostato trasversalmente alla camera. Il soffitto è anch’esso piano. Sulla parete destra della camera funeraria, è presente un’apertura rettangolare rialzata rispetto al piano di calpestio, che immette in una nicchia di forma leggermente trapezoidale. Sul pavimento della nicchia si osserva un foro diagonale che comunica con una sorta di canaletta obliqua, ottenuta ribassando la superficie rocciosa della parete laterale del vano sepolcrale.
Quella che veniva precedentemente chiamata tomba IV e che oggi chiamiamo tomba III, che era chiamata tomba di Sas Iscias I da Giovanni Sanna, la quale è attigua alla tomba I, la cui fronte, che si apre a livello del piano stradale, è completamente scomparsa e quindi non vi sono elementi diagnostici del prospetto che possano aiutarci nell’attribuzione tipologica dell’ipogeo. È da considerare una tomba monocellulare neolitica, resta infatti una camera di forma subtrapezoidale con il soffitto piano che residua solo nella parte terminale del vano. Nella tomba è rappresentata la falsa porta, costituita da tre cornici inscritte l’una nell’altra e ribassate, secondo uno schema noto nell’ambito dell’ipogeismo sardo. Nella parete di fondo si apre un incasso rettangolare, al cui interno è incavata un’altra nicchia più piccola, incasso che è interpretabile come l’inizio dello scavo di una seconda camera.
Come abbiamo detto, la necropoli di Molineddu è costituita da cinque tombe ubicate sul medio e basso versante della collina sopra la quale si trova la necropoli di S'Eleghe Entosu, ma è stata recentemente inviduata anche un’altra tomba chiamata la tomba VI , che è situata circa cinquecento metri più a nord est, in una posizione distante rispetto al gruppo delle tombe della necropoli. Su di essa non abbiamo, però, ulteriori notizie.
La prossima tappa del nostro viaggio
Nella prossima tappa del nostro viaggio, da Usini ci recheremo a visitare Uri con i suoi dintorni, nei quali si trova il lago artificiale del Cuga con i siti archeologici parzialemente o totalmente sommersi e con la chiesa di San Leonardo al Cuga.
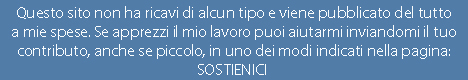
Tutte le foto e riprese sono state effettuate a scopo amatoriale per uso personale senza fini di lucro. Alle nostre foto se ne aggiungono altre inviateci da amici ed alcune tratte da Internet. Alcune informazioni sulle descrizioni dei comuni sono tratte da italiapedia.it, informazioni sui siti archeologici da tharros.info e molte foto da donnanuragica.com, descrizoni e foto di Chiese da Chiesedisardegna.weebly.com, foto di impianti sportivi da sardegnasport.it, altre da siti differenti. È consentito scaricare testi, foto e riprese dell’autore per uso privato senza eliminare i riferimenti. Libri e filmati sono riprodotti per farli conoscere ma non è consentita la riproduzione delle foto di terzi, dei libri, dei filmati e di altro materiale non realizzato dall’autore. È vietato qualsiasi utilizzo commerciale del materiale in assenza di apposita autorizzazione. |
© Claudio de Tisi 2002-2023 - Codice Fiscale DTSCLD44M23F132W




















































































































































