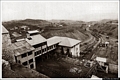Un sito di oltre 450 pagine che descrive tutta l’Isola e che pur non vendendo niente riceve da 300 a oltre 1400 visitatori ogni giorno

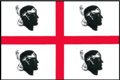

I dintorni di Carbonia con l’importante area archeologica del Monte Sirai e con le diverse frazioni a nord dell’abitato
In questa tappa del nostro viaggio, ci recheremo a visitare i dintorni della Città di Carbonia, con l’importante area archeologica del Monte Sirai e con le diverse frazioni a nord dell’abitato ed i resti delle miniere nei loro territori.
Visita dei dintorni a nord ovest dell’abitato della città di Carbonia
Inizieremo, ora, la visita dei dintorni a nord ovest di Carbonia, con le diverse frazioni che si trovano lungo la SS126 Sud Occidentale Sarda che collega Carbonia con Gonnesa. Vedremo lungo questa strada anche l’area archeologica fenicio punica di Monte Sirai.
L’area archeologica neolitica e fenicio punica di Monte Sirai
Dal centro di Carbonia, dalla piazza Roma dove si trova il Municipio, prendiamo la via Roma e seguiamo la strada che ci conduce alla rotonda di Is Gallus sulla SS126 Sud Occidentale Sarda, che, presa verso nord, collega Carbonia con Gonnesa. Seguita per un chilometro e trecento metri, passato da duecento metri il cartello segnaletico che indica il chilometro 16, se prendiamo a sinistra la deviazione andiamo a visitare l’Area PIP, ossia del Piano degli Insediamenti Produttivi, di Carbonia.
 Percorsi altri duecento metri lungo la SS126 Sud Occidentale Sarda, all’altezza del cartello segnaletico che indica il chilometro 17, seguendo le indicazioni sulla sinistra per Monte Sirai, svoltiamo a sinistra e, dopo un centinaio di metri, a destra sulla strada di accesso a Monte Sirai. Seguendo questa strada, raggiungiamo in circa due chilometri l’area archeologica fenicio punica di Monte Sirai, nella quale sono compresi una piccola necropoli a tombe a camera ipogeica tipo domus de janas, un villaggio di capanne eneolitico, i ruderi di un nuraghe ed un esteso villaggio d’età fenicio punica. Il villaggio fenicio punico si articola in almeno tre spazi: la necropoli, il tofet e l’abitato fortificato. A partire dagli anni sessanta del Novecento si sono condotti, con alcune interruzioni, interventi e campagne di scavo nell’area archeologica di Monte Sirai. Dal 1963 al 1966 le campagne di scavo sono state condotte sotto la direzione di Ferruccio Barreca e Giovanni Garbini; nel 1979 seguite da Piero Bartoloni; nel 1980-1985 a cura di Sandro Filippo Bondì; dal 1981 ad oggi sono dirette nuovamente da Piero Bartoloni.
Percorsi altri duecento metri lungo la SS126 Sud Occidentale Sarda, all’altezza del cartello segnaletico che indica il chilometro 17, seguendo le indicazioni sulla sinistra per Monte Sirai, svoltiamo a sinistra e, dopo un centinaio di metri, a destra sulla strada di accesso a Monte Sirai. Seguendo questa strada, raggiungiamo in circa due chilometri l’area archeologica fenicio punica di Monte Sirai, nella quale sono compresi una piccola necropoli a tombe a camera ipogeica tipo domus de janas, un villaggio di capanne eneolitico, i ruderi di un nuraghe ed un esteso villaggio d’età fenicio punica. Il villaggio fenicio punico si articola in almeno tre spazi: la necropoli, il tofet e l’abitato fortificato. A partire dagli anni sessanta del Novecento si sono condotti, con alcune interruzioni, interventi e campagne di scavo nell’area archeologica di Monte Sirai. Dal 1963 al 1966 le campagne di scavo sono state condotte sotto la direzione di Ferruccio Barreca e Giovanni Garbini; nel 1979 seguite da Piero Bartoloni; nel 1980-1985 a cura di Sandro Filippo Bondì; dal 1981 ad oggi sono dirette nuovamente da Piero Bartoloni.
Brevi cenni storici
 L’insediamento era costituito da una città fortificata, edificata sulla sommità di un altopiano vulcanico all’altezza di circa 194 metri, in una posizione dominante tutta la pianura e la costa, nell’ottavo secolo avanti Cristo dai Fenici, probabilmente dagli abitanti della vicina città di Sulci, l’attuale Sant’Antioco. Durante la spedizione dei Cartaginesi guidati da Malco per invadere la Sardegna, la resistenza della popolazione locale distrugge la fortezza perché non cada nelle loro mani. Successivamente, quando i Cartaginesi arrivano ad occupare l’isola, tra il sesto ed il quinto secolo avanti Cristo, la ricostruiscono, e quello che è arrivato fino a noi è in gran parte di questo secondo periodo. L’insediamento di Monte Sirai conosce una nuova fase di sviluppo, nel quarto secolo la città viene munita di una cinta muraria, con uno spessore massimo di quattro metri, e aumenta per dimensioni ed importanza. Quindi l’insediamento ha la sua massima espansione fra il quarto ed il secondo secolo avanti Cristo, fra l’et tardo punica e quella romano repubblicana. Con la successiva conquista romana, la città non subisce alcuna distruzione, ma tutte le fortificazioni che circondano l’acropoli vengono rase al suolo. Segue l’improvviso abbandono nel 110 avanti Cristo per cause ancora sconosciute.
L’insediamento era costituito da una città fortificata, edificata sulla sommità di un altopiano vulcanico all’altezza di circa 194 metri, in una posizione dominante tutta la pianura e la costa, nell’ottavo secolo avanti Cristo dai Fenici, probabilmente dagli abitanti della vicina città di Sulci, l’attuale Sant’Antioco. Durante la spedizione dei Cartaginesi guidati da Malco per invadere la Sardegna, la resistenza della popolazione locale distrugge la fortezza perché non cada nelle loro mani. Successivamente, quando i Cartaginesi arrivano ad occupare l’isola, tra il sesto ed il quinto secolo avanti Cristo, la ricostruiscono, e quello che è arrivato fino a noi è in gran parte di questo secondo periodo. L’insediamento di Monte Sirai conosce una nuova fase di sviluppo, nel quarto secolo la città viene munita di una cinta muraria, con uno spessore massimo di quattro metri, e aumenta per dimensioni ed importanza. Quindi l’insediamento ha la sua massima espansione fra il quarto ed il secondo secolo avanti Cristo, fra l’et tardo punica e quella romano repubblicana. Con la successiva conquista romana, la città non subisce alcuna distruzione, ma tutte le fortificazioni che circondano l’acropoli vengono rase al suolo. Segue l’improvviso abbandono nel 110 avanti Cristo per cause ancora sconosciute.
Le necropoli fenicia con le tombe a fossa
 È possibile salire in macchina fino alla sommità del colle sul quale era stata edificata. Iniziando la visita dell’area archeologica dalla valle delle necropoli, incontriamo prima i resti dell’ampia Necropoli fenicia tutta composta da tombe singole a fossa scavate nel tufo, della quale rimangono ad oggi circa una settantina di fosse di incinerazione. Come in tutte le città fenicie della Sardegna, anche qui si praticava soprattutto il rito dell’incinerazione dei defunti. È stato anche possibile riconoscere una variante del rito funebre, che consisteva nella combustione del corpo in un luogo che non coincideva con la fossa, nella quale poi venivano deposti i resti ossei. Sebbene il rito dell’incinerazione fosse prevalente, anche se in misura minore era in uso anche quello dell’inumazione, che consisteva nella deposizione del corpo all’interno di una fossa.
È possibile salire in macchina fino alla sommità del colle sul quale era stata edificata. Iniziando la visita dell’area archeologica dalla valle delle necropoli, incontriamo prima i resti dell’ampia Necropoli fenicia tutta composta da tombe singole a fossa scavate nel tufo, della quale rimangono ad oggi circa una settantina di fosse di incinerazione. Come in tutte le città fenicie della Sardegna, anche qui si praticava soprattutto il rito dell’incinerazione dei defunti. È stato anche possibile riconoscere una variante del rito funebre, che consisteva nella combustione del corpo in un luogo che non coincideva con la fossa, nella quale poi venivano deposti i resti ossei. Sebbene il rito dell’incinerazione fosse prevalente, anche se in misura minore era in uso anche quello dell’inumazione, che consisteva nella deposizione del corpo all’interno di una fossa.
La necropoli punica con le tombe sotterranee a camera
Vicino ad essa è stata edificata la Necropoli punica costituita da tredici tombe sotterranee a camera, due delle quali ricavate con l’ampliamento delle due precedenti domus de janas situate sotto la scarpata del Tophet. A queste tredici, è da aggiungere un corridoio di accesso privo della camera ipogea, probabilmente il tentativo di esecuzione di una tomba non portato a completamento. Mentre tutte le tombe fenicie a incinerazione contenevano un solo corpo, quelle puniche accoglievano numerosi defunti e, viste le loro dimensioni, sono probabilmente da considerare tombe di famiglia. All’interno delle tombe a camera sono presenti i sarcofaghi scavati nella pietra, e sulle pareti mascheroni e simboli sacri.
 La tomba V la più importante e la più grande tomba a camera, costituita da un dromos con scalinata discendente che termina con un pianerottolo su cui si affaccia il portello che introduce alla camera funeraria, con pavimento e soffitto piani. Sulla parete destra ricavato un loculo, sulle altre pareti, due loculi per lato, mentre una nicchia scavata sulla parete destra e una in quella di fondo. l’unica a possedere un pilastro centrale allungato, che suddivide in due lo spazio funerario, e questo elemento fa pensare sia appartenuta ad una famiglia importante della comunit punica. La tomba collettiva conteneva i defunti inumati, pratica introdotta a Monte Sirai con la dominazione cartaginese, non prima della fine del sesto secolo avanti Cristo. Un altro elemento importantissimo che d a questa tomba un certo rilievo societario, il simbolo scolpito sul lato breve sud occidentale del pilastro centrale, quello rivolto verso il portale di accesso, che è il cosiddetto Segno di Tanit rovesciato. La dea Tanit era la divinità femminile punica di carattere lunare, corrispettivo femminile del dio solare Baal, ed era la dea della fecondità, dell’amore e della morte, protettrice di Cartagine, associata a Didone. Il Segno di Tanit è rappresentato da un triangolo col vertice in basso sormontato da una barra orizzontale a sua volta sovrastata da un disco, e qui viene scolpito rovesciato che viene interpretato come il simbolo della divinit protesa dal cielo verso la terra a tutelare il sonno dei defunti, ad indicare quindi che siamo nel regno dei morti. l’unico esempio in cui la dea viene rappresentata in questo modo, e per la sua particolarit , il simbolo di Tanit capovolto, diventato il simbolo del Monte Sirai.
La tomba V la più importante e la più grande tomba a camera, costituita da un dromos con scalinata discendente che termina con un pianerottolo su cui si affaccia il portello che introduce alla camera funeraria, con pavimento e soffitto piani. Sulla parete destra ricavato un loculo, sulle altre pareti, due loculi per lato, mentre una nicchia scavata sulla parete destra e una in quella di fondo. l’unica a possedere un pilastro centrale allungato, che suddivide in due lo spazio funerario, e questo elemento fa pensare sia appartenuta ad una famiglia importante della comunit punica. La tomba collettiva conteneva i defunti inumati, pratica introdotta a Monte Sirai con la dominazione cartaginese, non prima della fine del sesto secolo avanti Cristo. Un altro elemento importantissimo che d a questa tomba un certo rilievo societario, il simbolo scolpito sul lato breve sud occidentale del pilastro centrale, quello rivolto verso il portale di accesso, che è il cosiddetto Segno di Tanit rovesciato. La dea Tanit era la divinità femminile punica di carattere lunare, corrispettivo femminile del dio solare Baal, ed era la dea della fecondità, dell’amore e della morte, protettrice di Cartagine, associata a Didone. Il Segno di Tanit è rappresentato da un triangolo col vertice in basso sormontato da una barra orizzontale a sua volta sovrastata da un disco, e qui viene scolpito rovesciato che viene interpretato come il simbolo della divinit protesa dal cielo verso la terra a tutelare il sonno dei defunti, ad indicare quindi che siamo nel regno dei morti. l’unico esempio in cui la dea viene rappresentata in questo modo, e per la sua particolarit , il simbolo di Tanit capovolto, diventato il simbolo del Monte Sirai.
Importante anche la tomba XI, una tomba a camera costituita da un dromos con scalinata discendente che termina con un pianerottolo su cui si affaccia il portello che introduce alla camera funeraria, con pavimento e soffitto piani. Tre loculi sono ricavati nella parete di fondo e nelle due laterali. Tracce di pittura rossa si osservavano sul soffitto, sulle pareti e sui parapetti dei loculi. La tomba collettiva conteneva i defunti inumati, pratica introdotta a Monte Sirai con la dominazione cartaginese, non prima della fine del sesto secolo avanti Cristo. Lo scavo ha consentito di recuperare numerosi vasi pertinenti ai corredi funerari, poggiati sul pavimento della camera o dentro i loculi, ed anche un fermaglio in bronzo che rappresenta una doppia Tanit, a testimoniare anch’esso la persistenza del culto della dea cartaginese nell’ambiente del Monte Sirai.
I resti delle domus de janas IV e V di Monte Sirai
La Necropoli neolitica di Monte Sirai comprende varie tombe a domus de janas scavate nel tufo, composte da poche camere precedute da un breve corridoio. Più avanti rispetto alla necropoli punica, sotto la scarpata della collina sulla quale sorge il Tophet, si trovano i resti di due domus de janas della necropoli di Monte Sirai, la IV e la V, che sono state successivamente riutilizzate in ambito punico, mentre altre sono situate al centro della valle ma più in basso rispetto alle necropoli. Il villaggio prenuragico al quale appartenevano le domus de janas non doveva essere situato in un luogo molto distante, dato che la valle delle necropoli ha costituito l’unico luogo coltivabile di tutto il monte e, per di più, nella sua parte occidentale era ubicata l’unica sorgente perenne di tutto il circondario.
Sulla porzione settentrionale dell’insediamento si individuano alcune capanne con zoccolo lapideo risalenti all’Età del rame. Sull’acropoli i resti di un nuraghe sono stati parzialmente obliterati dalla costruzione del cosiddetto tempio di Ashtart.
Il Tophet fenicio con il Campo delle urne ed il Tempietto fenicio
 Si passa, quindi, a visitare la collina, una terrazza di trachite affacciata a nord della valle delle necropoli, sotto la quale sono stati trovati i resti del Tophet fenicio, nel quale venivano cremati i bambini morti prematuramente, che non vediamo in quanto è stato successivamente reinterrato. La parola Tophet è un termine di origine biblica che indica una località nei pressi di Gerusalemme, nella quale venivano bruciati e sepolti i bambini, ed oggi, convenzionalmente, indica le aree sacre di età fenicia e punica rinvenute in Sardegna, Sicilia e Tunisia, nella quale sono state recuperate urne contenenti ossa bruciate di bambini e animali. Nel periodo fenicio, e successivamente in quello punico, i bambini non potevano essere sepolti nella necropoli dato che non avevano ancora superato le cerimonie di iniziazione. Venivano quindi sepolti in una località separata, nella nuda terra, nel Tophet, dopo essere stati cremati.
Si passa, quindi, a visitare la collina, una terrazza di trachite affacciata a nord della valle delle necropoli, sotto la quale sono stati trovati i resti del Tophet fenicio, nel quale venivano cremati i bambini morti prematuramente, che non vediamo in quanto è stato successivamente reinterrato. La parola Tophet è un termine di origine biblica che indica una località nei pressi di Gerusalemme, nella quale venivano bruciati e sepolti i bambini, ed oggi, convenzionalmente, indica le aree sacre di età fenicia e punica rinvenute in Sardegna, Sicilia e Tunisia, nella quale sono state recuperate urne contenenti ossa bruciate di bambini e animali. Nel periodo fenicio, e successivamente in quello punico, i bambini non potevano essere sepolti nella necropoli dato che non avevano ancora superato le cerimonie di iniziazione. Venivano quindi sepolti in una località separata, nella nuda terra, nel Tophet, dopo essere stati cremati.

 Il Tophet fenicio, ossia il cimitero dei bambini, del Monte Sirai sorge su una terrazza a nord della valle della necropoli. Si tratta di un vasto piazzale su due livelli, di cui quello inferiore era il cosiddetto Campo delle Urne, nel quale venivano deposte le urne cinerarie dei bambini cremati, deposte sulla roccia e ricoperte di terreno, con una stele commemorativa che segnalava le deposizione. Il livello superiore occupato dal cosiddetto Tempietto fenicio. Il Tophet del Monte Sirai non è ben conservato, e per visitare un più significativo Tophet fenicio ci recheremo, in una delle prossime tappe, a Sant’Antioco dove troveremo quello che è arrivato a noi meglio conservato, il più importante di tutta la Sardegna ed uno dei principali al mondo, dato che solo quello di Cartagine è ad esso superiore come numero di urne e steli funerarie.
Il Tophet fenicio, ossia il cimitero dei bambini, del Monte Sirai sorge su una terrazza a nord della valle della necropoli. Si tratta di un vasto piazzale su due livelli, di cui quello inferiore era il cosiddetto Campo delle Urne, nel quale venivano deposte le urne cinerarie dei bambini cremati, deposte sulla roccia e ricoperte di terreno, con una stele commemorativa che segnalava le deposizione. Il livello superiore occupato dal cosiddetto Tempietto fenicio. Il Tophet del Monte Sirai non è ben conservato, e per visitare un più significativo Tophet fenicio ci recheremo, in una delle prossime tappe, a Sant’Antioco dove troveremo quello che è arrivato a noi meglio conservato, il più importante di tutta la Sardegna ed uno dei principali al mondo, dato che solo quello di Cartagine è ad esso superiore come numero di urne e steli funerarie.
L’acropoli con i resti dell’abitato fortificato

 Più a sud rispetto alla valle della necropoli, si trovano i resti della città, che era costituita da un’acropoli della larghezza di sessanta metri e della lunghezza di trecento, realizzata dapprima dai Fenici. I Cartaginesi, successivamente, hanno trasformato l’abitato fenicio in una fortezza. L’abitato fortificato si compone di quattro isolati di edifici di case a schiera con pianta quadrangolare, suddivisi in più vani. I suoi isolati sono stati chiamati nella storia degli studi insulae, messi in relazione da piccole piazze e strade disposte a scacchiera, edifici di prevalente uso abitativo, ma anche artigianali e religiosi. Nella nostra visita, percorriamo i resti dell’abitato, e se si prescinde da due agglomerati di case addossati alla fronte dell’abitato, ognuno dei quattro quartieri di cui era composta l’acropoli era formato da una doppia fila di case, che si affacciavano ciascuna su una strada diversa. Le case di abitazione avevano un unico ingresso sulla strada e il retro era in comune con l’abitazione opposta, che si affacciava sull’altra strada.
Più a sud rispetto alla valle della necropoli, si trovano i resti della città, che era costituita da un’acropoli della larghezza di sessanta metri e della lunghezza di trecento, realizzata dapprima dai Fenici. I Cartaginesi, successivamente, hanno trasformato l’abitato fenicio in una fortezza. L’abitato fortificato si compone di quattro isolati di edifici di case a schiera con pianta quadrangolare, suddivisi in più vani. I suoi isolati sono stati chiamati nella storia degli studi insulae, messi in relazione da piccole piazze e strade disposte a scacchiera, edifici di prevalente uso abitativo, ma anche artigianali e religiosi. Nella nostra visita, percorriamo i resti dell’abitato, e se si prescinde da due agglomerati di case addossati alla fronte dell’abitato, ognuno dei quattro quartieri di cui era composta l’acropoli era formato da una doppia fila di case, che si affacciavano ciascuna su una strada diversa. Le case di abitazione avevano un unico ingresso sulla strada e il retro era in comune con l’abitazione opposta, che si affacciava sull’altra strada.

 L’abitato comprende anche un edificio di culto, di pianta quadrangolare, preceduto da una gradinata, tripartito internamente, dedicato verosimilmente alla dea Astarte, la Grande Madre fenicia e cananea, sposa di Adon, legata al cielo notturno, alla fertilità, alla fecondit ed alla guerra. Arriviamo, quindi, alla piazza principale, dove si trovano i resti del Tempio di Ashtart, edificato dai Fenici sui resti del nuraghe di Monte Sirai. Si trattava di un nuraghe monotorre che era stato edificato a 176 metri di altezza, del quale rimangono ancora visibili poche tracce, e che era in contatto visivo sia con nuraghe Sirai che con il nuraghe Seruci di Gonnesa. Probabilmente le pietre che lo costituivano sono state reimpiegate nella costruzione dell’acropoli di Monte Sirai. Il tempio era dedicato ad Ashtart o Asthoreth o Astarte, che era la fenicia dea madre, progenitrice degli esseri viventi, il cui culto comprendeva la prostituzione sacra. Astarte viene spesso raffigurata nuda mentre si stringe i seni, o mentre sorregge fiori di loto o un disco o dei serpenti, o mentre allatta un bambino. Nel tempio è stata rinvenutia la famosa statua della dea risalente al settimo secolo, ed anche un betilo a rappresentare la divinità maschile.
L’abitato comprende anche un edificio di culto, di pianta quadrangolare, preceduto da una gradinata, tripartito internamente, dedicato verosimilmente alla dea Astarte, la Grande Madre fenicia e cananea, sposa di Adon, legata al cielo notturno, alla fertilità, alla fecondit ed alla guerra. Arriviamo, quindi, alla piazza principale, dove si trovano i resti del Tempio di Ashtart, edificato dai Fenici sui resti del nuraghe di Monte Sirai. Si trattava di un nuraghe monotorre che era stato edificato a 176 metri di altezza, del quale rimangono ancora visibili poche tracce, e che era in contatto visivo sia con nuraghe Sirai che con il nuraghe Seruci di Gonnesa. Probabilmente le pietre che lo costituivano sono state reimpiegate nella costruzione dell’acropoli di Monte Sirai. Il tempio era dedicato ad Ashtart o Asthoreth o Astarte, che era la fenicia dea madre, progenitrice degli esseri viventi, il cui culto comprendeva la prostituzione sacra. Astarte viene spesso raffigurata nuda mentre si stringe i seni, o mentre sorregge fiori di loto o un disco o dei serpenti, o mentre allatta un bambino. Nel tempio è stata rinvenutia la famosa statua della dea risalente al settimo secolo, ed anche un betilo a rappresentare la divinità maschile.
Resti del nuraghe Lallai e del nuraghe NW
 All’esterno rispetto all’area archeologica fenicio punica di Monte Sirai, si trovano un sito di archeologia industriale, e diversi altri siti archeologici edificati in periodo prenuragico e nuragico. A nord dell’area archeologica sono presenti i pochi resti del nuraghe Lallai, chiamato anche nuraghe di Costa Lallai, un nuraghe semplice, monotorre, edificato in tufo ossia ignimbrite a 124 metri di altezza, che è però scarsamente visibile e riconoscibile, essendo completamente inglobato da lentisco e cisto. Di questo nuraghe non restano che esigue tracce, in particolare sono presenti soltanto numerosi grossi massi di tufo ossia ignimbrite. Quattrocento metri a sud ovest rispetto al nuraghe Lallai, si trovano poche tracce del nuraghe NW, così chiamato dato che si trova a nord ovest rispetto al Monte Sirai, che era un nuraghe di tipologia indefinita, probabilmente un nuraghe semplice, edificato in materiale indeterminato a 107 metri di altezza.
All’esterno rispetto all’area archeologica fenicio punica di Monte Sirai, si trovano un sito di archeologia industriale, e diversi altri siti archeologici edificati in periodo prenuragico e nuragico. A nord dell’area archeologica sono presenti i pochi resti del nuraghe Lallai, chiamato anche nuraghe di Costa Lallai, un nuraghe semplice, monotorre, edificato in tufo ossia ignimbrite a 124 metri di altezza, che è però scarsamente visibile e riconoscibile, essendo completamente inglobato da lentisco e cisto. Di questo nuraghe non restano che esigue tracce, in particolare sono presenti soltanto numerosi grossi massi di tufo ossia ignimbrite. Quattrocento metri a sud ovest rispetto al nuraghe Lallai, si trovano poche tracce del nuraghe NW, così chiamato dato che si trova a nord ovest rispetto al Monte Sirai, che era un nuraghe di tipologia indefinita, probabilmente un nuraghe semplice, edificato in materiale indeterminato a 107 metri di altezza.
Resti del nuraghe Terra Niedda e ad ovest rispetto ad esso l’area di rimboschimento di Terra Niedda
 Ad ovest rispetto al Tophet fenicio che si trova all’interno dell’area archeologica, a quasi quattrocento metri di sistanza dal Tophet fenicio, a seicento metri di distanza rispetto al nuraghe NW ed a poco più di un chilometro dal nuraghe Lallai, più a sud rispetto a questi nuraghi, sono presenti i pochi resti del nuraghe Terra Niedda, un nuraghe semplice, monotorre, edificato in trachite a 109 metri di altezza, accanto al quale sono presenti anche alcune tracce di un insedimento abitativo. Più ad ovest rispetto a questo nuraghe si trova l’area di rimboschimento di Terra Niedda, che si trova quasi interamente nel territorio comunale di Carbonia, salvo una piccola porzione ubicata nel territorio comunale di Portoscuso, nella quale è stato effettuato un rimboschimento con alberi di pino, e con linee frangivento ai bordi delle strade sterrate.
Ad ovest rispetto al Tophet fenicio che si trova all’interno dell’area archeologica, a quasi quattrocento metri di sistanza dal Tophet fenicio, a seicento metri di distanza rispetto al nuraghe NW ed a poco più di un chilometro dal nuraghe Lallai, più a sud rispetto a questi nuraghi, sono presenti i pochi resti del nuraghe Terra Niedda, un nuraghe semplice, monotorre, edificato in trachite a 109 metri di altezza, accanto al quale sono presenti anche alcune tracce di un insedimento abitativo. Più ad ovest rispetto a questo nuraghe si trova l’area di rimboschimento di Terra Niedda, che si trova quasi interamente nel territorio comunale di Carbonia, salvo una piccola porzione ubicata nel territorio comunale di Portoscuso, nella quale è stato effettuato un rimboschimento con alberi di pino, e con linee frangivento ai bordi delle strade sterrate.
La frazione Medau Rubiu
Lungo la SS126 Sud Occidentale Sarda, all’altezza del cartello segnaletico che indica il chilometro 17, seguendo le indicazioni sulla sinistra per Monte Sirai, svoltiamo a sinistra, evitiamo la deviazione sulla strada di accesso a Monte Sirai e proseguiamo invece dritti verso sud per settecentocinquanta metri, poi a sinistra raggiungiamo le abitazioni della frazione Medau Rubiu (altezza metri 90, distanza in linea d’aria circa 5.8 chilometri, abitanti circa 28). Medau Rubiu, ossia il Casale Rosso, era un tempo un casale agro pastorale che è oggi situato tra l’area PIP, ossia del Piano degli Insediamenti Produttivi, di Carbonia, e la borgata di Sirai. A questa frazione si ritiene appartengano le ultime domus de janas di Monte Sirai, il nuraghe Nuraxieddu ed il nuraghe Sirai, che si trovano nel suo territorio a nord ovest della frazione.
Le domus de janas I II e III di Monte Sirai
Ad ovest rispetto all’acropoli presente nell’area archeologica, si trovano altri resti della Necropoli neolitica comprende varie tombe a domus de janas scavate nel tufo, composte da poche camere precedute da un breve corridoio. La IV e la V sono state già descritte, dato che si trovano all’interno dell’area archeologica, mentre qui vedremo la III, che si trova circa duecento metri ad ovest rispetto alla necropoli punica, mentre trecento metri più a sud si trovano la I e la II.
Il nuraghe Nuraxieddu
 Circa cinquecento metri più a sud est rispetto a queste domus de janas, si trova il nuraghe Nuraxieddu che domina la porzione sud-orientale della piana sottostante il Monte Sirai. Si tratta di un nuraghe edificato a 109 metri di altezza, ed è ancora oggi parzialmente visibile. Questo nuraghe è di incerta tipologia ma, secondo l’archeologo Piero Bartoloni che ha diretto gli scavi archeologici a Sant’Antioco e al Monte Sirai, sarebbe stato un altro nuraghe semplice, monotorre. Sono presenti crolli diffusi delle strutture murarie, le quali sono scarsamente leggibili a causa della fitta vegetazione che le ricopre. Si individua un segmento murario nel versante sud occidentale, realizzato con blocchi parallelepipedi di tufo ossia ignimbrite. Sul lato sud orientale sul pendio sul quale è stato edificato il nuraghe rimangono tracce di un insediamento abitativo.
Circa cinquecento metri più a sud est rispetto a queste domus de janas, si trova il nuraghe Nuraxieddu che domina la porzione sud-orientale della piana sottostante il Monte Sirai. Si tratta di un nuraghe edificato a 109 metri di altezza, ed è ancora oggi parzialmente visibile. Questo nuraghe è di incerta tipologia ma, secondo l’archeologo Piero Bartoloni che ha diretto gli scavi archeologici a Sant’Antioco e al Monte Sirai, sarebbe stato un altro nuraghe semplice, monotorre. Sono presenti crolli diffusi delle strutture murarie, le quali sono scarsamente leggibili a causa della fitta vegetazione che le ricopre. Si individua un segmento murario nel versante sud occidentale, realizzato con blocchi parallelepipedi di tufo ossia ignimbrite. Sul lato sud orientale sul pendio sul quale è stato edificato il nuraghe rimangono tracce di un insediamento abitativo.
Il nuraghe Sirai
Più ad est rispetto a questo nuraghe, dal quale dista cinquecento metri, si trova un’area archeologica che ricopre una superficie di almeno un ettaro di estensione e si trova a meno di vovecento metri di distanza dal noto complesso archeologico di Monte Sirai. Sulla cima di un piccolo colle sono presenti i resti del nuraghe Sirai, un nuraghe complesso di tipo polilobato del quale è ancora incerto il numero esatto delle torri, essendo in fase di scavo, che si pensa siano almeno cinque. Edificato in tufo ossia ignimbrite a 79 metri di altezza, è costituito da un mastio centrale, con bastioni e con diverse torri aggiunte, intorno ai quali si trovava un ampio antemurale. Il nuraghe era anche circondato da un insediamento nuragico, cinto da terrapieni e mura fortificate spesse ben sei metri. Sui costoni del nuraghe sono state individuate delle aree terrazzate adibite al culto e alle produzioni manifatturiere, con di particolare rilevanza e interesse le lavorazioni del vetro e la concia e lavorazione delle pelli.
E vicino a questo insediamento si trovano anche le tracce di fortificazioni risalenti al settimo secolo avanti Cristo, nel periodo di forti contatti con il mondo fenicio. Il nuraghe e il villaggio nuragico circostante, di indubbia importanza per le sue peculiarità, sono attualmente in fase di scavo al fine di rendere fruibile la visita turistica delle loro antiche vestigia.
La frazione Sirai
Lungo la SS126 Sud Occidentale Sarda, all’altezza del cartello segnaletico che indica il chilometro 17, seguendo le indicazioni sulla sinistra per Monte Sirai, avevamo svoltato a sinistra nella strada che ci aveva portati sulla strada di accesso a Monte Sirai ed alla frazione Medau Rubiu. Proseguiamo lungo la SS126 Sud Occidentale Sarda per duecentocinquanta metri ed arriviamo a un raccordo, dove prendiamo la deviazione a destra sulla Strada Statale Sirai seguendo le indicazioni per tornare a Carbonia. Presa questa deviazione, in circa duecentocinquanta metri arriviamo all’interno della frazione Sirai (altezza metri 94, distanza in linea d’aria circa 4.2 chilometri, abitanti circa 289). Una teoria sull’origine del nome lo fa risalire dalla radice semitica sr, che dovrebbe significare rocca, o roccia, o luogo roccioso. Si tratta di un’antica borgata agro pastorale, che oggi è diventata una zona residenziale, con a fianco una zona di vari insediamenti produttivi artigianali, ai piedi del parco archeologico di Monte Sirai e dal vicino nuraghe omonimo, costituito da una fortezza e da un villaggio, abitato in pacifica convivenza da popolazioni nuragiche e fenicie. Per questo motivo, l’area nella quale si trova la frazione è stata, in epoca antica, un importante crocevia di diverse strade che si dirigono dalle zone minerarie metallifere ai porti delle coste sulcitane, oppure dalle zone cerealicole del Campidano verso i porti del Sulcis. Il grande numero di abitanti e limportanza di questa frazione deriva soprattutto dal fatto che nel suo territorio, più ad est rispetto all’abitato, si trova l’Ospedale Sirai.
I ruderi della miniera di Sirai
 Sulla SS126 Sud Occidentale Sarda, presa la deviazione sulla Strada Statale Sirai che porta all’interno dell’abitato della frazione Sirai, proseguiamo per duecentocinquanta metri ed arriviamo a un raccordo, dove prendiamo la deviazione a destra seguendo le indicazioni per tornare a Carbonia. Proseguiamo e dopo altri trecento metri arriviamo una rotonda dove prendiamo verso destra, seguendo le indicazioni per Carbonia, la via Dalmazia, dopo duecentoventi metri in direzione sud est, a un bivio, deviamo a sinistra per rimanere sulla via Dalmazia, e, percorsi cinquecento metri, arriviamo a una rotonda. Qui prendiamo la prima uscita che ci porta sul una strada che si dirige verso sud, ai lati della quale si trovano i ruderi della miniera di Sirai, una delle prime miniere realizzate nel bacino carbonifero del Sulcis, che è stata attiva dal 1918, realizzata per lo sfruttamento del giacimento carbonifero di Schisorgiu. Nella miniera di Sirai si coltivava un giacimento stratiforme carbonioso a lignite, molto disturbato da pieghe e faglie. La miniera è stata caratterizzata dagli impianti estrattivi di pozzo Sirai, pozzo Tanas, pozzo Schisorgiu, pozzo Vigna, pozzo Barbusi, pozzo Nuraxeddu Nuovo, e dagli impianti di pozzo 8, pozzo 9, pozzo 10, pozzo 11, pozzo 12, numerazione che si agginge a quella dei pozzi della successiva miniera di Serbariu, per accogliere il cui personale è stata realizzata la città di Carbonia. Dal 1906 al 1915 si sono alternate nell’area di Sirai, diversi permessi di ricerca per minerali di piombo, argento, zinco, rame, ferro e combustili fossili. La miniera viene concessa alla Società Anonima di Bacu Abis l’8 ottobre del 1919, nel 1934 la concessione viene trasferita alla Società Anonima Carbonifera Sarda, rinnovata nel 1936 alla stessa societàper cinquanta anni. La concessione è scaduta nel 1969.
Sulla SS126 Sud Occidentale Sarda, presa la deviazione sulla Strada Statale Sirai che porta all’interno dell’abitato della frazione Sirai, proseguiamo per duecentocinquanta metri ed arriviamo a un raccordo, dove prendiamo la deviazione a destra seguendo le indicazioni per tornare a Carbonia. Proseguiamo e dopo altri trecento metri arriviamo una rotonda dove prendiamo verso destra, seguendo le indicazioni per Carbonia, la via Dalmazia, dopo duecentoventi metri in direzione sud est, a un bivio, deviamo a sinistra per rimanere sulla via Dalmazia, e, percorsi cinquecento metri, arriviamo a una rotonda. Qui prendiamo la prima uscita che ci porta sul una strada che si dirige verso sud, ai lati della quale si trovano i ruderi della miniera di Sirai, una delle prime miniere realizzate nel bacino carbonifero del Sulcis, che è stata attiva dal 1918, realizzata per lo sfruttamento del giacimento carbonifero di Schisorgiu. Nella miniera di Sirai si coltivava un giacimento stratiforme carbonioso a lignite, molto disturbato da pieghe e faglie. La miniera è stata caratterizzata dagli impianti estrattivi di pozzo Sirai, pozzo Tanas, pozzo Schisorgiu, pozzo Vigna, pozzo Barbusi, pozzo Nuraxeddu Nuovo, e dagli impianti di pozzo 8, pozzo 9, pozzo 10, pozzo 11, pozzo 12, numerazione che si agginge a quella dei pozzi della successiva miniera di Serbariu, per accogliere il cui personale è stata realizzata la città di Carbonia. Dal 1906 al 1915 si sono alternate nell’area di Sirai, diversi permessi di ricerca per minerali di piombo, argento, zinco, rame, ferro e combustili fossili. La miniera viene concessa alla Società Anonima di Bacu Abis l’8 ottobre del 1919, nel 1934 la concessione viene trasferita alla Società Anonima Carbonifera Sarda, rinnovata nel 1936 alla stessa societàper cinquanta anni. La concessione è scaduta nel 1969.
Nella miniera di Sirai nel 1937 il più grave incidente minerario della Sardegna verificatosi
 In questa miniera il 19 ottobre 1937, dieci minuti prima della fine del primo turno lavorativo, ufficialmente registrato alle ore 22:50 circa, nel pozzo Schisorgiu avvenne un tragico incidente in sotterraneo, causato da una forte esplosione data dalla polvere di carbone, durante lo sparo delle mine negli avanzamenti del cantiere del IV fascio. I minatori addetti agli avanzamenti dei cantieri A ed N, dopo aver preparato ed acceso 39 mine, scesero dal fornello G nella galleria di livello +40 per mettersi al riparo. Dopo la volata, una massa notevole di gas si incendi e si propag a forte pressione ed a grande velocità nella galleria dove invest i minatori che si trovarono lungo i cunicoli di passaggio, gettandoli violentemente a terra ed ustionandoli al viso, alle mani e in varie parti del corpo. Tale incidente minerario provocò la morte immediata di cinque minatori, che si trovavano vicini al suddetto fornello, furono violentemente colpiti dall’esplosione e dai terribili effetti dell’ossido di carbonio, i loro corpi presentarono gravissime ustioni e fratture del cranio, tanto che due morirono sul colpo, mentre gli altri tre decedettero poco dopo. Furono, inoltre, ustionati e feriti in modo più o meno grave altri diciassette operai, che si trovavano in galleria F, cioè avevano quasi raggiunto la stazione alla base del pozzo E, e sebbene al buio, per essersi spente tutte le lampade, riuscirono a raggiungere il pozzo stesso e ad uscire coi propri mezzi. Di questi minatori feriti quattro furono rilasciati dopo le prime cure, mentre nove morirono pochi giorni pi tardi, portando a quattordici il numero definitivo delle vittime del grave incidente. Furono così trasportati e ricoverati agli ospedali civili di Iglesias e di Cagliari gli altri feriti più gravi a causa delle ustioni in molte parti del corpo e per fenomeni broncopolmonari infiammatori dovuti a probabile inspirazione di gas tossici e di aria sovrariscaldata.
In questa miniera il 19 ottobre 1937, dieci minuti prima della fine del primo turno lavorativo, ufficialmente registrato alle ore 22:50 circa, nel pozzo Schisorgiu avvenne un tragico incidente in sotterraneo, causato da una forte esplosione data dalla polvere di carbone, durante lo sparo delle mine negli avanzamenti del cantiere del IV fascio. I minatori addetti agli avanzamenti dei cantieri A ed N, dopo aver preparato ed acceso 39 mine, scesero dal fornello G nella galleria di livello +40 per mettersi al riparo. Dopo la volata, una massa notevole di gas si incendi e si propag a forte pressione ed a grande velocità nella galleria dove invest i minatori che si trovarono lungo i cunicoli di passaggio, gettandoli violentemente a terra ed ustionandoli al viso, alle mani e in varie parti del corpo. Tale incidente minerario provocò la morte immediata di cinque minatori, che si trovavano vicini al suddetto fornello, furono violentemente colpiti dall’esplosione e dai terribili effetti dell’ossido di carbonio, i loro corpi presentarono gravissime ustioni e fratture del cranio, tanto che due morirono sul colpo, mentre gli altri tre decedettero poco dopo. Furono, inoltre, ustionati e feriti in modo più o meno grave altri diciassette operai, che si trovavano in galleria F, cioè avevano quasi raggiunto la stazione alla base del pozzo E, e sebbene al buio, per essersi spente tutte le lampade, riuscirono a raggiungere il pozzo stesso e ad uscire coi propri mezzi. Di questi minatori feriti quattro furono rilasciati dopo le prime cure, mentre nove morirono pochi giorni pi tardi, portando a quattordici il numero definitivo delle vittime del grave incidente. Furono così trasportati e ricoverati agli ospedali civili di Iglesias e di Cagliari gli altri feriti più gravi a causa delle ustioni in molte parti del corpo e per fenomeni broncopolmonari infiammatori dovuti a probabile inspirazione di gas tossici e di aria sovrariscaldata.
Nella miniera di Sirai nel 1942 uno dei primi scioperi d’Italia
 Il 2 maggio 1942 a Carbonia vi fu il primo sciopero d’Italia contro il caro vita, organizzato da cellule clandestine del partito comunista all’interno del sindacato corporativo durante il regime fascista, e diretto da Tito Morosini, delegato confederale del sindacato dei lavoratori. Lo sciopero iniziò nella miniera di Sirai e si estese a tutto il bacino carbonifero del Sulcis. Era stato organizzato contro la Carbosarda perché, forte della condizione di azienda militarizzata, attuò un regime di sfruttamento con provvedimenti arbitrari come l’aumento del costo dei viveri di prima necessit negli spacci aziendali e il costo dell’energia, fino all’aumento degli affitti per le case dei minatori e per gli alberghi operai, in contrasto con gli accordi contrattuali, tanto che vi fu quasi subito un’unanime reazione di contrapposizione da tutti i lavoratori del bacino carbonifero del Sulcis. Un’idea dell’organizzazione clandestina comunista, all’interno delle gallerie minerarie, si può avere, ad esempio, visionando qualche scena e diverse inquadrature del film Il figlio di Bakunìn, del 1997, diretto dal regista Gianfranco Cabiddu e ispirato all’omonimo romanzo dello scrittore Sergio Atzeni, prematuramente scomparso.
Il 2 maggio 1942 a Carbonia vi fu il primo sciopero d’Italia contro il caro vita, organizzato da cellule clandestine del partito comunista all’interno del sindacato corporativo durante il regime fascista, e diretto da Tito Morosini, delegato confederale del sindacato dei lavoratori. Lo sciopero iniziò nella miniera di Sirai e si estese a tutto il bacino carbonifero del Sulcis. Era stato organizzato contro la Carbosarda perché, forte della condizione di azienda militarizzata, attuò un regime di sfruttamento con provvedimenti arbitrari come l’aumento del costo dei viveri di prima necessit negli spacci aziendali e il costo dell’energia, fino all’aumento degli affitti per le case dei minatori e per gli alberghi operai, in contrasto con gli accordi contrattuali, tanto che vi fu quasi subito un’unanime reazione di contrapposizione da tutti i lavoratori del bacino carbonifero del Sulcis. Un’idea dell’organizzazione clandestina comunista, all’interno delle gallerie minerarie, si può avere, ad esempio, visionando qualche scena e diverse inquadrature del film Il figlio di Bakunìn, del 1997, diretto dal regista Gianfranco Cabiddu e ispirato all’omonimo romanzo dello scrittore Sergio Atzeni, prematuramente scomparso.
I resti della stazione ferroviaria di Sirai
 Per il trasporto dei materiali estratti nella miniera di Sirai, le Ferrovie Meridionali Sarde nel 1930 hanno aperto la Stazione ferroviaria di Sirai, una fermata ferroviaria situata lungo la dismessa linea che collegava San Giovanni Suergiu con Iglesias. La fermata è stata istituita in corrispondenza della casa cantoniera numero quarantadue della propria rete ferroviaria in un’area all’epoca in pieno sviluppo per via dell’attivit estrattiva legata al carbone. Inoltre, dinanzi a questa fermata, convergevano anche i binari di una breve linea mineraria che collegava i pozzi carboniferi dei dintorni. Nel secondo dopoguerra, al binario a scartamento ridotto della linea per Iglesias e San Giovanni Suergiu si era affiancato anche quello della linea delle Ferrovie dello Stato che collegava Villamassargia con Carbonia, che però non si servirono mai dell’impianto. Lo scalo di Sirai è rimasto in uso sino al 1974, data di cessazione del servizio ferroviario sull’intera rete delle Ferrovie Meridionali Sarde, da quando la fermata di Sirai non pi attiva e l’infrastruttura ferroviaria stata smantellata negli anni successivi. Il fabbricato viaggiatori si trovava prendendo la deviazione verso destra dalla SS126 Sud Occidentale Sarda all’altezza del chilometro 16.9, ossia circa duecentocinquanta metri prima del raccordo con la strada statale Sirai, e la si trova sulla destra dopo una settantina di metri. Oggi questo fabbricato ancora esistente ed in uso come abitazione privata, sebbene alterato rispetto alla pianta originale.
Per il trasporto dei materiali estratti nella miniera di Sirai, le Ferrovie Meridionali Sarde nel 1930 hanno aperto la Stazione ferroviaria di Sirai, una fermata ferroviaria situata lungo la dismessa linea che collegava San Giovanni Suergiu con Iglesias. La fermata è stata istituita in corrispondenza della casa cantoniera numero quarantadue della propria rete ferroviaria in un’area all’epoca in pieno sviluppo per via dell’attivit estrattiva legata al carbone. Inoltre, dinanzi a questa fermata, convergevano anche i binari di una breve linea mineraria che collegava i pozzi carboniferi dei dintorni. Nel secondo dopoguerra, al binario a scartamento ridotto della linea per Iglesias e San Giovanni Suergiu si era affiancato anche quello della linea delle Ferrovie dello Stato che collegava Villamassargia con Carbonia, che però non si servirono mai dell’impianto. Lo scalo di Sirai è rimasto in uso sino al 1974, data di cessazione del servizio ferroviario sull’intera rete delle Ferrovie Meridionali Sarde, da quando la fermata di Sirai non pi attiva e l’infrastruttura ferroviaria stata smantellata negli anni successivi. Il fabbricato viaggiatori si trovava prendendo la deviazione verso destra dalla SS126 Sud Occidentale Sarda all’altezza del chilometro 16.9, ossia circa duecentocinquanta metri prima del raccordo con la strada statale Sirai, e la si trova sulla destra dopo una settantina di metri. Oggi questo fabbricato ancora esistente ed in uso come abitazione privata, sebbene alterato rispetto alla pianta originale.
Insediamento all’aperto di età prenuragica in località Campu Frassolis
 Dalla rotonda dove avevamo preso verso destra, seguendo le indicazioni per Carbonia, la via Dalmazia, dopo duecentoventi metri in direzione sud est, al bivio avevamo deviato a sinistra per rimanere sulla via Dalmazia, e, percorsi cinquecento metri, eravamo arrivati a una rotonda. Qui prendiamo questa volta la terza uscita che ci porta sulla via dell’Ospedale, che si dirige verso il Presidio Ospedaliero Sirai. Alla sinistra della via dell’Ospedale si sviluppa l’area di Campu Frassolis, un’area residenziale nella periferia settentrionale della città di Carbonia. Il sito risulta insistere alla base di un’ampia formazione collinare che si dispone a semicerchio intorno a Carbonia. La località è nota in letteratura soprattutto per ritrovamenti fortuiti, che fanno presumere una frequentazione abitativa in età storica. Le prime fasi dell’antropizzazione della zona si ascrivono, però, all’età prenuragica, senza che vi sia apparente continuità insediativa, ma solo una contiguità spaziale che si giustifica con la felice conformazione geografica, adatta allo stanziamento umano.
Dalla rotonda dove avevamo preso verso destra, seguendo le indicazioni per Carbonia, la via Dalmazia, dopo duecentoventi metri in direzione sud est, al bivio avevamo deviato a sinistra per rimanere sulla via Dalmazia, e, percorsi cinquecento metri, eravamo arrivati a una rotonda. Qui prendiamo questa volta la terza uscita che ci porta sulla via dell’Ospedale, che si dirige verso il Presidio Ospedaliero Sirai. Alla sinistra della via dell’Ospedale si sviluppa l’area di Campu Frassolis, un’area residenziale nella periferia settentrionale della città di Carbonia. Il sito risulta insistere alla base di un’ampia formazione collinare che si dispone a semicerchio intorno a Carbonia. La località è nota in letteratura soprattutto per ritrovamenti fortuiti, che fanno presumere una frequentazione abitativa in età storica. Le prime fasi dell’antropizzazione della zona si ascrivono, però, all’età prenuragica, senza che vi sia apparente continuità insediativa, ma solo una contiguità spaziale che si giustifica con la felice conformazione geografica, adatta allo stanziamento umano.
Il Presidio Ospedaliero Sirai
 Presa la via dell’Ospedale, la seguiamo per trecentocinquanta metri, e vediamo, alla sinistra della strada, l’ingresso del Presidio Ospedaliero Sirai. L’Ospedale Sirai, sito nell’omonima località di Carbonia, è il presidio principale dell’Azienda Sanitaria Locale di Carbonia. Eroga prestazioni di natura diagnostica e terapeutica nelle strutture semplici e complesse di Allergologia, Cardiologia, Chirurgia, Endocrinologia, Fisiatria, Gastroenterologia, Medicina, Nefrologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Radiodiagnostica, Urologia, Anatomia Patologica, Anestesia e Rianimazione, Cardiologia e UTIC, Chirurgia Generale, Diabetologia, Diagnostica per Immagini, Emodinamica, Laboratorio Analisi, Medicina interna, Medicina nucleare, Nefrologia e Dialisi, Oncologia, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e ginecologia, Pronto Soccorso, Psichiatria, Riabilitazione, Servizio prevenzione e trattamento delle talassemie, Medicina trasfusionale, Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Urologia.
Presa la via dell’Ospedale, la seguiamo per trecentocinquanta metri, e vediamo, alla sinistra della strada, l’ingresso del Presidio Ospedaliero Sirai. L’Ospedale Sirai, sito nell’omonima località di Carbonia, è il presidio principale dell’Azienda Sanitaria Locale di Carbonia. Eroga prestazioni di natura diagnostica e terapeutica nelle strutture semplici e complesse di Allergologia, Cardiologia, Chirurgia, Endocrinologia, Fisiatria, Gastroenterologia, Medicina, Nefrologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Radiodiagnostica, Urologia, Anatomia Patologica, Anestesia e Rianimazione, Cardiologia e UTIC, Chirurgia Generale, Diabetologia, Diagnostica per Immagini, Emodinamica, Laboratorio Analisi, Medicina interna, Medicina nucleare, Nefrologia e Dialisi, Oncologia, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e ginecologia, Pronto Soccorso, Psichiatria, Riabilitazione, Servizio prevenzione e trattamento delle talassemie, Medicina trasfusionale, Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Urologia.
Nel Presidio ospedaliero Sirai si trova la chiesa parrocchiale di San Camillo
All’interno del Presidio Ospedalieri Sirai si trova la Cappella di San Camillo. la quale è stata elevata al ruolo di parrocchia venendo a costituire una delle nuove chiese parrocchiali di Carbonia. Da un esame della tipologia edilizia e delle pietre utilizzate per la realizzazione della parte bassa dei muri esterni, si pu dedurre che la chiesa sia stata realizzata o contestualmente o immediatamente dopo la struttura ospedaliera, quindi tra gli anni 1946 e 1950. L’edificio originariamente risultava a livello superiore rispetto all’area antistante. A seguito di un recente ampliamento della struttura ospedaliera, ora risulta a quota inferiore rispetto al solaio di copertura della zona oggetto di ampliamento e si accede alla chiesa per mezzo di una gradinata. Nella facciata sono individuabili due livelli distinti. Il primo contiene al centro l’ingresso alla chiesa, affiancato da due pilastri sui quali posta una copertura aggettante.
La porzione superiore invece, conclusa dall’andamento a capanna degli spioventi della copertura, si contraddistingue per la presenza di una finestra circolare, inquadrata all’interno di un ampia campitura ricavata nella muratura, il cui profilo superiore a tutto sesto. Internamente l’edificio articolato in un unico vano illuminato da finestre laterali e con copertura lignea.
La frazione Campo Frassolis con la sua area residenziale
Arrivando con la via dell’Ospedale, alla sinistra della strada subito prima dell’ingresso del Presidio Ospedaliero, si trovano le abitazioni presenti nella piccola frazione Campo Frassolis (altezza metri 110, distanza in linea d’aria circa 5.8 chilometri, abitanti circa 88), che costituisce un’area residenziale posizionata nella periferia settentrionale della città di Carbonia. Vedreno, ora, che cosa si incontra muovendosi verso est, partendo dalla località Campo Frassolis.
Il Centro ippico San Michele
 Dall’interno della frazione Campo Fassonis, arriviamo alla rotonda davanti all’ingresso del Presidio Ospedaliero Sirai, dove prendiamo l’uscita che ci porta alla prosecuzione della via dell’Ospedale verso nord est. Percorsi altri duecentocinquanta metri lungo la prosecuzione della via dell’Ospedale, arriviamo a un’altra rotonda che si trova all’esterno dell’estremo orientale del Presidio Ospedaliero, ed a questa rotonda prendiamo la prima uscita che ci porta della via Don Luigi Orione, che si dirige verso sud est. Percorsi quattrocento metri, troviamo alla sinista della strada la deviazione in una strada bianca che, in poco più di un centinaio di metri, porta al Centro ippico San Michele di Carbonia, che mette a disposizione degli utenti il campo ospacoli con percorsi diversi ogni settimana.
Dall’interno della frazione Campo Fassonis, arriviamo alla rotonda davanti all’ingresso del Presidio Ospedaliero Sirai, dove prendiamo l’uscita che ci porta alla prosecuzione della via dell’Ospedale verso nord est. Percorsi altri duecentocinquanta metri lungo la prosecuzione della via dell’Ospedale, arriviamo a un’altra rotonda che si trova all’esterno dell’estremo orientale del Presidio Ospedaliero, ed a questa rotonda prendiamo la prima uscita che ci porta della via Don Luigi Orione, che si dirige verso sud est. Percorsi quattrocento metri, troviamo alla sinista della strada la deviazione in una strada bianca che, in poco più di un centinaio di metri, porta al Centro ippico San Michele di Carbonia, che mette a disposizione degli utenti il campo ospacoli con percorsi diversi ogni settimana.
Raggiungiamo il Monte Leone
 Molto più ad oriente rispetto all’insediamento di Campo Frassolis, si trova il Monte Leone, una ripida collina alta 280 metri e ricoperta da fitta pineta accessibile con facilità sino alla cima, al quale si arriva prendendo la via Don Luigi Orione, seguendola per novecento metri, poi prendendo a sinistra la via Costa Medau Becciu, dopo una quarantina di metri svoltando leggermente a destra nella via Santu Miai che dopo centocinquanta metri continua sulla via Lazio, la quale, percorsi quattrocentocinquanta metri, arriva alla base del Monte Leone. Partendo dalla base di Monte Leone, l’itinerario si inerpica lungo sentieri immersi in una vegetazione lussureggiante, dove la macchia mediterranea si alterna a tratti boschivi. Per raggiungere la sommità del Monte Leone, dalla via Lazio svoltiamo a sinistra in una strada bianca che seguiamo per centosettanta metri, poi svoltiamo a destra in un sentiero e proseguiamo per ottocentocinquanta metri per raggiungere in una cinquantina di metri la Croce bianca di Monte Leone, una croce di metallo alta alcuni metri ed installata di recente, a metà degli anni 2000. Più a sud, a trecento metri di distanza, passata la sommità del Monte Leone, è presente la Croce di ferro di Monte Leone, posizionata nel 1982, facilmente accessibile ed in posizione elevata, che è un frequentato punto panoramico per fotografie della città e di tutta la zona zona.
Molto più ad oriente rispetto all’insediamento di Campo Frassolis, si trova il Monte Leone, una ripida collina alta 280 metri e ricoperta da fitta pineta accessibile con facilità sino alla cima, al quale si arriva prendendo la via Don Luigi Orione, seguendola per novecento metri, poi prendendo a sinistra la via Costa Medau Becciu, dopo una quarantina di metri svoltando leggermente a destra nella via Santu Miai che dopo centocinquanta metri continua sulla via Lazio, la quale, percorsi quattrocentocinquanta metri, arriva alla base del Monte Leone. Partendo dalla base di Monte Leone, l’itinerario si inerpica lungo sentieri immersi in una vegetazione lussureggiante, dove la macchia mediterranea si alterna a tratti boschivi. Per raggiungere la sommità del Monte Leone, dalla via Lazio svoltiamo a sinistra in una strada bianca che seguiamo per centosettanta metri, poi svoltiamo a destra in un sentiero e proseguiamo per ottocentocinquanta metri per raggiungere in una cinquantina di metri la Croce bianca di Monte Leone, una croce di metallo alta alcuni metri ed installata di recente, a metà degli anni 2000. Più a sud, a trecento metri di distanza, passata la sommità del Monte Leone, è presente la Croce di ferro di Monte Leone, posizionata nel 1982, facilmente accessibile ed in posizione elevata, che è un frequentato punto panoramico per fotografie della città e di tutta la zona zona.
Dal Monte Leone lo sguardo abbraccia l’orizzonte per decine di chilometri, dal Pan di Zucchero di Masua al golfo di Palmas con le isole di Sant’Antioco e di San Pietro, ed offre una visuale molto dettagliata dell’abitato di Carbonia che offre una visuale molto dettagliata dell’abitato di Carbonia. È molto frequentato sia sportivi che vogliono allenarsi in corsa, mountain bike ed altro, sia da persone di tutte le età che vogliono fare una bella passeggiata godendo di un bel panorama.
I resti della miniera di Serra Lurdagu
A nord del Monte Leone si trovano i resti della miniera di Serra Lurdagu, chiamata anche miniera di Santa Barbara, nella quale l’attività mineraria estrattiva prevalente è stata la barite, ma altri minerali estratti sono stati argilla, blenda, calamine, calcite, cerussite, galena, limonite, marcasite e altro. La miniera di Serra Lurdagu posta a nord rispetto a Carbonia, e a sud rispetto alla pi nota miniera di barite di Barbusi. Nella localitàdi Serra Lurdagu si sono alternati dai primi del Novecento diversi permessi di ricerca, prima per minerali di piombo e zinco e poi per bario.
Nell’area in esame nel 1925 viene rilasciato al signor Virgilio Nurchis di Iglesias un permesso di ricerca per minerali di piombo, argento, zinco, rame, ferro e arsenico, permesso che scade nel 1928. Viene, quindi, rilasciato nel 1941 alla Socità Italiana del Litopone un permesso per minerali di bario. In seguito, tra il 1965 e il 1971, nell’area opera la società miniera di Barega, la quale ricerca barite, e dal 1975 al 1979 viene rilasciato alla Bariosarda un permesso di ricerca per minerali di bario e fluoro. Ora nell’area restano a testimonianza dell’attivit mineraria solo poche gallerie e qualche scavo all’aperto.
A nord ovest di Carbonia raggiungiamo la frazione Flumentepido
Passata sulla SS126 Sud Occidentale Sarda l’uscita per la frazione Sirai, proseguiamo lungo questa strada, che da nord si porta a nord ovest. Percorso circa un chilometro dalla deviazione a destra sulla Strada Statale Sirai, passato ilcartello indicatore del chilometro 18 arriviamo a una rotonda, alla quale, seguendo le indicazioni, prendiamo la seconda uscita, in direzione di Flumentepido. Questa uscita ci fa imboccare la via delle Querce, la quale in cinquecento metri ci porta all’interno della frazione Flumentepido (altezza metri 66, distanza in linea d’aria circa 5.8 chilometri, abitanti circa 192). Si tratta di un’antica borgata agro pastorale, divenuta oggi una zona residenziale, situata ai piedi del colle di Monte Sirai, verso nord. In passato la SS126 Sud Occidentale Sarda passava all’interno della frazione, successivamente il tracciato è stato spostato all’esterno.
In un colle vicino all’abitato si trova la restaurata chiesetta di Santa Maria di Flumentepido, di origine medievale, con i resti dell’antico monastero benedettino.
La chiesa di Sant’Antonio da Padova
 Il nome della frazione, Flumentepido, conservato sino ad oggi, testimonia la presenza di un antico villaggio giudicale, ben documentato nel Trecento, periodo in cui, verso la fine del secolo o agli inizi di quello successivo, il villaggio è costretto a spopolarsi a causa delle interminabili lotte per il possesso della Sardegna, che sono anche la causa di carestie e pestilenze. Prima di uscire dall’abitato, prendiamo a sinistra la via degli Abeti, che porta sulla SP2 in direzione di Portoscuso. Ad angolo tra la prosecuzione della via delle Querce e la via degli Abeti, si trova la piccola Chiesa di Sant’Antonio da Padova, la piccola chiesa moderna di Flumentepido, la quale custodisce al suo interno un’antica statua della Madonna ed un’acquasantiera, che originariamente erano conservate nella chiesa di Santa Maria di Flumentepido, situata sulla vicina collina.
Il nome della frazione, Flumentepido, conservato sino ad oggi, testimonia la presenza di un antico villaggio giudicale, ben documentato nel Trecento, periodo in cui, verso la fine del secolo o agli inizi di quello successivo, il villaggio è costretto a spopolarsi a causa delle interminabili lotte per il possesso della Sardegna, che sono anche la causa di carestie e pestilenze. Prima di uscire dall’abitato, prendiamo a sinistra la via degli Abeti, che porta sulla SP2 in direzione di Portoscuso. Ad angolo tra la prosecuzione della via delle Querce e la via degli Abeti, si trova la piccola Chiesa di Sant’Antonio da Padova, la piccola chiesa moderna di Flumentepido, la quale custodisce al suo interno un’antica statua della Madonna ed un’acquasantiera, che originariamente erano conservate nella chiesa di Santa Maria di Flumentepido, situata sulla vicina collina.
La chiesa romanica di Santa Maria di Flumentepido
 Dalla frazione Flumentepido, procediamo sulla via degli Abeti in direzione Portoscuso, percorsi poco più di trecento metri, imbocchiamo una stradina sterrata sulla destra, proseguiamo parallelamente alla strada asfaltata per circa cento metri, poi svoltamo a destra all’interno di un boschetto di eucalipti, e da qui, per ulteriori cinquecento metri, sino alla cima della collinetta, dove raggiungiamo la restaurata piccola Chiesa romanica di Santa Maria di Flumentepido. Situata sopra una piccola altura, è stata edificata nell’undicesimo secolo in stile romanico, ed ha una unica navata senza abside. La chiesa di S. Marie de flumine Tepidus viene menzionata fino dal 1066, in quanto oggetto di una donazione da parte di Torchitorio, giudice di Cagliari, in favore dell’Ordine monastico Cassinese, che avrebbe dovuto impiantarvi un proprio centro spirituale, mai portato a compimento, perché ostacolato da più parti. Ancora documentata nel 1159, come appartenente al medesimo Ordine, risulta nel 1218, inclusa tra i beni donati da papa Onorio III alla diocesi sulcitana, mentre nel 1236 viene citata come di pertinenza dei Cistercensi, che vi costruiscono un monastero, i cui resti rimangono visibili almeno sino all’Ottocento, dato che sono stati segnalati anche da Vittorio Angius, e del quale restano oggi solo poche tracce ricoperte dalla vegetazione.
Dalla frazione Flumentepido, procediamo sulla via degli Abeti in direzione Portoscuso, percorsi poco più di trecento metri, imbocchiamo una stradina sterrata sulla destra, proseguiamo parallelamente alla strada asfaltata per circa cento metri, poi svoltamo a destra all’interno di un boschetto di eucalipti, e da qui, per ulteriori cinquecento metri, sino alla cima della collinetta, dove raggiungiamo la restaurata piccola Chiesa romanica di Santa Maria di Flumentepido. Situata sopra una piccola altura, è stata edificata nell’undicesimo secolo in stile romanico, ed ha una unica navata senza abside. La chiesa di S. Marie de flumine Tepidus viene menzionata fino dal 1066, in quanto oggetto di una donazione da parte di Torchitorio, giudice di Cagliari, in favore dell’Ordine monastico Cassinese, che avrebbe dovuto impiantarvi un proprio centro spirituale, mai portato a compimento, perché ostacolato da più parti. Ancora documentata nel 1159, come appartenente al medesimo Ordine, risulta nel 1218, inclusa tra i beni donati da papa Onorio III alla diocesi sulcitana, mentre nel 1236 viene citata come di pertinenza dei Cistercensi, che vi costruiscono un monastero, i cui resti rimangono visibili almeno sino all’Ottocento, dato che sono stati segnalati anche da Vittorio Angius, e del quale restano oggi solo poche tracce ricoperte dalla vegetazione.
La piccola chiesa, composta da blocchi di pietra locale, provenienti almeno in parte da strutture preesistenti, dopo l’ultimo recente restauro, nel 2014 è stata dichiarata bene di interesse culturale, considerata la sua lunga storia. Si tratta di un piccolo edificio privo di decorazioni, con copertura a capanna, e con soffitto ligneo sostenuto da capriate. Sul frontale si ergeva un campaniletto a vela, ed un tempo intorno alla chiesa era presente un loggiato, le cui possenti colonne si trovano ancora sul posto. L’interno è illuminato solamente da due strette monofore speculari, e nella parete di fondo rispetto all’ingresso si apre la nicchia che ospitava il simulacro, ora custodito nella vicina chiesa di Sant’Antonio, insieme all’acquasantiera.
 Nell’area esterna adiacente alla chiesa sono presenti tre cippi miliari romani fuori contesto, provenienti dalla vicina strada romana, riutilizzati come colonne del portale della chiesa di Santa Maria di Flumentepido. Tra questi il più significativo è un cippo miliario del primo secolo dopo Cristo indicato come CIL X, con sopra una iscrizione che è stata però molto danneggiata dagli agenti atmosferici. Benché la collocazione attuale non rispecchi esattamente l’originaria località d’uso del cippo, è possibile riferire il manufatto al territorio circostante, attraversato dalla via a Karalibus Sulcos. Il tracciato della strada è infatti ricostruibile attraverso la valle del rio Flumentepido, dove dovette attraversare la stazione termale oggi nota col toponimo di Aquas Callentis, località che ha restituito un miliario anepigrafe, oggi conservato nella collezione privata del Ristorante Tanit in località Sirai, insieme ad un secondo cippo, sempre anepigrafe, reimpiegato nella chiesa di Santa Maria di Flumentepido. L’intera area, da Flumentepido, sino alla frazione del comune di Carbonia, Barbusi, ha restituito diversi blocchi riferibili a manufatti itinerari e stradali. Il testo epigrafico presenta la commemorazione per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione o di rifacimento della via durante il principato di Vespasiano. Gli elementi della titolatura imperiale consentono la datazione puntuale dell’iscrizione. L’indicazione del governatore curatore dell’opera, il proconsole Secundus, il cui consolato va dal 1 luglio del 69 d.C. al 30 giugno del 70, è coerente con la cronologia suggerita dalla titolatura imperiale.
Nell’area esterna adiacente alla chiesa sono presenti tre cippi miliari romani fuori contesto, provenienti dalla vicina strada romana, riutilizzati come colonne del portale della chiesa di Santa Maria di Flumentepido. Tra questi il più significativo è un cippo miliario del primo secolo dopo Cristo indicato come CIL X, con sopra una iscrizione che è stata però molto danneggiata dagli agenti atmosferici. Benché la collocazione attuale non rispecchi esattamente l’originaria località d’uso del cippo, è possibile riferire il manufatto al territorio circostante, attraversato dalla via a Karalibus Sulcos. Il tracciato della strada è infatti ricostruibile attraverso la valle del rio Flumentepido, dove dovette attraversare la stazione termale oggi nota col toponimo di Aquas Callentis, località che ha restituito un miliario anepigrafe, oggi conservato nella collezione privata del Ristorante Tanit in località Sirai, insieme ad un secondo cippo, sempre anepigrafe, reimpiegato nella chiesa di Santa Maria di Flumentepido. L’intera area, da Flumentepido, sino alla frazione del comune di Carbonia, Barbusi, ha restituito diversi blocchi riferibili a manufatti itinerari e stradali. Il testo epigrafico presenta la commemorazione per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione o di rifacimento della via durante il principato di Vespasiano. Gli elementi della titolatura imperiale consentono la datazione puntuale dell’iscrizione. L’indicazione del governatore curatore dell’opera, il proconsole Secundus, il cui consolato va dal 1 luglio del 69 d.C. al 30 giugno del 70, è coerente con la cronologia suggerita dalla titolatura imperiale.
Le frazioni più a nord rispetto alla frazione Flumentepido
Più a nord rispetto alla frazione Flumentepido si trovano le frazioni Medau Is Fenus e Medau Is Serafinis.
Vicino a Flumentepido si trova la frazione Medau Is Fenus
Dall’interno della frazione Flumentepido, evitiamo la deviazione su via degli Abeti, e proseguiamo, invece, lungo la via delle Querce che esce dall’abitato in direzione nord ovest. A circa un chilometro da dove, dalla rotonda sulla SS126 Sud Occidentale Sarda, avevamo imboccato la via delle Querce, troviamo alla destra una deviazione che, in poche decine di metri, ci porta all’interno della piccola frazione in località Medau Is Fenus (altezza metri 88, distanza in linea d’aria circa 6.4 chilometri, abitanti circa 10), ossia il Casale della famiglia Fenus, che era un casale agropastorale ed è situato a brevissima distanza da Flumentepido. A nord ovest rispetto all’abitato si trovano i resti di una cava che veniva utilizzata per la produzione di argilla, e che attualmente risulta abbandonata, con progetti di riqualificazione in corso. E vicino, poco più a nord, si trovano anche i resti di quelle che erano le Fornaci Fodde, che erano fornaci per la produzione di laterizi grazie alla vicina cava di argilla, che ora ospitano la Acentro, un concessionario ed una officina di automobili.
La frazione Medau Is Serafinis
Dalla rotonda dove avevamo preso la deviazione per Flumentepido, proseguiamo per un chilometro e mezzo sulla SS126 Sud Occidentale Sarda e, seguendo le indicazioni, prendiamo la deviazione a sinistra che, in duecentocinquanta metri, ci porta all’interno della frazione Medau Is Serafinis (altezza metri 61, distanza in linea d’aria circa 6.8 chilometri, abitanti circa 18), ossia il Casale della famiglia Serafinis, già antico casale agropastorale situato vicino alla SS126 Sud Occidentale Sarda. Ad ovest della frazione, si sviluppa la zona del Rimboschimento di Is Serafinis, un’ampia zona di rimboschimento effettuato tramite alberi di pino.
La frazione Medau Desogus
Proseguiamo lungo la SS126 Sud Occidentale Sarda, e, passata la deviazione per la frazione Medau Is Serafinis, percorriamo appena centocinquanta metri, dopo di che raggiungiamo la rotatoria di Medau Desogus, dove prendiamo la deviazione a destra che, in quattrocento metri, ci porta all’ingresso della frazione Medau Desogus (altezza metri 72, distanza in linea d’aria circa 7.2 chilometri, abitanti circa 136), ossia il Casale della famiglia Desogus, in passato casale agro pastorale ed oggi una borgata, che si posiziona al lato destro della strada provinciale, quasi di fronte alla frazione Medau Is Serafinis.
La piccola chiesa di San Pio da Pietrelcina
Entreati all’ingresso della frazione, proseguiamo dritti nella strada che, percorsi centoventi metri, arriva a un bivio. Presa a destra, dopo una cinquantina di metri si apre alla sinistra uno spazio pedonale con panchine nel quale si affaccia il retro della moderna piccola Chiesa di San Pio da Pietrelcina. Sul retro sono presenti due bei murales, a sinistra quello che rappresenta San Pio, ed a destra uno che rappresenta la madonna con il Bambino. Costeggiato il fianco della chiesa, si arriva alla piazza antistante, sulla quale si affaccia il suo frontale sopraelevato rispetto alla quota del terreno, con al centro il portale di ingresso preceduta da una scalinata di sei gradini.
All’interno della frazione di Medau Desogus, ogni anno dal 20 al 23 settembre si svolgono i festeggiamenti per celebrare San Pio da Pietrelcina. Si tratta di una ricorrenza da sempre molto sentita e partecipata dagli abitanti del luogo, una piccola comunità che si unisce per celebrare le sue tradizioni religiose e rinnovare annualmente la sua devozione al Santo. L’evento è organizzato dalla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Cortoghiana.
La importante frazione Cortoghiana e le altre frazioni minori nei dintroni
 Dalla rotatoria di Medau Desogus, percorriamo lungo la SS126 Sud Occidentale Sarda ancora un chilometro e seicento metri, e raggiungiamo un semaforo dove, seguendo le indicazioni per Cortoghiana, prendiamo la deviazione a sinistra in viale Amedeo di Savoia, che ci porta in quattrocentocinquanta metri a una rotonda all’interno della importante frazione Cortoghiana (altezza metri 93, distanza in linea d’aria circa 9.1 chilometri, abitanti circa 2.468), la più popolosa frazione del comune di Carbonia, realizzata nelle vicinanze dell’omonima miniera, nella zona nota come Corti Ogianu, italianizzato in Corti Ogiana o Corti Oghiana, alla quale si fa risalire il suo nome. Cortoghiana, insieme alla precedente nascita di Carbonia, da cui dipende come sua frazione, e a quella contemporanea della frazione di Bacu Abis, furono finanziate per incrementare e ottimizzare lo sfruttamento minerario del Sulcis in epoca fascista.
Dalla rotatoria di Medau Desogus, percorriamo lungo la SS126 Sud Occidentale Sarda ancora un chilometro e seicento metri, e raggiungiamo un semaforo dove, seguendo le indicazioni per Cortoghiana, prendiamo la deviazione a sinistra in viale Amedeo di Savoia, che ci porta in quattrocentocinquanta metri a una rotonda all’interno della importante frazione Cortoghiana (altezza metri 93, distanza in linea d’aria circa 9.1 chilometri, abitanti circa 2.468), la più popolosa frazione del comune di Carbonia, realizzata nelle vicinanze dell’omonima miniera, nella zona nota come Corti Ogianu, italianizzato in Corti Ogiana o Corti Oghiana, alla quale si fa risalire il suo nome. Cortoghiana, insieme alla precedente nascita di Carbonia, da cui dipende come sua frazione, e a quella contemporanea della frazione di Bacu Abis, furono finanziate per incrementare e ottimizzare lo sfruttamento minerario del Sulcis in epoca fascista.
Il progetto dell’abitato e della grande piazza Venezia
 Dalla rotonda, proseguendo dritti in altri quattrocento metri si raggiunge la grande piazza Venezia, che è la piazza principale di Cortoghiana. Il progetto urbanistico complessivo dell’abitato di Cortoghiana, e l’architettura della piazza Venezia, sono opera dell’architetto Saverio Muratori, cui era stata affidato nel 1939, e che aveva curato anche la progettazione del vicino villaggio minerario. L’inaugurazione della frazione avviene il 15 maggio 1942, alla presenza del capo del regime fascista Benito Mussolini, che visita il nuovo centro abitato e la locale miniera. È di particolare rilevanza l’organizzazione urbanistica dell’abitato, di stampo razionalista, e la vasta piazza Venezia, tipico esempio di architettura del Ventennio. Anche questa frazione è legata storicamente, infatti, all’attività mineraria dei vicini pozzi carboniferi. Il nome Cortoghiana gli è stato dato, però, dopo la guerra, in quanto durante il Ventennio l’abitato era detto Villaggio Umberto, in onore del figlio del Re d’Italia.
Dalla rotonda, proseguendo dritti in altri quattrocento metri si raggiunge la grande piazza Venezia, che è la piazza principale di Cortoghiana. Il progetto urbanistico complessivo dell’abitato di Cortoghiana, e l’architettura della piazza Venezia, sono opera dell’architetto Saverio Muratori, cui era stata affidato nel 1939, e che aveva curato anche la progettazione del vicino villaggio minerario. L’inaugurazione della frazione avviene il 15 maggio 1942, alla presenza del capo del regime fascista Benito Mussolini, che visita il nuovo centro abitato e la locale miniera. È di particolare rilevanza l’organizzazione urbanistica dell’abitato, di stampo razionalista, e la vasta piazza Venezia, tipico esempio di architettura del Ventennio. Anche questa frazione è legata storicamente, infatti, all’attività mineraria dei vicini pozzi carboniferi. Il nome Cortoghiana gli è stato dato, però, dopo la guerra, in quanto durante il Ventennio l’abitato era detto Villaggio Umberto, in onore del figlio del Re d’Italia.
La chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù
E proprio in piazza Venezia, fulcro dell insediamento, si trova la chiesa del Sacro Cuore di Gesù che è la parrocchiale della frazione Cortoghiana. Nonostante la sua realizzazione fosse gi stata prevista nel piano di fondazione di Cortoghiana messo a punto dall architetto Saverio Muratori nel 1940, la chiesa stata realizzata solo nel dopoguerra, e però nella sua struttura non risponde affatto a quella, con torre campanaria, che era stata prevista nei progetti originari dell’architetto Saverio Muratori.
 L’edificio sorse a partire dal 1957, su progetto dell architetto don Angelo Verri. Impostato sulla base di una pianta esagonale, è suddiviso, dal punto di vista planivolumetrico, in due blocchi, di cui il secondo, corrispondente al nucleo centrale della chiesa, sviluppato in altezza, si inserisce al centro del primo, che si sviluppa invece in larghezza ospitando ampie cappelle laterali che fanno da corollario alla navata principale. Quest'ultima si contraddistingue in primo luogo per la presenza di elementi in cemento armato che, innestati a partire dalla metà delle pareti laterali, seguono l’andamento delle falde di copertura enfatizzando la spinta verticale dello spazio. La facciata principale, impostata secondo la medesima logica, è suddivisa in due livelli, dei quali il primo, ribassato, è articolato in un portico retto da pilastri, mentre il secondo con copertura a capanna, è caratterizzato dalla presenza di un’ampia apertura nella porzione più alta. Quale raccordo visivo fra le due parti è inserito un campanile a vela dall’andamento mistilineo, che poggia sulla copertura del portico di facciata.
L’edificio sorse a partire dal 1957, su progetto dell architetto don Angelo Verri. Impostato sulla base di una pianta esagonale, è suddiviso, dal punto di vista planivolumetrico, in due blocchi, di cui il secondo, corrispondente al nucleo centrale della chiesa, sviluppato in altezza, si inserisce al centro del primo, che si sviluppa invece in larghezza ospitando ampie cappelle laterali che fanno da corollario alla navata principale. Quest'ultima si contraddistingue in primo luogo per la presenza di elementi in cemento armato che, innestati a partire dalla metà delle pareti laterali, seguono l’andamento delle falde di copertura enfatizzando la spinta verticale dello spazio. La facciata principale, impostata secondo la medesima logica, è suddivisa in due livelli, dei quali il primo, ribassato, è articolato in un portico retto da pilastri, mentre il secondo con copertura a capanna, è caratterizzato dalla presenza di un’ampia apertura nella porzione più alta. Quale raccordo visivo fra le due parti è inserito un campanile a vela dall’andamento mistilineo, che poggia sulla copertura del portico di facciata.
Il campo sportivo di Cortoghiana
Dalla SS126 Sud Occidentale Sarda, al semaforo, avevamo svoltato a sinistra e preso il viale Amedeo di Savoia, poi dopo quattrocentocinquanta metri alla rotonda prendiamo questa volta la terza uscita che ci porta sulla via Enzo Ferrari, dopo una sessantina di metri svoltiamo a sinistra sulla via Torricelli. Dopo trecento metri, a un bivio, svoltamo leggermente a sinistra e in quattrocento metri, in localtà Masongiu Pintus, vediamo alla sinistra della strada l’ingresso del Campo sportivo di Cortoghiana. Si tratta di un Campo da calcio a 11, con fondo in terra battuta, di tribune in grado di ospitare 500 spettatori.
La frazione miniera Cortoghiana con la miniera carbonifera dismessa
 Al semaforo dove avevamo preso a sinistra la deviazione per Cortoghiana, prendiamo, invece, la deviazione a destra. Appena imboccata, deviamo subito a sinistra nella strada che seguiamo per circa ottocento metri, poi prendiamo a destra la strada verso Cuccuru Suergiu, e vediamo, alla destra della strada, gli edifici della frazione miniera Cortoghiana (altezza metri 127, distanza in linea d’aria circa 9.0 chilometri, abitanti circa 23). Nel lontano 1861 la zona di Corti Ogianu era interessata da permessi di ricerca per combustibili fossili, ed in essa vengono realizzate trincee e gallerie. La prima concessione viene rilasciata nel 1892 alla Ditta Birocchi Filippo, nel 1896 la miniera viene ceduta ad Anselmo Roux, un famoso tecnico che rende grande la miniera di Bacu Abis. Nella prima decade del Novecento la miniera risulta quasi inattiva, ma nel 1914 vengono realizzate nuove gallerie. Nel 1919 viene scavato un nuovo pozzo profondo venti metri ad est di Pozzo Roth. Nel 1923 viene realizzato un nuovo castello e una sala compressori e viene approfondito il pozzo principale fino ai cinquantadue metri. La miniera di Cortoghiana passa nel 1929 alla Società Anonima Bacu Abis, che si dedica ad approfondire ulteriormente il pozzo ed a rivestirlo in muratura, e vengono effettuati lavori anche nel Pozzo Castoldi. Dal 1930 al 1933 la miniera risulta di nuovo inattiva. Nel 1934 la concessione passa alla Carbonifera Sarda, che si dedica a lavori di preparazione e di ricerca mediante sondaggi, mentre i lavori di coltivazione si concentrano a monte del pozzo di estrazione. Nel 1940 è già in esaurimento la parte di giacimento presso la vecchia discenderia, poi nel 1945 i lavori di coltivazione si estendono anche ai livelli 2, 3 e 4. Nel 1951 vengono realizzati grandi lavori per collegare la miniera di Cortoghiana con quella di Bacu Abis, e successivamente le miniere di Cortoghiana Nuova, di Bacu Abis e di Cortoghiana Vecchia vengono messe in comunicazione tra di loro. Nel 1954 la miniera risulta inattiva a causa dell’esaurimento del giacimento e i pozzi vengono riempiti con materiale sterile fino all’imbocco. Nel 1958 la produzione viene fermata nonostante l’esito favorevole dei sondaggi, vengono smantellate le infrastrutture minerarie comprese le pompe, che causano l’allagamento delle gallerie. La Carbonifera Sarda che ne rimane proprietaria fino all’atto di rinuncia alla concessione del 1969 e alla vendita a privati nel 1973.
Al semaforo dove avevamo preso a sinistra la deviazione per Cortoghiana, prendiamo, invece, la deviazione a destra. Appena imboccata, deviamo subito a sinistra nella strada che seguiamo per circa ottocento metri, poi prendiamo a destra la strada verso Cuccuru Suergiu, e vediamo, alla destra della strada, gli edifici della frazione miniera Cortoghiana (altezza metri 127, distanza in linea d’aria circa 9.0 chilometri, abitanti circa 23). Nel lontano 1861 la zona di Corti Ogianu era interessata da permessi di ricerca per combustibili fossili, ed in essa vengono realizzate trincee e gallerie. La prima concessione viene rilasciata nel 1892 alla Ditta Birocchi Filippo, nel 1896 la miniera viene ceduta ad Anselmo Roux, un famoso tecnico che rende grande la miniera di Bacu Abis. Nella prima decade del Novecento la miniera risulta quasi inattiva, ma nel 1914 vengono realizzate nuove gallerie. Nel 1919 viene scavato un nuovo pozzo profondo venti metri ad est di Pozzo Roth. Nel 1923 viene realizzato un nuovo castello e una sala compressori e viene approfondito il pozzo principale fino ai cinquantadue metri. La miniera di Cortoghiana passa nel 1929 alla Società Anonima Bacu Abis, che si dedica ad approfondire ulteriormente il pozzo ed a rivestirlo in muratura, e vengono effettuati lavori anche nel Pozzo Castoldi. Dal 1930 al 1933 la miniera risulta di nuovo inattiva. Nel 1934 la concessione passa alla Carbonifera Sarda, che si dedica a lavori di preparazione e di ricerca mediante sondaggi, mentre i lavori di coltivazione si concentrano a monte del pozzo di estrazione. Nel 1940 è già in esaurimento la parte di giacimento presso la vecchia discenderia, poi nel 1945 i lavori di coltivazione si estendono anche ai livelli 2, 3 e 4. Nel 1951 vengono realizzati grandi lavori per collegare la miniera di Cortoghiana con quella di Bacu Abis, e successivamente le miniere di Cortoghiana Nuova, di Bacu Abis e di Cortoghiana Vecchia vengono messe in comunicazione tra di loro. Nel 1954 la miniera risulta inattiva a causa dell’esaurimento del giacimento e i pozzi vengono riempiti con materiale sterile fino all’imbocco. Nel 1958 la produzione viene fermata nonostante l’esito favorevole dei sondaggi, vengono smantellate le infrastrutture minerarie comprese le pompe, che causano l’allagamento delle gallerie. La Carbonifera Sarda che ne rimane proprietaria fino all’atto di rinuncia alla concessione del 1969 e alla vendita a privati nel 1973.
Il complesso della miniera di Cortoghiana che operava nel giacimento carbonifero di Cortoghiana Nuova, perché espansione della precedente miniera di Cortoghiana Vecchia, comprende diversi edifici ed impianti estrattivi vicino all’omonima frazione. A Cortoghiana Vecchia si trova il pozzo est, mentre a Cortoghiana Nuova si trovano il pozzo 1, il pozzo 2. All’interno si possono vedere un cippo commemorativo in pietra, la vecchia direzione mineraria, uffici amministrativi, depositi ed officine meccaniche, magazzini, centrale elettrica e laveria della vicina miniera carbonifera dismessa, che era stata attiva fino agli anni cinquanta del secolo scorso, ed è ormai abbandonata. Alcuni degli edifici presenti nella frazione vengono ora utilizzati per attività artigianali e commerciali. Attualmente è in programma un progetto di recupero degli edifici storici.
I ruderi dell’antica stazione ferroviaria di Cortoghiana delle Ferrovie Meridionali Sarde
 Nell’estremità sud occidentale dell’area della miniera dismessa si trovano i ruderi dell’antica Stazione ferroviaria di Cortoghiana. Per servire la frazione, ma soprattutto le miniere poste a oriente rispetto ad essa, le Ferrovie Meridionali Sarde edificano un nuovo impianto lungo la propria linea a scartamento ridotto che collegava Palmas Suergiu ad Iglesias. La stazione ferroviaria di Cortoghiana inizia cos nel 1941 l’attività incentrata prevalentemente sul trasporto del carbone estratto nella zona verso gli impianti di destinazione e verso lo scalo di Sant’Antioco Ponti, dal quale proseguiva poi oltre mare. Per il servizio viaggiatori la stazione viene dotata di un fabbricato che dovrebbe essere provvisorio in attesa della costruzione di un edificio atto allo scopo, il quale tuttavia non viene mai realizzato. All’inizio dell’attività l’impianto è quindi interessato ad un rilevante traffico ferroviario, tuttavia la crisi del settore estrattivo sulcitano che nel secondo dopoguerra ha portato alla chiusura di quasi tutte le miniere carbonifere del sud ovest della Sardegna significa anche la fine dell’attività estrattiva a Cortoghiana, per cui la stazione vede il crollo del traffico merci restando comunque operativa fino al 1974, data della cessazione del servizio ferroviario sulla linea tra San Giovanni Suergiu ed Iglesias, le cui relazioni vengono sostituite da autocorse. Successivamente la stazione viene disarmata, e della stessa rimase solo il fabbricato viaggiatori, ormai un ridotto allo stato di rudere.
Nell’estremità sud occidentale dell’area della miniera dismessa si trovano i ruderi dell’antica Stazione ferroviaria di Cortoghiana. Per servire la frazione, ma soprattutto le miniere poste a oriente rispetto ad essa, le Ferrovie Meridionali Sarde edificano un nuovo impianto lungo la propria linea a scartamento ridotto che collegava Palmas Suergiu ad Iglesias. La stazione ferroviaria di Cortoghiana inizia cos nel 1941 l’attività incentrata prevalentemente sul trasporto del carbone estratto nella zona verso gli impianti di destinazione e verso lo scalo di Sant’Antioco Ponti, dal quale proseguiva poi oltre mare. Per il servizio viaggiatori la stazione viene dotata di un fabbricato che dovrebbe essere provvisorio in attesa della costruzione di un edificio atto allo scopo, il quale tuttavia non viene mai realizzato. All’inizio dell’attività l’impianto è quindi interessato ad un rilevante traffico ferroviario, tuttavia la crisi del settore estrattivo sulcitano che nel secondo dopoguerra ha portato alla chiusura di quasi tutte le miniere carbonifere del sud ovest della Sardegna significa anche la fine dell’attività estrattiva a Cortoghiana, per cui la stazione vede il crollo del traffico merci restando comunque operativa fino al 1974, data della cessazione del servizio ferroviario sulla linea tra San Giovanni Suergiu ed Iglesias, le cui relazioni vengono sostituite da autocorse. Successivamente la stazione viene disarmata, e della stessa rimase solo il fabbricato viaggiatori, ormai un ridotto allo stato di rudere.
La piccola frazione Cuccurru Suergiu
Passata la frazione miniera Cortoghiana, proseguiamo lungo la strada e, seguendo le indicazioni, dopo settecento metri arriviamo alla frazione Cuccurru Suergiu (altezza metri 150, distanza in linea d’aria circa 9.8 chilometri, abitanti circa 15), il cui nome significa Cima della Sughereta per la presenza di alcune querce da sughero, delle quali in antichità vi era proprio un vasto bosco, sulla sommità della vicina collina.
La piccola frazione Genna Gonnesa
Dal semaforo dove avevamo preso le deviazioni per Cortoghiana e per Cuccurru Suergiu, proseguiamo lungo la SS126 Sud Occidentale Sarda ancora per un chilometro, e, seguendo le indicazioni, prendiamo a destra la deviazione che, in circa trecentocinquanta metri, ci porta all’interno della frazione Genna Gonnesa (altezza metri 123, distanza in linea d’aria circa 9.7 chilometri, abitanti circa 25), ossia la Porta di Gonnesa, che è un antico casale agropastorale.
A nord dell’abitato, si sviluppa l’ampia pineta di Cortoghiana. Proseguendo, la strada che ci ha portati alla frazione Cortoghiana ci conduce, in altri tre chilometri e mezzo, a Nuraxi Figus, che è la frazione più meridionale del comune di Gonnesa.
Il Cimitero di Cortoghiana
 Appena duecentocinquanta metri più avanti lungo la SS126 Sud Occidentale Sarda, prendiamo la deviazione sulla sinistra, che, in altri duecentocinquanta metri, ci porta di fronte all’ingresso del Cimitero di Cortoghiana che pur appartenendo a questa frazione Carbonia dalla quale dista oltre due chilometri, si trova però all’interno del territorio comunale di Gonnesa. Il cimitero di Cortoghiana, di pianta quadrata, occupa un lotto di diecimila mqtri quadratu e presenta un unico ingresso sulla strada. Il recinto è costituito da una muratura continua. L’ingresso è caratterizzato da due pilastri tra i quali è posto un cancello in ferro lavorato, in mezzeria del muro di cinta è posizionata la cappella e simmetricamente sono presenti due corpi di fabbrica di minore altezza e copertura a padiglione a quattro falde.
Appena duecentocinquanta metri più avanti lungo la SS126 Sud Occidentale Sarda, prendiamo la deviazione sulla sinistra, che, in altri duecentocinquanta metri, ci porta di fronte all’ingresso del Cimitero di Cortoghiana che pur appartenendo a questa frazione Carbonia dalla quale dista oltre due chilometri, si trova però all’interno del territorio comunale di Gonnesa. Il cimitero di Cortoghiana, di pianta quadrata, occupa un lotto di diecimila mqtri quadratu e presenta un unico ingresso sulla strada. Il recinto è costituito da una muratura continua. L’ingresso è caratterizzato da due pilastri tra i quali è posto un cancello in ferro lavorato, in mezzeria del muro di cinta è posizionata la cappella e simmetricamente sono presenti due corpi di fabbrica di minore altezza e copertura a padiglione a quattro falde.
 La Cappella sorge in mezzeria del muro di cinta del cimitero ed insieme ai due ingressi disposti simmetricamente a questi ed ai due corpi di fabbrica di minore altezza. Caratterizzata da una modesta dimensione e da un impianto di grande semplicità, la cappella si compone di un vano unico a pianta rettangolare, ed assume un carattere architettonico piacevole, ricorrendo ad un garbato timpano e a una copertura a doppia falda, la cui proporzione rimanda a più noti esempi di celle di matrice ellenica, al pari del basamento sopraelevato rispetto alla quota del terreno, sorta di aulico piedistallo per la cella. Il portale presente sul fronte principale, insieme all’oculo circolare sovrastante, costituisce l’apparato architettonico della cappella.
La Cappella sorge in mezzeria del muro di cinta del cimitero ed insieme ai due ingressi disposti simmetricamente a questi ed ai due corpi di fabbrica di minore altezza. Caratterizzata da una modesta dimensione e da un impianto di grande semplicità, la cappella si compone di un vano unico a pianta rettangolare, ed assume un carattere architettonico piacevole, ricorrendo ad un garbato timpano e a una copertura a doppia falda, la cui proporzione rimanda a più noti esempi di celle di matrice ellenica, al pari del basamento sopraelevato rispetto alla quota del terreno, sorta di aulico piedistallo per la cella. Il portale presente sul fronte principale, insieme all’oculo circolare sovrastante, costituisce l’apparato architettonico della cappella.
Le frazioni ad est tra Cortoghiana e Bacu Abis
Da dove avevamo preso la deviazione per Cortoghana, proseguiamo lungo la SS126 Sud Occidentale Sarda evitando le deviazioni per Genna Gonnesa e per il Cimitero di Cortoghiana.
La frazione Domu Beccia
Dopo un chilometro e mezzo, poco dopo il cartello che indica il chilometro 23, prendiamo la deviazione sulla destra seguendo le indicazioni, e, in poco più di un altro chilometro e mezzo, raggiungiamo la frazione Domu Beccia (altezza metri 129, distanza in linea d’aria circa 11.4 chilometri, abitanti circa 44), ossia la Casa Vecchia, costruita intorno ad un casale agropastorale di antiche origini medievali, che si trova a circa un chilometro e mezzo dalla SS126 Sud Occidentale Sarda, tra gli abitati di Bacu Abis e Cortoghiana, a circa una decina di chilometri da Carbonia. Pur essendo pi vicino a Bacu Abis faceva parte della circoscrizione municipale di Cortoghiana.
La frazione Medau Peddis
Entrati nell’abitato di Domu Beccia, seguiamo la strada che ci ha portati in esso, le seguiamo fino a dove svolta a destra, e prendiamo la prima deviazione a sinistra che è la strada che conduce verso est. La seguiamo per poco più di cinquecento metri, finché si immette su una trasversale, che prendiamo verso sinistra. Dopo seicento metri svoltiamo a destra e prendiamo la strada che, in cinquecento metri, ci porta all’interno della frazione Medau Peddis (altezza metri 90, distanza in linea d’aria circa 8.9 chilometri, abitanti circa 36), ossia il Casale della famiglia Peddis, situato in località Terra Segada, ossia Terra Spaccata. Si tratta di un casale agropastorale anch’esso di origini antiche, che risulta distante un paio di chilometri dal centro di Bacu Abis.
La frazione Medau Brau
Proseguendo lungo la strada che ci ha portati a Medau Peddis, in settecento metri arriviamo all’interno della frazione Medau Brau (altezza metri 108, distanza in linea d’aria circa 8.2 chilometri, abitanti circa 27), ossia il Casale della famiglia Brau, situato anch’esso in località Terra Segada, ossia Terra Spaccata. Si tratta di un casale agropastorale di origini antiche, forse romane, dato che nei suoi dintorni sono stati effettuati diversi ritrovamenti archeologici riferiti al periodo della presenza romana in Sardegna. Poco prima del 1878, l’architetto Filippo Vivanet invia l’archeologo Filippo Nissardi nel territorio di Bacu Abis, e dalla sua relazione inviata alla regia Accademia dei Lincei, si apprende che gli scavi archeologici effettuati dall’ingegner Bianchi, direttore della miniera carbonifera omonima, hanno portato al rinvenimento dei resti di due Ville romane che ricordano ambienti della casa rustica e rurale della Sardegna meridionale, poste nella vallata di Flumentepido, presso l’antica strada romana che da Carales portava a Sulci; ed anche di diverse Tombe romane nelle quali sono state rinvenute monete consolari, dei primi Cesari e dei Costantini, lucerne del primo secolo dell’impero romano, altre del quarto e del quinto secolo dopo Cristo con i simboli della croce e del monogramma di Cristo, ed anche oggetti in terracotta, tra i quali un piatto dove si raffigurano nel fondo tre anime che si beano in Cristo, rappresentate allegoricamente da tre colombe attorno al monogramma di Cristo.
La concessione mineraria di Terra Segada
La frazione Medau Brau è nota, inoltre, anche perché nella vicina località Cannamenda, vicino all’omonimo rio, nel 1838 Alberto Ferrero della Marmora, che era stato nominato commissario straordinario per la Sardegna, scopre il primo giacimento di carbone presente nella Sardegna, che è diventato poi la concessione mineraria di Terra Segada oggetto di ricerche ed esplorazioni.
La importante frazione Bacu Abis
 Dal cimitero di Cortoghiana, percorsi ancora poco più di un paio di chilometri lungo la SS126 Sud Occidentale Sarda, arrivati al cartello che indica il chilometro chilometro 25 troviamo la deviazione verso destra nella via Pozzo Castoldi che, dopo seicento metri, ci fa raggiungere una rotonda dove la terza uscita porta sulla via Santa Barbara che ci fa raggiungere l’interno della importante frazione Bacu Abis (altezza metri 85, distanza in linea d’aria circa 11.8 chilometri, abitanti circa 1.673), che sino al 1937 era stata una frazione del comune di Gonnesa ed oggi costituisce l’estremità nord occidentale dell’area comunale di Carbonia.
Dal cimitero di Cortoghiana, percorsi ancora poco più di un paio di chilometri lungo la SS126 Sud Occidentale Sarda, arrivati al cartello che indica il chilometro chilometro 25 troviamo la deviazione verso destra nella via Pozzo Castoldi che, dopo seicento metri, ci fa raggiungere una rotonda dove la terza uscita porta sulla via Santa Barbara che ci fa raggiungere l’interno della importante frazione Bacu Abis (altezza metri 85, distanza in linea d’aria circa 11.8 chilometri, abitanti circa 1.673), che sino al 1937 era stata una frazione del comune di Gonnesa ed oggi costituisce l’estremità nord occidentale dell’area comunale di Carbonia.  Diverse sono le ipotesi sull’origine del suo nome: il nome potrebbe indicare una Gola delle api, come narrato da Primo Levi nel racconto Piombo del suo libro Il sistema periodico, dove scrive «…questo villaggio che ho fondato presso il ruscello delle api selvatiche, ed a cui avrei voluto dare un nome della mia lingua che sto dimenticando, Bak der Binnen, che significa appunto 'Rio delle Api': ma la gente di qui ha accettato il nome solo in parte, e fra di loro, nel loro linguaggio che è ormai il mio, lo chiamano 'Bacu Abis'». Un altro significato potrebbe però ricondurre il nome a Forra o gola degli Abis, una famiglia antica proprietaria delle terre dove oggi sorge il paese. Comunque, la zona nel Settecento era nota col nome S’Ortu de Is Abis, che in sardo può voler dire sia Orto delle api che Orto degli Abis.
Diverse sono le ipotesi sull’origine del suo nome: il nome potrebbe indicare una Gola delle api, come narrato da Primo Levi nel racconto Piombo del suo libro Il sistema periodico, dove scrive «…questo villaggio che ho fondato presso il ruscello delle api selvatiche, ed a cui avrei voluto dare un nome della mia lingua che sto dimenticando, Bak der Binnen, che significa appunto 'Rio delle Api': ma la gente di qui ha accettato il nome solo in parte, e fra di loro, nel loro linguaggio che è ormai il mio, lo chiamano 'Bacu Abis'». Un altro significato potrebbe però ricondurre il nome a Forra o gola degli Abis, una famiglia antica proprietaria delle terre dove oggi sorge il paese. Comunque, la zona nel Settecento era nota col nome S’Ortu de Is Abis, che in sardo può voler dire sia Orto delle api che Orto degli Abis.
Brevi cenni storici
La storia di questo abitato inizia alla met dell Ottocento con la scoperta di alcuni giacimenti di lignite, utili per il fabbisogno nazionale come fonte energetica, e Bacu Abis nasce per ospitare i lavoratori occupati nell’industria estrattiva. L’ingegnere torinese Anselmo Roux, che nel 1871 aveva raccolto tra i familiari e amici il capitale e fondato la Societ Anonima proprietaria delle Miniere di carbone di Bacu Abis, divenuto direttore della miniera dal 1873 al 1899, amplia la parte più antica del paese. Infatti, l insediamento ottocentesco del centro carbonifero di Bacu Abis era inizialmente costituito da un nucleo abitativo di due lunghi edifici fronteggianti fra loro, denominato Case Congia, edificate nel 1914. All epoca Bacu Abis era frazione del comune di Gonnesa, e lo fu fino al 5 novembre 1937, quando venne poi inglobato nel nuovo Comune di Carbonia, del quale diventa una frazione. Il carbone di Bacu Abis diviene, durante la prima guerra mondiale, l’unica fonte energetica disponibile, tanto che lo Stato dichiara la miniera Stabilimento Ausiliario. Dopo il Conflitto, inizia il declino, ma i sacrifici dei minatori, e l’intervento dei sindacati fascisti guidati da Vittorio Tredici, salvano la miniera e la Mineraria Carbonifera Sarda ne assume la gestione. Il carbone del Sulcis viene valorizzato dalla politica autarchica del regime. Dal 1935 viene realizzato il secondo nucleo del paese, in stile razionalista fascista.
Visita dell’abitato
Negli anni dal 1936 al 1938, su progetto di Gustavo Pulitzer-Finali e dei suoi collaboratori, si decide di costruire un Razionale Villaggio Operaio, comprendente venti isolati, con alloggi per ottanta famiglie di minatori, e tre isolati per sette famiglie di impiegati. A questo primo nucleo edilizio, costruito nell asse viario di viale della Libert , si aggiunge l ex casa del Fascio con piccola torre, il cine teatro con sul lato destro il balcone del dopolavoro da cui si affacciò Mussolini durante la sua visita nel paese minerario, lo spaccio aziendale e l ambulatorio. La casa del Direttore, ubicata tra il viale della Libertà e la via Santa Barbara, ormai molto malridotta, si presenta circondata da due ampi giardini in uno stile semplice e lineare. Di fronte si snoda il lungo viale della Libertà dove risiedevano i dirigenti. Gli alloggi per gli operai furono costruiti nelle aree est e ovest del nucleo centrale. Per gli scapoli vennero realizzati i cameroni, una mensa e la lavanderia, gestita dalle Suore Orsoline.
La chiesa di Santa Barbara Vergine e Martire
 Da dove avevamo preso la via Pozzo Castoldi, la seguiamo fino all’interno dell’abitato e, dopo seicento metri, raggiungiamo una rotonda, alla quale la seconda uscita porta della via Santa Barbara che, in quattrocento metri, porta nella piazza Pietro Micca, che si trova a nord dell’abitato, nella quale sono presenti i tre monumenti più importanti di Bacu Abis, che sono la chiesa, la grotta di Lourdes, ed il Monumento ai Caduti. La Chiesa di Santa Barbara Vergine e Martire che è la parrocchiale della frazione Bacu Abis, era in passato intitolata a San Vittorio, e viene intitolata dal 1938 alla Santa protettrice dei minatori. Realizzata secondo un architettura di stampo razionalista, sorge in posizione isolata rispetto al resto del centro abitato di Bacu Abis, e si presenta affiancata, sul versante sinistro e per gran parte della facciata, da una sorta di ardica, una zona porticata che abbraccia anche l ingresso principale. L edificio, in pietra, caratterizzato da un profilo a capanna, con la facciata impreziosita da un rosone con vetro bicolore, che permette ai raggi del sole di illuminare l’altare al suo sorgere. In corrispondenza dell angolo destro, ma in posizione avanzata, inserito il campanile, a canna quadrata, con copertura a spiovente che segue la medesima inclinazione della falda sinistra del tetto della chiesa. Internamente lo sviluppo planimetrico contenuto entro un ambiente di pianta rettangolare, nel quale solo a sinistra, mediante alcuni archi, dall ultimo dei quali si accede anche alla sacrestia, sono ricavati spazi adibiti a cappelle. Sulla parete sinistra e su quella di fondo sono ricavate aperture di forma e grandezza differenti, che illuminano la navata.
Da dove avevamo preso la via Pozzo Castoldi, la seguiamo fino all’interno dell’abitato e, dopo seicento metri, raggiungiamo una rotonda, alla quale la seconda uscita porta della via Santa Barbara che, in quattrocento metri, porta nella piazza Pietro Micca, che si trova a nord dell’abitato, nella quale sono presenti i tre monumenti più importanti di Bacu Abis, che sono la chiesa, la grotta di Lourdes, ed il Monumento ai Caduti. La Chiesa di Santa Barbara Vergine e Martire che è la parrocchiale della frazione Bacu Abis, era in passato intitolata a San Vittorio, e viene intitolata dal 1938 alla Santa protettrice dei minatori. Realizzata secondo un architettura di stampo razionalista, sorge in posizione isolata rispetto al resto del centro abitato di Bacu Abis, e si presenta affiancata, sul versante sinistro e per gran parte della facciata, da una sorta di ardica, una zona porticata che abbraccia anche l ingresso principale. L edificio, in pietra, caratterizzato da un profilo a capanna, con la facciata impreziosita da un rosone con vetro bicolore, che permette ai raggi del sole di illuminare l’altare al suo sorgere. In corrispondenza dell angolo destro, ma in posizione avanzata, inserito il campanile, a canna quadrata, con copertura a spiovente che segue la medesima inclinazione della falda sinistra del tetto della chiesa. Internamente lo sviluppo planimetrico contenuto entro un ambiente di pianta rettangolare, nel quale solo a sinistra, mediante alcuni archi, dall ultimo dei quali si accede anche alla sacrestia, sono ricavati spazi adibiti a cappelle. Sulla parete sinistra e su quella di fondo sono ricavate aperture di forma e grandezza differenti, che illuminano la navata.
Ogni anno, a inizio agosto, presso questa chiesa ed all’interno dell’abitato di Bacu Abis si svolge la Sagra di Santa Barbara, ossia la festa della patrona dei minatori, con cerimonie religiose e manifestazioni civili.
Vicino alla chiesa la riproduzione della grotta di Lourdes ed il Monumento ai Caduti
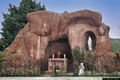 La riproduzione della Grotta di Lourdes, voluta da Don Nazzareno, viene inaugurata nel 1953 e si trova a destra della chiesa.
La riproduzione della Grotta di Lourdes, voluta da Don Nazzareno, viene inaugurata nel 1953 e si trova a destra della chiesa.  L’opera rappresenta un arco roccioso con all’interno un altare, una nicchia con la statua della Madonna. La grotta rappresenta un simbolo importante per la comunità di Bacu Abis ed è meta di pellegrinaggi da parte di persone anche dai paesi vicini. Alla sinistra della chiesa, dirimpetto alla grotta di Lourdes, si trova il monumento realizzato per onorare la memoria dei caduti delle due Guerre Mondiali, inaugurato nel 1950. Il monumento è stato ribattezzato Il Cannone, ed intorno ad esso, ogni 4 novembre, gli abitanti del paese ed i rappresentanti dei corpi militari ed istituzionali si radunano per la commemorazione dei caduti di Bacu Abis nelle due Guerre Mondiali.
L’opera rappresenta un arco roccioso con all’interno un altare, una nicchia con la statua della Madonna. La grotta rappresenta un simbolo importante per la comunità di Bacu Abis ed è meta di pellegrinaggi da parte di persone anche dai paesi vicini. Alla sinistra della chiesa, dirimpetto alla grotta di Lourdes, si trova il monumento realizzato per onorare la memoria dei caduti delle due Guerre Mondiali, inaugurato nel 1950. Il monumento è stato ribattezzato Il Cannone, ed intorno ad esso, ogni 4 novembre, gli abitanti del paese ed i rappresentanti dei corpi militari ed istituzionali si radunano per la commemorazione dei caduti di Bacu Abis nelle due Guerre Mondiali.
Il campo sportivo di Bacu Abis
Dalla SS126 Sud Occidentale Sarda, abbiamo presa la deviazione verso destra nella via Pozzo Castoldi, la seguiamo per circa seicento metri e raggiungiamo una rotonda dove prendiamo la prima uscita che ci porta sulla via Pozzo Nuovo, dopo centocinquanta metri svoltiamo a destra e, in una cinquantina di metri, ci fa raggiungere il Campo Sportivo di Bacu Abis. Si tratta di un Campo da calcio a 11, con fondo in terra battuta, di tribune in grado di ospitare 720 spettatori.
Il giacimento carbonifero di Bacu Abis
Il giacimento carbonifero di Bacu Abis viene scoperto nel 1851 da Ubaldo Millo, che ottiene nel 1853 tre concessioni carbonifere, quella di Bacu Abis, e quelle di Terras Collu e di Funtanamare che si trovano ad ovest rispetto all’abitato di Bacu Abis, in territorio di Gonnesa. La miniera di Bacu Abis sfruttava l’omonimo giacimento carbonifero, con gli impianti estrattivi di Pozzo Roth, Pozzo Emilio, Pozzo Castoldi, Pozzo Nuovo. A nord ovest delle abitazioni della frazione, lungo la strada ferrata, si trovano i ruderi della Laveria del carbone della minera di Bacu Abis.
Il Pozzo Castoldi si trova alla destra della via Pozzo Castoldi, a duecentosettanta metri da dove la abbiamo presa dalla SS126 Sud Occidentale Sarda. La sua costruzione risale al 1929, e nei due anni successivi vengono realizzati il castello, la cabina dell’argano e le gallerie, tanto che nel 1931 entra in esercizio. Rivestito in muratura, grazie alle sue dimensioni permetteva il transito di due gabbie.L’attività estrattiva viene interrotta nel 1941 per l’esaurimento del filone. Il pozzo sarà in seguito utilizzato come galleria di collegamento con la nuova miniera di Cortigiana, e viene dismesso nella seconda metà degli anni cinquanta dello scorso secolo, con la cessazione dei lavori di coltivazione in tutta la miniera.
A nord dell’abitato rimangono i ruderi della stazione ferroviaria di Bacu Abis delle Ferrovie Meridionali Sarde
 Dalla piazza Pietro Micca, la prosecuzione verso nord della via Santa Barbara è la via Pietro Micca che, seguita per circa un chilometro, porta ai ruderi della Stazione ferroviaria di Bacu Abis, la quale era una stazione ferroviaria situata lungo due linee a scartamento ridotto, quella che collegavano San Giovanni Suergiu con Iglesias, e la ferrovia privata che collegava Monteponi con Portovesme. Lo scalo nasce nel 1930 su iniziativa delle Ferrovie Meridionali Sarde, societ in quegli anni particolarmente attiva dal punto di vista estrattivo, in corrispondenza della casa cantoniera numero quarantasei. La necessit di un impianto a Bacu Abis era legata al potenziamento del sistema di trasporti del carbone estratto nell’area, che comunque era gi attraversata dalla ferrovia privata che collegava Monteponi con Portovesme. Il nuovo scalo viene quindi collocato in modo che sia servito da entrambe le linee, e le Ferrovie Meridionali Sarde lo edificano a nord dell’abitato di Bacu Abis, che in quegli stessi anni si apprestava a essere significativamente espanso. L’impianto nasce in origine con caratteristiche di fermata, tuttavia la grande mole di carbone estratto a Bacu Abis porta gi a fine decennio al potenziamento dell’impianto, che viene ampliato, dotato di un rifornitore idrico, e successivamente della interconnessione dei binari delle due ferrovie. Dopo l’ampliamento a stazione, lo scalo di Bacu Abis diviene inoltre scalo capolinea di vari convogli per il trasporto del carbone, ed il traffico ferroviario si mantiene su alti livelli anche nell’immediato dopoguerra, tuttavia con la fine dell’embargo contro l’Italia in vigore dagli anni trenta il locale carbone Sulcis patisce la concorrenza dei combustibili esteri, fatto che porterà successivamente alla dismissione della gran parte delle miniere del territorio, comprese quelle di Bacu Abis. Si registra, inoltre, nel gennaio 1963 la cessazione dell’esercizio sulla ferrovia privata che collegava Monteponi con Portovesme, data la decisione della propriet di utilizzare i mezzi gommati per l’inoltro dei materiali estratti dalla miniera di Monteponi. Dopo tale chiusura l’attivit ferroviaria a Bacu Abis prosegue con le sole Ferrovie Meridionali Sarde, che in quello stesso periodo riducono in maniera drastica il servizio merci sulla loro rete, effettuando quasi esclusivamente treni viaggiatori. La storia della stazione ha termine nel 1974, data della cessazione del servizio ferroviario tra San Giovanni Suergiu ed Iglesias, le cui relazioni vengono sostituite da autocorse. In seguito l’impianto viene smantellato e abbandonato.
Dalla piazza Pietro Micca, la prosecuzione verso nord della via Santa Barbara è la via Pietro Micca che, seguita per circa un chilometro, porta ai ruderi della Stazione ferroviaria di Bacu Abis, la quale era una stazione ferroviaria situata lungo due linee a scartamento ridotto, quella che collegavano San Giovanni Suergiu con Iglesias, e la ferrovia privata che collegava Monteponi con Portovesme. Lo scalo nasce nel 1930 su iniziativa delle Ferrovie Meridionali Sarde, societ in quegli anni particolarmente attiva dal punto di vista estrattivo, in corrispondenza della casa cantoniera numero quarantasei. La necessit di un impianto a Bacu Abis era legata al potenziamento del sistema di trasporti del carbone estratto nell’area, che comunque era gi attraversata dalla ferrovia privata che collegava Monteponi con Portovesme. Il nuovo scalo viene quindi collocato in modo che sia servito da entrambe le linee, e le Ferrovie Meridionali Sarde lo edificano a nord dell’abitato di Bacu Abis, che in quegli stessi anni si apprestava a essere significativamente espanso. L’impianto nasce in origine con caratteristiche di fermata, tuttavia la grande mole di carbone estratto a Bacu Abis porta gi a fine decennio al potenziamento dell’impianto, che viene ampliato, dotato di un rifornitore idrico, e successivamente della interconnessione dei binari delle due ferrovie. Dopo l’ampliamento a stazione, lo scalo di Bacu Abis diviene inoltre scalo capolinea di vari convogli per il trasporto del carbone, ed il traffico ferroviario si mantiene su alti livelli anche nell’immediato dopoguerra, tuttavia con la fine dell’embargo contro l’Italia in vigore dagli anni trenta il locale carbone Sulcis patisce la concorrenza dei combustibili esteri, fatto che porterà successivamente alla dismissione della gran parte delle miniere del territorio, comprese quelle di Bacu Abis. Si registra, inoltre, nel gennaio 1963 la cessazione dell’esercizio sulla ferrovia privata che collegava Monteponi con Portovesme, data la decisione della propriet di utilizzare i mezzi gommati per l’inoltro dei materiali estratti dalla miniera di Monteponi. Dopo tale chiusura l’attivit ferroviaria a Bacu Abis prosegue con le sole Ferrovie Meridionali Sarde, che in quello stesso periodo riducono in maniera drastica il servizio merci sulla loro rete, effettuando quasi esclusivamente treni viaggiatori. La storia della stazione ha termine nel 1974, data della cessazione del servizio ferroviario tra San Giovanni Suergiu ed Iglesias, le cui relazioni vengono sostituite da autocorse. In seguito l’impianto viene smantellato e abbandonato.
A sud dell’abitato si trovava la fermata ferroviaria di Pozzo Nuovo
 Dal campo sportivo di Bacu Abis, proseguiamo verso sud lungo la via Pozzo Nuovo che, dopo ottocentocinquanta metri, sbocca sulla SS126 Sud Occidentale Sarda, all’altezza del chilometro 23.7 ossia circa un chilometro e trecento metri prima della deviazione verso destra nella via Pozzo Castoldi che ci aveva portati all’interno dell’abitato della frazione Bacu Abis. Subito prima del termine della via Pozzo Nuovo, alla destra di questa strada, si trovava la Fermata ferroviaria di Pozzo Nuovo delle Ferrovie Meridionali Sarde, al servizio dell’omonima miniera carbonifera a Bacu Abis, posta lungo la linea tra San Giovanni Suergiu ed Iglesias. La fermata è stata istituita in corrispondenza della casa cantoniera numero quarantacinque della propria rete ferroviaria, collocata alle porte di Bacu Abis a pochi metri dalla SS126, dinanzi ai cantieri minerari di Pozzo Nuovo, una delle miniere carbonifere della frazione. E proprio la presenza di questa miniera particolarmente attiva negli anni dell’autarchia è stata la causa dell’istituzione di questa fermata, che risultava in uso a inizio anni quaranta sia per il servizio merci che per quello viaggiatori. L’attività nell’impianto, tuttavia, è durato pochi anni, dato che con la chiusura della miniera, alla fine degli anni cinquanta la fermata è risultata priva di traffico, situazione che si è mantenuta sino al momento della cessazione dell’esercizio ferroviario sulla linea nel 1974. Successivamente lo scalo è stato smantellato e completamente demolito.
Dal campo sportivo di Bacu Abis, proseguiamo verso sud lungo la via Pozzo Nuovo che, dopo ottocentocinquanta metri, sbocca sulla SS126 Sud Occidentale Sarda, all’altezza del chilometro 23.7 ossia circa un chilometro e trecento metri prima della deviazione verso destra nella via Pozzo Castoldi che ci aveva portati all’interno dell’abitato della frazione Bacu Abis. Subito prima del termine della via Pozzo Nuovo, alla destra di questa strada, si trovava la Fermata ferroviaria di Pozzo Nuovo delle Ferrovie Meridionali Sarde, al servizio dell’omonima miniera carbonifera a Bacu Abis, posta lungo la linea tra San Giovanni Suergiu ed Iglesias. La fermata è stata istituita in corrispondenza della casa cantoniera numero quarantacinque della propria rete ferroviaria, collocata alle porte di Bacu Abis a pochi metri dalla SS126, dinanzi ai cantieri minerari di Pozzo Nuovo, una delle miniere carbonifere della frazione. E proprio la presenza di questa miniera particolarmente attiva negli anni dell’autarchia è stata la causa dell’istituzione di questa fermata, che risultava in uso a inizio anni quaranta sia per il servizio merci che per quello viaggiatori. L’attività nell’impianto, tuttavia, è durato pochi anni, dato che con la chiusura della miniera, alla fine degli anni cinquanta la fermata è risultata priva di traffico, situazione che si è mantenuta sino al momento della cessazione dell’esercizio ferroviario sulla linea nel 1974. Successivamente lo scalo è stato smantellato e completamente demolito.
Visita dei dintorni a nord est dell’abitato della città di Carbonia
Ci rechiamo, ora, a visitare i dintorni a nord est di Carbonia, con le diverse frazioni che si trovano lungo la SP2 che si dirige verso Villamassargia. Dal centro di Carbonia ci recheremo alla Stazione ferroviaria di Carbonia Serbariu, dalla quale la via della Stazione ci porta ai resti della Stazione ferroviaria dismessa di Carbonia Stato, e poi, passata una rotonda, esce dall’abitato dirigendosi verso nord ovest con il nome di via del Minatore.
Raggiungiamo la frazione Medau Tanas
Presa la via del Minatore che esce dall’abitato dirigendosi verso nord ovest, in un paio di chilometri arriviamo all’interno dell’abitato di Sirai, dal quale usciamo verso nord est con la Strada Statale Sirai, che, in un chilometro, ci porta all’interno della frazione Medau Tanas (altezza metri 105, distanza in linea d’aria circa 3.9 chilometri, abitanti circa 19), ossia il Casale della famiglia Tanas, che era un casale agropastorale.
La miniera di Sa Corona 'e Sa Craba
 Ad est dell’abitato della frazione Medau Tanas si trova la miniera di Sa Corona 'e Sa Craba, il cui nome in sardo significa la Corona della Capra. La grotta di Sa Corona e Sa Craba situata ad un altitudine di 260 metri, e la cavità si sviluppa per oltre duecento metri in direzione sud est. È stata scoperta nel 1971 da speleologi del Gruppo Ricerche Speleologiche Édouard-Alfred Martel di Carbonia, e l’area di Sa Corona 'e Sa Craba, è stata esplorata per giacimenti di piombo, zinco e barite nei primi anni trenta del Novecento, e lo sfruttamento economico è continuato per poco più di trenta anni dopo il 1950. Malgrado le numerosissime visite dei ricercatori di minerali, solo cinque minerali erano noti in questa località, ossia barite in bellissimi cristalli che diventano bluastri all esposizione alla luce del sole, calcite, dolomite, quarzo ed aragonite. L’intera grotta si sviluppa nella quarzite, con passaggi molto larghi ed evidenti segni di dissoluzione ad opera di acidi forti, che probabilmente derivavano dall’ossidazione dei corpi mineralizzati a solfuri che sono presenti nella zona, o da risalita di fluidi idrotermali legati ad attività vulcanica.
Ad est dell’abitato della frazione Medau Tanas si trova la miniera di Sa Corona 'e Sa Craba, il cui nome in sardo significa la Corona della Capra. La grotta di Sa Corona e Sa Craba situata ad un altitudine di 260 metri, e la cavità si sviluppa per oltre duecento metri in direzione sud est. È stata scoperta nel 1971 da speleologi del Gruppo Ricerche Speleologiche Édouard-Alfred Martel di Carbonia, e l’area di Sa Corona 'e Sa Craba, è stata esplorata per giacimenti di piombo, zinco e barite nei primi anni trenta del Novecento, e lo sfruttamento economico è continuato per poco più di trenta anni dopo il 1950. Malgrado le numerosissime visite dei ricercatori di minerali, solo cinque minerali erano noti in questa località, ossia barite in bellissimi cristalli che diventano bluastri all esposizione alla luce del sole, calcite, dolomite, quarzo ed aragonite. L’intera grotta si sviluppa nella quarzite, con passaggi molto larghi ed evidenti segni di dissoluzione ad opera di acidi forti, che probabilmente derivavano dall’ossidazione dei corpi mineralizzati a solfuri che sono presenti nella zona, o da risalita di fluidi idrotermali legati ad attività vulcanica.
La frazione Barbusi
Dall’abitato di Medau Tanas, la Strada Statale Sirai prosegue con il nome di via Santa Maria delle Grazie, e, in quattrocento metri, ci porta ad entrare nella frazione Barbusi (altezza metri 119, distanza in linea d’aria circa 4.7 chilometri, abitanti circa 546). Prima della fondazione della città di Carbonia, dal 1853 fino al 1937, Barbusi era una frazione del comune di Serbariu, che è stato poi soppresso ed inglobato nel nuovo comune di Carbonia. Barbusi nel secondo dopoguerra è stata sede di delegazione comunale, e sino al 2011 è stata una circoscrizione municipale extraurbana e decentrata del comune di Carbonia. Il nome della frazione secondo alcuni si farebbe risalire al fenicio punico bar-bus, che significherebbe Pozzo fetido o Acquitrino. Il suo territorio è stato fino dalla preistoria, e poi in epoca fenicio punica e successivamente in epoca romana. Diviene, poi, una Villa del Giudicato di Càralis, nella Curatoria del Sulcis. Il nome di Barbusi è citato nel Codex Diplomaticus Ecclesiensis del 1877.
La chiesa parrocchiale di Nostra Signora delle Grazie
Da dove siamo arrivati all’interno dell’abitato di Barbusi, percorsi circa cinquecento metri, al civico numero 112 della via Santa Maria delle Grazie, alla destra della strada, si trova l’edificio che ospita la Chiesa di Nostra Signora delle Grazie che è la parrocchiale della frazione Barbusi. La chiesa parrocchiale stata inaugurata nel 1957. Il prospetto dell edificio, che si caratterizzava in passato per il paramento in mattoni esteso a tutta la superficie, oggi intonacato nella porzione superiore, dove posta una finestra circolare e che coronata da un prolungamento della muratura in quello che potrebbe sembrare un campanile a vela. La porzione inferiore invece contraddistinta dalla presenza di una sorta di ardica, un portico, che dal versante destro della chiesa si spinge ad abbracciare il portale di ingresso. Internamente la chiesa si sviluppa in un unico spazio a pianta rettangolare, contraddistinto esclusivamente dalla presenza degli elementi costruttivi a vista lungo le pareti perimetrali maggiori e nella copertura. Questa chiesa costituiva una delle tappe della strada denominata de Sa Reliquia, che era il percorso della processione di Sant’Antioco che da Iglesias arrivava all’antica Sulci, raggiungendo le Chiese di Santa Maria di Barega, Santa Barbara di Piolanas e Santa Maria delle Grazie di Barbusi.
Nel maggio 1986 il borgo e la chiesa parrocchiale di Barbusi sono stati visitati da Madre Teresa di Calcutta, nel corso del suo viaggio in Sardegna prima della sua morte, della beatificazione il 19 ottobre 2003 da parte di papa Giovanni Paolo II, e della successiva santificazione il 4 settembre 2016 da parte di papa Francesco.
Nella frazione Barbusi si svolgono diverse manifestazioni, ossia la prima settimana di luglio la Festa di nostra Signora delle Grazie, ed a fine luglio o inizio settembre la Festa di Sant’Isidoro, in occasione della quale numerosi risvolti folkloristici, con la partecipazione alle processioni di vari gruppi provenienti dal resto dell’isola. Da segnalare inoltre la Festa de Su Curruscioni, pasta tipica sarda che viene preparata dalle donne del borgo secondo la tradizione, per essere poi degustata.
Il campo sportivo di Barbusi
Passata la Chiesa di Nostra Signora delle Grazie proseguiamo lungo la via Santa Maria delle Grazie oper una trentina di metri, poi svoltiamo a sinistra nella via Madre Teresa di Calcutta e, dopo una settantina di metri, a destra sulla via Sant’Isidoro che scorre parallela alla SP2 che si dirige verso Villamassargia. Percorso un centinaio di metri, attraversiamo la SP2 ed arriviamo di fronte al cancello di ingresso del Campo sportivo di Barbusi, che ospita il Campo da calcio comunale a 11 di Barbusi, con fondo in terra battuta, e senza tribune per gli spettatori.
I ruderi della stazione ferroviaria di Barbusi delle Ferrovie Meridionali Sarde
 Dall’ingresso del campo sportivo, procediamo in direzione sudovest sulla SP2 superando lo svincolo Barbusi Sud, percorsi settecentocinquanta metri dal campo sportivo svoltiano a destra e prendiamo una deviazione che diventa una strada bianca. Dopo quattrocento metri svoltiamo a sinistra, altri duecentosettanta metri e svoltiamo leggermente a destra, e precorsi altri centosettanta metri raggiungiamo quello che resta della Stazione ferroviaria di Barbusi delle Ferrovie Meridionali Sarde, che era una fermata ferroviaria a servizio dell’omonima frazione del comune di Carbonia, situata lungo la dismessa linea a scaramento ridotto che collegava San Giovanni Suergiu con Iglesias. Le origini della fermata risalgono agli anni venti del Novecento, nell’ambito della fase di costruzione di una rete ferroviaria a scartamento ridotto per il Sulcis Iglesiente, portata avanti per conto della Ferrovie Meridionali Sarde. I lavori di costruzione della linea e della fermata vengono eseguiti tra il 1923 ed il 1926, ed entrambe sono inaugurate il 13 maggio 1926. L’impianto serve principalmente la frazione di Barbusi, posta alcune centinaia di metri più a est, sebbene parte del traffico locale si dirotterà in seguito verso la omonima stazione delle Ferrovie dello Stato di Barbusi Caput Aques, in funzione dal 1956. L’attività nella fermata viene, comunque, espletata anche sino al 1974, data di cessazione del servizio ferroviario sull’intera rete delle Ferrovie Meridionali Sarde. L’impianto viene quindi dismesso ed in seguito disarmato, mentre i fabbricati vengono abbandonati.
Dall’ingresso del campo sportivo, procediamo in direzione sudovest sulla SP2 superando lo svincolo Barbusi Sud, percorsi settecentocinquanta metri dal campo sportivo svoltiano a destra e prendiamo una deviazione che diventa una strada bianca. Dopo quattrocento metri svoltiamo a sinistra, altri duecentosettanta metri e svoltiamo leggermente a destra, e precorsi altri centosettanta metri raggiungiamo quello che resta della Stazione ferroviaria di Barbusi delle Ferrovie Meridionali Sarde, che era una fermata ferroviaria a servizio dell’omonima frazione del comune di Carbonia, situata lungo la dismessa linea a scaramento ridotto che collegava San Giovanni Suergiu con Iglesias. Le origini della fermata risalgono agli anni venti del Novecento, nell’ambito della fase di costruzione di una rete ferroviaria a scartamento ridotto per il Sulcis Iglesiente, portata avanti per conto della Ferrovie Meridionali Sarde. I lavori di costruzione della linea e della fermata vengono eseguiti tra il 1923 ed il 1926, ed entrambe sono inaugurate il 13 maggio 1926. L’impianto serve principalmente la frazione di Barbusi, posta alcune centinaia di metri più a est, sebbene parte del traffico locale si dirotterà in seguito verso la omonima stazione delle Ferrovie dello Stato di Barbusi Caput Aques, in funzione dal 1956. L’attività nella fermata viene, comunque, espletata anche sino al 1974, data di cessazione del servizio ferroviario sull’intera rete delle Ferrovie Meridionali Sarde. L’impianto viene quindi dismesso ed in seguito disarmato, mentre i fabbricati vengono abbandonati.
La miniera di Barbusi
Ad est dell’abitato della frazione Barbusi si trovava la Concessione mineraria di Barbusi, per la quale sono state effettuate vecchie esplorazioni di ricerca. La miniera di Barbusi è stata caratterizzata, come per la la miniera di Sa Corona 'e Sa Craba, da una cava dove avveniva l’estrazione prevalente di barite, ed anche di altri minerali come calcite e galena. Da tale miniera provengono cristalli di barite di rara bellezza, oltre che di galena e calcite. La concessione di 85 ettari di territorio è stata affidata nel 1935 alla Società Italiana della Barite, successivamente nel 1957 la miniera era di proprietà della Socità Italiana del Litopone, assieme a quella di Barega, ed infine negli anni sessanta è passata prima alla Società Montecatini e quindi alla Bariosarda.
Il bosso delle Baleari che si trova sulla piccola montagna denominata S'Arriu de Suttu
Vicino all’abitato della frazione Barbusi, è presente una piccola montagna denominata S’Arriu de Suttu, ossia il Rivo di Sotto, o forse S’Arriu de S'Utu, ossia il Rivo della Gola. Su questa altura, minacciata da una cava per l’estrazione della ghiaia, si trova una pianta rara, il Bosso delle Baleari, ossia Buxus Balearica, che è una vegetazione arbustiva con foglie grandi e lunghe fino a quattro centimetri, bislunghe, di colore verde chiaro, e con fiori profumati. Si tratta di una specie spontanea, nativa delle Isole Baleari, della Spagna sudorientale e dell’Africa nordoccidentale, che in Italia si trova solo in Sardegna, in due località nel territorio comunale di Carbonia, a Barbusi su questa montagna, ed a Monte Tasua.
La frazione Caput Acquas e la vicina frazione Acqua Callentis nota anche come Is Perdas
Dalla chiesa parrocchiale di Barbusi proseguiamo lungo la via Santa Maria delle Grazie, dopo ottocentocinquanta metri questa strada si immette su una trasversale, che, presa verso sinistra, passa sotto la SP2. Presa la trasversale che passa sotto la SP2 percorriamo un centinaio di metri, poi svoltiamo a destra e proseguiamo. Presa la trasversale che passa sotto la SP2, dopo un centinaio di metri svoltiamo a destra e, percorsa appena una sessantina di metri, svoltiamo a sinistra e proseguiamo.
La località Caput Acquas
Percorso circa un chilometro, raggiungiamo la località Caput Acquas (altezza metri 76, distanza in linea d’aria circa 6.9 chilometri, abitanti circa 31), un casale ad economia agropastorale situato lungo le rive del rio Flumentepido che attraversa l’abitato. Il nome di Caput Acquas, ossia Sorgente delle acque, deriva da una vicina sorgente e fonte di acque potabili molto rinomate, conosciute fino dall’antichità, che si trova ad est dell’abitato lungo la riva sinistra del Flumentepido, a un paio di chilometri di distanza, in territorio della frazione Genna Corriga, che troveremo più avanti.
La miniera di Caput Acquas
 Nel territorio di Caput Acquas si trovava la miniera di Caput Acquas che sfruttava due giacimenti carboniferi, quello di Caput Acquas e quello di Piolanas. I banchi carboniosi coltivati nell’area di Caput Acquas e Piolanas appartenevano a due bacini distinti separati da una dorsale paleozoica. La miniera di Caput Acquas viene concessa nel 1878 a Leon Gouin, poi ceduta a Filippo Birocchi e quindi nel 1896 ad Anselmo Roux. Nella concessione erano attivi gli impianti estrattivi di pozzo Caput Acquas, pozzo Tolmetta, pozzo Zara, pozzo Is Piras, pozzo D. Il massimo della produzione viene raggiunto nel 1938 con 516 operai. Nel settembre del 1913 la miniera di Caput Acquas passa alla Società Carbonifera di Bacu Abis. All’esterno funzionava a pieno regime la ferrovia a trazione a vapore lunga sei chilometri che collegava Caput Acquas con la stazione lungo la ferrovia che collegava Monteponi con Portovesme. Nel 1929 la miniera viene concessa in perpetuo alla Società Anonima di Bacu Abis. Nel 1934 la miniera passa alla Società Carbonifera Sarda che fà domanda di rinuncia nel marzo del 1957, dato che in realtà già dal 1935 la miniera risultava inattiva. Ad est della concessione di Caput Acquas era presente la concessione di Piolanas, nota già dalla fine dell’ottocento e rimasta attiva con alterne vicende fino al 1927. La concessione Piolanas passa poi alla Società Mineraria Carbonifera Sarda che vi rinuncia nel 1956. Tutti questi permessi di ricerca hanno presto una brusca contrazione vista la difficoltà di collocare sul mercato la produzione di carbone, anche perché molte ditte nahho già iniziato ad utilizzare la nafta per alimentare gli impianti di combustione.
Nel territorio di Caput Acquas si trovava la miniera di Caput Acquas che sfruttava due giacimenti carboniferi, quello di Caput Acquas e quello di Piolanas. I banchi carboniosi coltivati nell’area di Caput Acquas e Piolanas appartenevano a due bacini distinti separati da una dorsale paleozoica. La miniera di Caput Acquas viene concessa nel 1878 a Leon Gouin, poi ceduta a Filippo Birocchi e quindi nel 1896 ad Anselmo Roux. Nella concessione erano attivi gli impianti estrattivi di pozzo Caput Acquas, pozzo Tolmetta, pozzo Zara, pozzo Is Piras, pozzo D. Il massimo della produzione viene raggiunto nel 1938 con 516 operai. Nel settembre del 1913 la miniera di Caput Acquas passa alla Società Carbonifera di Bacu Abis. All’esterno funzionava a pieno regime la ferrovia a trazione a vapore lunga sei chilometri che collegava Caput Acquas con la stazione lungo la ferrovia che collegava Monteponi con Portovesme. Nel 1929 la miniera viene concessa in perpetuo alla Società Anonima di Bacu Abis. Nel 1934 la miniera passa alla Società Carbonifera Sarda che fà domanda di rinuncia nel marzo del 1957, dato che in realtà già dal 1935 la miniera risultava inattiva. Ad est della concessione di Caput Acquas era presente la concessione di Piolanas, nota già dalla fine dell’ottocento e rimasta attiva con alterne vicende fino al 1927. La concessione Piolanas passa poi alla Società Mineraria Carbonifera Sarda che vi rinuncia nel 1956. Tutti questi permessi di ricerca hanno presto una brusca contrazione vista la difficoltà di collocare sul mercato la produzione di carbone, anche perché molte ditte nahho già iniziato ad utilizzare la nafta per alimentare gli impianti di combustione.
La Stazione ferroviaria dismessa di Barbusi Caput Acquas
 All’interno dell’abitato della frazione, era un tempo presente la Stazione ferroviaria di Barbusi Caput Acquas, una fermata ormi dismessa a servizio della frazione carboniense di Barbusi e di altre località limitrofe. L’impianto, nato come stazione, è stato progettato negli anni quaranta nell’ambito della nuova linea ferroviaria che le Ferrovie dello Stato avevano previsto per il collegamento diretto di Carbonia con la rete a scartamento ordinario realizzata in Sardegna. Nel dopoguerra, seppur rimaneggiata rispetto al progetto originale, la linea che collegava Villamassargia con Carbonia è stata ultimata e con essa la stazione, che è stata quindi inaugurata nel novembre 1956. Barbusi era gi servita all’epoca da un’altra stazione delle Ferrovie Meridionali Sarde situata lungo la linea a scartamento ridotto che collegava San Giovanni Suergiu con Iglesias. E quindi Barbusi con le limitrofe località di Caput Acquas, dove la stazione è stata costruita, Acquas Callentis, Piolanas e Terra Segada, sono state quindi collegate in maniera pi agevole con Carbonia e col cagliaritano. Ci nonostante sette anni dopo l’inaugurazione, nel 1963 il Ministero dei trasporti dispose la trasformazione della stazione in impianto impresenziato, provvedimento che fu attuato il 15 gennaio del 1964. Anche il servizio merci, in seguito a questo ridimensionamento, è andato progressivamente verso la cessazione. Successivamente si è iniziato a ridurre l’utilizzo della fermata anche per il servizio passeggeri, e nel 2009 si è arrivati ad avere una sola coppia di corse aventi in orario la sosta a Barbusi, sino a poco dopo, quando la stazione è stata del tutto disabilitata al traffico passeggeri. L’impianto da allora è rimasto formalmente attivo come località di servizio per altri due anni fino al 2011, data della sua chiusura definitiva.
All’interno dell’abitato della frazione, era un tempo presente la Stazione ferroviaria di Barbusi Caput Acquas, una fermata ormi dismessa a servizio della frazione carboniense di Barbusi e di altre località limitrofe. L’impianto, nato come stazione, è stato progettato negli anni quaranta nell’ambito della nuova linea ferroviaria che le Ferrovie dello Stato avevano previsto per il collegamento diretto di Carbonia con la rete a scartamento ordinario realizzata in Sardegna. Nel dopoguerra, seppur rimaneggiata rispetto al progetto originale, la linea che collegava Villamassargia con Carbonia è stata ultimata e con essa la stazione, che è stata quindi inaugurata nel novembre 1956. Barbusi era gi servita all’epoca da un’altra stazione delle Ferrovie Meridionali Sarde situata lungo la linea a scartamento ridotto che collegava San Giovanni Suergiu con Iglesias. E quindi Barbusi con le limitrofe località di Caput Acquas, dove la stazione è stata costruita, Acquas Callentis, Piolanas e Terra Segada, sono state quindi collegate in maniera pi agevole con Carbonia e col cagliaritano. Ci nonostante sette anni dopo l’inaugurazione, nel 1963 il Ministero dei trasporti dispose la trasformazione della stazione in impianto impresenziato, provvedimento che fu attuato il 15 gennaio del 1964. Anche il servizio merci, in seguito a questo ridimensionamento, è andato progressivamente verso la cessazione. Successivamente si è iniziato a ridurre l’utilizzo della fermata anche per il servizio passeggeri, e nel 2009 si è arrivati ad avere una sola coppia di corse aventi in orario la sosta a Barbusi, sino a poco dopo, quando la stazione è stata del tutto disabilitata al traffico passeggeri. L’impianto da allora è rimasto formalmente attivo come località di servizio per altri due anni fino al 2011, data della sua chiusura definitiva.
La frazione Acqua Callentis nota anche come Is Perdas
Passata la frazione Caput Acquas, proseguiamo lungo la strada che ci ha portati ad essa, e, percorsi circa ottocento metri, arriviamo nella frazione Acqua Callentis (altezza metri 76, distanza in linea d’aria circa 7.8 chilometri, abitanti circa 140), nome che significa Acque Calde, e che deriva da una vicina sorgente di acque ipotermali che si trova nella riva destra del rio Flumentepido. Questa borgata, che un tempo apparteneva al Comune di Iglesias, viene denominata anche come Is Perdas o spesso anche con il nome Medau de Is Perdas ossia il Casale della famiglia Perdas, perché probabilmente in passato era abitato prevalentemente da una numerosa famiglia Perdas. Il nome di Aquas Callentis, ossia Acque Calde, deriva da una vicina sorgente di acque ipotermali che si trova nella riva destra del rio Flumentepido. Un tempo era un antico casale situato lungo la riva destra del rio Flumentepido, ed è divenuta ora una borgata agro pastorale.
La chiesa di Santa Maria Ausiliatrice
 Lungo la strada che da Caput Acquas ci porta ad Acqua Callentis, circa duecento metri prima di arrivare all’interno dell’abitato, alla destra della strada si incontra la moderna Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, che viene chiamata anche Chiesa di Nostra Signora dell’Ausilio. Qui, in località Is Perdas, da secoli era presente una piccola chiesa campestre, che è stata completamente ricostruita in tempi recenti. Si tratta di una bella chiesa cattolica campestre, situata in un luogo pieno di fascino ancestrale, vicino agli antichi insediamenti minerari. Un panorama forte, ideale per il trekking, da visitare in primavera per godere dei colori della natura. Sedersi all’ombra e meditare, oppure mentre si gusta un frugale pranzo al sacco.
Lungo la strada che da Caput Acquas ci porta ad Acqua Callentis, circa duecento metri prima di arrivare all’interno dell’abitato, alla destra della strada si incontra la moderna Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, che viene chiamata anche Chiesa di Nostra Signora dell’Ausilio. Qui, in località Is Perdas, da secoli era presente una piccola chiesa campestre, che è stata completamente ricostruita in tempi recenti. Si tratta di una bella chiesa cattolica campestre, situata in un luogo pieno di fascino ancestrale, vicino agli antichi insediamenti minerari. Un panorama forte, ideale per il trekking, da visitare in primavera per godere dei colori della natura. Sedersi all’ombra e meditare, oppure mentre si gusta un frugale pranzo al sacco.
La frazione Genna Corriga
Dalla chiesa parrocchiale di Barbusi proseguiamo lungo la via Santa Maria delle Grazie, dopo ottocentocinquanta metri questa strada si immette su una trasversale, che, presa verso sinistra, passa sotto la SP2. Presa la trasversale che passa sotto la SP2 percorriamo un centinaio di metri, poi svoltiamo a destra e proseguiamo. Presa la trasversale che passa sotto la SP2, dopo un centinaio di metri svoltiamo a destra e, percorsa appena una sessantina di metri, svoltiamo a sinistra. Percorsa una cinquantina di metri, svoltiamo leggermente a destra, dopo quattrocentocinquanta metri svoltiamo a sinistra e prendiamo la via Provinciale, che scorre parallela alla SP2.
Visita della frazione Genna Corriga
Percorsi appena cinquecento metri lungo la via Provinciale, si prende una deviazione a sinistra della strada provinciale seguendo le indicazioni per Genna Corriga e, dopo altri seiecento metri, raggiungiamo la frazione Genna Corriga (altezza metri 119, distanza in linea d’aria circa 9.5 chilometri, abitanti circa 82), ossia la Porta di Corriga, che era un antico casale agropastorale divenuto oggi una borgata. La si può raggiungere anche, da dove si è presa la via Provinciale, dopo cinquecento metri evitando la deviazione e proseguendo invece dritti lungo la via Provinciale, percorso poco più di un chilometro, presa a sinistra la via Perda Majore, arriviamo al centro della frazione. Genna Corriga è una delle frazione di probabili origini antiche, il cui nome deriva dall’antica denominazione di Genna de Cotricla, ossia la Porta del Pergolato, e si trova in corrispondenza del passo conosciuto come Su Strintu ’e S’Axina, ossia lo Stretto o il Passo dell’Uva.
La sorgente ed il lavatoio di Caput d’Acquas
Nel territorio di Genna Corriga, lungo la riva sinistra del Flumentepido, è presente la sorgente di acque potabili molto rinomate fino dall’antichità chiamata sorgente di Caput d’Acquas. Vicino alla sorgente si trova il lavatoio, costruito nel 1940, dal quale parte l’acquedotto Comunale. Il lavatoio della seconda guerra mondiale è stato recentemente restaurato. Per raggiungerli, dalla via Provinciale prendiamo la via Perda Majore, dopo una cinquantina di metri svoltiamo a sinistra per rimanere sulla via Perda Majore, e dopo un centinaio di metri svoltiamo a destra e, dopo centiventi metri, prendiamo a sinistra la strada che seguiamo per seicento metri. Arriviamo a un bivio dove prendiamo a sinistra e, dopo una settantina di metri, vediamo alla sinistra della strada la sorgente, ed alla destra della strada il lavatoio.
La frazione Medau Piredda
Dalla chiesa parrocchiale di Barbusi proseguiamo lungo la via Santa Maria delle Grazie, dopo ottocentocinquanta metri svoltiamo a destra e prendiamo lo svincolo che ci immettere sulla SP2 in direzione di Villamassargia. Percorsi due chilometri e seicento metri, prendiamo l’uscita verso Is Pireddas e Genna Corriga che, in un centinaio di metri, ci porta all’interno della frazione Medau Piredda (altezza metri 144, distanza in linea d’aria circa 8.7 chilometri, abitanti circa 68), ossia il Casale della famiglia Piredda, che era anch’esso un casale agropastorale noto anche con il nome Is Pireddas.
Il monte Tasua
 A sud dell’abitato della frazione Medau Piredda si sviluppa il monte Tasua, un rilievo alto 455 metri che è in assoluto il sistema carsico più esteso fino ad oggi esplorato nel territorio comunale, con uno sviluppo spaziale di poco superiore al chilometro. Anche sul monte Tasua si trova una pianta rara, il Bosso delle Baleari, ossia Buxus Balearica, che è una vegetazione arbustiva con foglie grandi e lunghe fino a quattro centimetri, bislunghe, di colore verde chiaro, e con fiori profumati. Si tratta di una specie spontanea, nativa delle Isole Baleari, della Spagna sudorientale e dell’Africa nordoccidentale, che in Italia si trova solo in Sardegna, in due località nel territorio comunale di Carbonia, nella frazione Medau Piredda su questa montagna, ed a Barbusi sulla piccola montagna denominata S’Arriu de Suttu. Fto del bosso delle Baleari sono state riportate quando abbiamo descritto la piccola montagna denominata S'Arriu de Suttu nella frazione Barbusi.
A sud dell’abitato della frazione Medau Piredda si sviluppa il monte Tasua, un rilievo alto 455 metri che è in assoluto il sistema carsico più esteso fino ad oggi esplorato nel territorio comunale, con uno sviluppo spaziale di poco superiore al chilometro. Anche sul monte Tasua si trova una pianta rara, il Bosso delle Baleari, ossia Buxus Balearica, che è una vegetazione arbustiva con foglie grandi e lunghe fino a quattro centimetri, bislunghe, di colore verde chiaro, e con fiori profumati. Si tratta di una specie spontanea, nativa delle Isole Baleari, della Spagna sudorientale e dell’Africa nordoccidentale, che in Italia si trova solo in Sardegna, in due località nel territorio comunale di Carbonia, nella frazione Medau Piredda su questa montagna, ed a Barbusi sulla piccola montagna denominata S’Arriu de Suttu. Fto del bosso delle Baleari sono state riportate quando abbiamo descritto la piccola montagna denominata S'Arriu de Suttu nella frazione Barbusi.
Sul versante meridionale del monte Tasua si trova la cavità nota come Sa Domu’ e S’Orcu
 Nel versante meridionale del monte Tasua si trovano le quattro grotte di monte Tasua e, a circa un chilometro di distanza in direzione sud est, la cavità più significativa nota come Sa Domu’ e S’Orcu, la casa dell’orco o anche come Su fossu de s'Orcu, il fosso dell’orco. Si presenta come una grande cavità quasi verticale impostata su una grossa frattura, ampliata da fenomeni graviclastici, cioè da quei materiali derivanti dai crolli che avvengono all’interno della grotta per assestamento delle volte o fusione di ambienti attigui. La frattura si ferma in corrispondenza di un livello di falda dando vita ad un fangosissimo laghetto pressoché perenne, che si sviluppa su una superficie di una quarantina di metri quadri.
Nel versante meridionale del monte Tasua si trovano le quattro grotte di monte Tasua e, a circa un chilometro di distanza in direzione sud est, la cavità più significativa nota come Sa Domu’ e S’Orcu, la casa dell’orco o anche come Su fossu de s'Orcu, il fosso dell’orco. Si presenta come una grande cavità quasi verticale impostata su una grossa frattura, ampliata da fenomeni graviclastici, cioè da quei materiali derivanti dai crolli che avvengono all’interno della grotta per assestamento delle volte o fusione di ambienti attigui. La frattura si ferma in corrispondenza di un livello di falda dando vita ad un fangosissimo laghetto pressoché perenne, che si sviluppa su una superficie di una quarantina di metri quadri.
La miniera di Monte Tasua
Il Monte Tasua, che sovrasta la frazione Is Pireddas, ospita nella sua falda settentrionale la miniera di Monte Tasua, nella quale l’estrazione mineraria prevalente sono state soprattutto la barite, ed anche la galena. Restano sia le gallerie che la laveria, e quest'ultima presenta, eccezionalmente conservato, l’impianto di trattamento costruito dalla Bariosarda Spa. La miniera di Monte Tasua era già citata dalla nota relazione di Quintino Sella alla fine dell’Ottocento. Il 4 marzo del 1900 viene rilasciata a Gustavo Cappa, responsabile della Società Vieille Montagne, la concessione relativa alla miniera di Monte Tasua, e fino al 1940 questa società coltiva i giacimenti di barite e galena ospitati entro i calcari cambrici. Negli anni sessanta la concessione chiamata Monte Mesu, che include anche questa miniera, passa alla Società Monte Tasua, poi, negli anni novanta, la ditta Fratelli Locci Estrazioni minerarie acquisisce la concessione, che scadrà poi nel 1997.
La laveria per il trattamento della barite è ubicata alle falde del Monte Tasua, ed in questa laveria, la barite subiva la macinazione in un mulino a martelli e a sfere, la classificazione con un classificatore a rastrelli, e la flottazione in celle di flottazione Humboldt. Ora la miniera di Monte Tasua risulta in parte abbandonata, e la laveria che conserva ancora gli impianti è utilizzata ora come ricovero per le capre, triste sorte comune a tante strutture minerarie abbandonate in Sardegna.
La frazione Piolanas
Dalla frazione Medau Piredda riprendiamo lo svincolo della SP2 in direzione di Villamassargia, imbocchiamo la strada provinciale e le seguiamo per un paio di chilometri fino alla prossima uscita che è quella per Tanì e per la Miniera Barega. Qui seguiamo lo svincolo ed imbcchiamo al SP2 in direzione inversa, ossia per Barbusi e Sirai, la seguiamo per un chilometro e mezzo, e prendiamo l’uscita verso la località Piolanas. Presa questa deviazione, procediamo in direzione ovest per novecento metri, poi svoltiamo leggermente a sinistra e, dopo un chilometro, troviamo una strada sterrata sulla destra che ci fa raggiungere, in circa duecento metri, le poche case dell’abitato della frazione Piolanas (altezza indefinita, distanza in linea d’aria circa 14.7 chilometri, non è disponibile il numero di abitanti), che era un casale agropastorale.
La morte della maestrina di Piolanas
Piolanas, piccolissima località nel cuore del Sulcis, custodisce il mistero di una delle storie più tragiche del Sulcis. Un mistero che risale al 5 novembre 1957 quando una maestra di 25 anni, Oretta Scalisi, venne uccisa lungo la strada che percorreva in bicicletta per raggiungere la stazione di Barbusi. Tutti gli uomini della piccola borgata furono portati in caserma ma poi le indagini si concentrarono su un contadino, Angelo Mancadato che i bulloni trovati vicino al corpo di Oretta avevano portato a lui che con dei bulloni simili le aveva riparato la bicicletta. Inutile ogni tentativo di difesa, compreso un alibi che lo vedeva a Cussorgia all’ora del delitto. Fu arrestato ma nessuno sospirò di sollievo perché erano tanti i dubbi, che divennero più grandi quando, il 12 novembre Angelo Manca morì suicida in carcere gridando la sua innocenza.
Quel crimine è tutt’ora velato dal mistero, perché dopo quel suicidio tante voci si rincorsero e rimase sempre il dubbio che la morte della maestra Oretta, fosse rimasta senza un vero colpevole. Ed ancora oggi il mistero resta aperto.
La chiesa campestre di Santa Barbara Vergine e Martire
 Arrivati alla poche case dell’abitato, nella parte di Piolanas denominata Medau Manca, ossia Casale della famiglia Manca, si trova uno sterrato che porta alla piccola Chiesa di Santa Barbara Vergine e Martire che risale probabilmente al periodo giudicale. Ma questa chiesa campestre è stata però fortemente modificata dai continui restauri ai quali è stata sottoposta nel tempo. Era una delle tappe della strada denominata De Sa Reliquia, che era il percorso della processione di Sant’Antioco che da Iglesias arrivava all’antica città di Sulci, raggiungendo durante il suo viaggio le Chiese di Santa Maria di Barega, Santa Barbara di Piolanas e Santa Maria delle Grazie di Barbusi.
Arrivati alla poche case dell’abitato, nella parte di Piolanas denominata Medau Manca, ossia Casale della famiglia Manca, si trova uno sterrato che porta alla piccola Chiesa di Santa Barbara Vergine e Martire che risale probabilmente al periodo giudicale. Ma questa chiesa campestre è stata però fortemente modificata dai continui restauri ai quali è stata sottoposta nel tempo. Era una delle tappe della strada denominata De Sa Reliquia, che era il percorso della processione di Sant’Antioco che da Iglesias arrivava all’antica città di Sulci, raggiungendo durante il suo viaggio le Chiese di Santa Maria di Barega, Santa Barbara di Piolanas e Santa Maria delle Grazie di Barbusi.
I resti della caserma della 164ª Compagnia Artieri del Genio oggi adibiti ad ovile
 A pochi passi dalla chiesa medievale di Santa Barbara Vergine e Martire di Piolanas si estende un edificio di quasi quattrocento metri quadrati, oggi adibito ad ovile, che negli anni della guerra è stata la caserma della 164ª Compagnia Artieri del Genio, in organico alla 205ª Divisione Costiera dell’Esercito Italiano. I militari di istanza a Piolanas all’inizio della seconda guerra mondiale hanno realizzato un campo minato tra Piolanas e Barega, campo che sarebbe servito qualora gli Alleati fossero sbarcati nell’Iglesiente per poi dirigersi verso Cagliari. Come ben sappiamo lo sbarco non avvenne in Sardegna e il campo minato fu prontamente smantellato alla fine della guerra. Fino a qualche anno fa, nel retro dell’edificio, era presente una targa in marmo che attestava la presenza della 164ª Compagnia, che però in seguito è stato rimosso.
A pochi passi dalla chiesa medievale di Santa Barbara Vergine e Martire di Piolanas si estende un edificio di quasi quattrocento metri quadrati, oggi adibito ad ovile, che negli anni della guerra è stata la caserma della 164ª Compagnia Artieri del Genio, in organico alla 205ª Divisione Costiera dell’Esercito Italiano. I militari di istanza a Piolanas all’inizio della seconda guerra mondiale hanno realizzato un campo minato tra Piolanas e Barega, campo che sarebbe servito qualora gli Alleati fossero sbarcati nell’Iglesiente per poi dirigersi verso Cagliari. Come ben sappiamo lo sbarco non avvenne in Sardegna e il campo minato fu prontamente smantellato alla fine della guerra. Fino a qualche anno fa, nel retro dell’edificio, era presente una targa in marmo che attestava la presenza della 164ª Compagnia, che però in seguito è stato rimosso.
I resti della miniera di Piolanas
 A sud ovest di questa frazione si trovano i resti della miniera di Piolanas nella quale avveniva l’estrazione di carbone e lignite, ormai abbandonata. La miniera di Piolanas era presente con il giacimento di Piolanas, che utilizzava gli impianti estrattivi del pozzo Piolanas, e più ad ovest il giacimento di Caput Acquas. La concessione di Piolanas, nota già dalla fine dell’Ottocento e rimasta attiva con alterne vicende fino al 1927. La concessione è passata poi alla Società Mineraria Carbonifera Sarda che vi ha rinunciato nel 1956. Nella miniera di Piolanas Nord la coltivazione del carbone era realizzata prevalentemente a cielo aperto, il che ha dato origine a due ampie cave principali, con fronti sub verticali alti una ventina di metri. I due scavi, con ampiezza massima di una settantina di metri, sono separati da un grande cumulo di materiali di discarica. Altri cumuli di sterili e materiale terrigeno indistinto, parzialmente rivegetati, sono disposti ai bordi dell’area mineraria, sino a giungere a ridosso della stradina che conduce alla Cooperativa Agricola Su Nenneri. L’estrazione veniva concentrata pressoché esclusivamente in corrispondenza degli affioramenti, lungo livelli carboniosi a stratificazione sub orizzontale, ancora ben osservabili. Nelle zone più depresse degli scavi si osservano i segni di venute d’acqua periodiche e ristagni idrici.
A sud ovest di questa frazione si trovano i resti della miniera di Piolanas nella quale avveniva l’estrazione di carbone e lignite, ormai abbandonata. La miniera di Piolanas era presente con il giacimento di Piolanas, che utilizzava gli impianti estrattivi del pozzo Piolanas, e più ad ovest il giacimento di Caput Acquas. La concessione di Piolanas, nota già dalla fine dell’Ottocento e rimasta attiva con alterne vicende fino al 1927. La concessione è passata poi alla Società Mineraria Carbonifera Sarda che vi ha rinunciato nel 1956. Nella miniera di Piolanas Nord la coltivazione del carbone era realizzata prevalentemente a cielo aperto, il che ha dato origine a due ampie cave principali, con fronti sub verticali alti una ventina di metri. I due scavi, con ampiezza massima di una settantina di metri, sono separati da un grande cumulo di materiali di discarica. Altri cumuli di sterili e materiale terrigeno indistinto, parzialmente rivegetati, sono disposti ai bordi dell’area mineraria, sino a giungere a ridosso della stradina che conduce alla Cooperativa Agricola Su Nenneri. L’estrazione veniva concentrata pressoché esclusivamente in corrispondenza degli affioramenti, lungo livelli carboniosi a stratificazione sub orizzontale, ancora ben osservabili. Nelle zone più depresse degli scavi si osservano i segni di venute d’acqua periodiche e ristagni idrici.
Sono qui riportati i ruderi di un edificio fortemente mal ridotti, che ne consentono una lettura solo parziale, dalla quale si può ipotizzare come fosse caratterizzato da una pianta rettangolare allungata verosimilmente priva di divisioni interne e coperto da una unica falda inclinata. Si deduce pertanto che lo stesso fosse adibito a locale deposito per mezzi o attrezzature legati alla discenderia, escludendo la funzione abitativa in relazione alla vicinanza con l’abitato di Piolanas. Sono riportati anche i resti della galleria drenante, realizzata in fase di attività della miniera per impedire l’allagamento degli scavi a cielo aperto situati a quota più elevata. La galleria aveva lo scopo di deprimere la superficie della falda idrica e permettere una lavorazione all’asciutto. Successivamente l’acqua venne immessa in condotta per essere utilizzata presso la miniera di Barega, distante circa due chilometri e mezzo. Allo stato attuale la galleria risulta completamente allagata e dunque inesplorabile, tuttavia si presume uno sviluppo orizzontale o debolmente inclinato verso il basso. All’imboccatura è posizionata una elettropompa idraulica e una passerella metallica di servizio che si addentra per il primo tratto.
Il piccolo insediamento di Tanì e la frazione Corongiu
A destra della SP20 si trovano le due frazioni Tanì e Corongiu, che sono entrambe divise tra il due comuni di Carbonia e Iglesias
Il piccolo insediamento di Tanì
Dalla frazione Medau Piredda riprendiamo lo svincolo della SP2 in direzione di Villamassargia, imbocchiamo la strada provinciale e le seguiamo per un paio di chilometri fino alla prossima uscita che è quella per Tanì e per la Miniera Barega. Presa questa uscita svoltia, seguendo le indicazioni, nella via Sa Cresiedda che, in circa un chilometro e quattrocento metri, porta a Tanì, un piccolo insediamento agropastorale diviso fra i due Comuni di Carbonia e di Iglesias, di una cinquantina di abitanti, che è costituita da due medaus, ossia casali. A nord si trova Tanì di Sopra, che appartiene al Comune di Iglesias, ed a sud Tanì di Sotto, del Comune di Carbonia, Sono vicini all’antica borgata di Corongiu e che si trovano vicini alla SP2, denominata Pedemontana. Nonostante le dimensioni ridotte, il borgo è un tassello della storia isolana, testimone di un passato agricolo e pastorale ancora vivo nelle attività quotidiane dei suoi residenti.
La frazione Corongiu
Dalla frazione Medau Piredda riprendiamo lo svincolo della SP2 in direzione di Villamassargia, imbocchiamo la strada provinciale e le seguiamo per due chilometri e settecento metri e prendiamo, seguendo le indicazioni per Corongiu, l’uscita che ci fa perndere la via Iglesias la quale, in circa seicento metri, conduce al centro della frazione Corongiu (altezza metri 180, distanza in linea d’aria circa 12.0 chilometri, abitanti circa 17), già casale di origini antiche, ora borgata, il cui nome significa Circolo o Corona di pietre o nuraghe, che fu forse una mansio, ossia una stazione di posta romana. Come Tanì che abbiamo già visto, e come Barega che visiteremo più avanti, anche Corongiu si trova in parte all’interno del territorio comunale di Carbonia, ed in parte in quello del comune di Iglesias.
La chiesa parrocchiale di Sant’Anna
 Al centro dell’abitato si trova il piazzale della chiesa, nel quale è presente la Chiesa di Sant’Anna, un edificio sacro di recente costruzione che rappresenta il punto di riferimento spirituale per la comunità locale. Prima della sua edificazione, a seguito di una consultazione tra gli abitanti, è stato scelto di dedicare la futura chiesa a Sant’Anna, la cui statua veniva custodita a turno dalle famiglie del paese, e nelle loro case veniva celebrata la messa. Alla fine degli anni sessanta una signora ha donato un terreno per la costruzione della chiesa. Tra il 1967 e il 1968 è stata costruita una chiesetta consistente in un unico locale adibito ad aula. Oggi la chiesa di Sant’Anna prospetta su un ampio spazio antistante, rispetto al quale è sopraelevata grazie alla presenza di un podio. L’ingresso, posizionato a sinistra, è ricavato in posizione perpendicolare rispetto all’asse longitudinale dell’aula, pertanto la facciata è caratterizzata da un ampio sviluppo in senso orizzontale, corrispondente al lato destro della navata. Oltre alla terminazione, che grazie alla disposizione delle falde di copertura simula un frontone triangolare, si segnala la presenza di una zona porticata della medesima larghezza della facciata. Sul versante sinistro della chiesa si attestano la zona adibita a sagrestia e il campanile, suddiviso in tre zone sovrapposte, di cui le prime due in muratura piena, mentre l’ultima, nella quale è posta la campana, è aperta sul lato frontale e posteriore. Internamente l’edificio si compone di un unico vano, con copertura orizzontale, illuminato grazie all’inserimento di finestre, due delle quali ubicate sulla parete di fondo.
Al centro dell’abitato si trova il piazzale della chiesa, nel quale è presente la Chiesa di Sant’Anna, un edificio sacro di recente costruzione che rappresenta il punto di riferimento spirituale per la comunità locale. Prima della sua edificazione, a seguito di una consultazione tra gli abitanti, è stato scelto di dedicare la futura chiesa a Sant’Anna, la cui statua veniva custodita a turno dalle famiglie del paese, e nelle loro case veniva celebrata la messa. Alla fine degli anni sessanta una signora ha donato un terreno per la costruzione della chiesa. Tra il 1967 e il 1968 è stata costruita una chiesetta consistente in un unico locale adibito ad aula. Oggi la chiesa di Sant’Anna prospetta su un ampio spazio antistante, rispetto al quale è sopraelevata grazie alla presenza di un podio. L’ingresso, posizionato a sinistra, è ricavato in posizione perpendicolare rispetto all’asse longitudinale dell’aula, pertanto la facciata è caratterizzata da un ampio sviluppo in senso orizzontale, corrispondente al lato destro della navata. Oltre alla terminazione, che grazie alla disposizione delle falde di copertura simula un frontone triangolare, si segnala la presenza di una zona porticata della medesima larghezza della facciata. Sul versante sinistro della chiesa si attestano la zona adibita a sagrestia e il campanile, suddiviso in tre zone sovrapposte, di cui le prime due in muratura piena, mentre l’ultima, nella quale è posta la campana, è aperta sul lato frontale e posteriore. Internamente l’edificio si compone di un unico vano, con copertura orizzontale, illuminato grazie all’inserimento di finestre, due delle quali ubicate sulla parete di fondo.
Ogni , questa chiesa ed in tutto l’abitato della frazione Corongiu, il 26 luglio in occasione della sua ricorrenza, si celebra la Festa di Sant’Anna, con cerimonie religiose e diverse manifestazioni civili.
I siti archeologici tra la frazione Corongiu e l’insediamento di Tanì
 Appena usciti dallo svincolo della SP2 in direzione di Tanì, presa la via Sa Cresiedda, percorsi appena duecentosettanta metri, svoltiamo a sinistra nella strada che porta in direzione dell’abitato della frazione Corongiu. E dall’altra parte, dal centro dell’abitato di Corongiu, dove si trova la chiesa parrocchiale di Sant’Anna, proseguiamo con la prosecuzione della via Iglesias e, dopo circa quattrocento metri, si raggiunge la via Sa Cresidda, che porta dalla SP2 all’interno del piccolo insediamento di Tanì. Lungo questa strada sorgeva un insediamento romano da cui provengono elementi architettonici, come lastre di marmo e frammenti di mosaico, riferibili ad un importante complesso, una villla o un edificio di culto.
Appena usciti dallo svincolo della SP2 in direzione di Tanì, presa la via Sa Cresiedda, percorsi appena duecentosettanta metri, svoltiamo a sinistra nella strada che porta in direzione dell’abitato della frazione Corongiu. E dall’altra parte, dal centro dell’abitato di Corongiu, dove si trova la chiesa parrocchiale di Sant’Anna, proseguiamo con la prosecuzione della via Iglesias e, dopo circa quattrocento metri, si raggiunge la via Sa Cresidda, che porta dalla SP2 all’interno del piccolo insediamento di Tanì. Lungo questa strada sorgeva un insediamento romano da cui provengono elementi architettonici, come lastre di marmo e frammenti di mosaico, riferibili ad un importante complesso, una villla o un edificio di culto.  Tradizionalmente questa struttura è indicata, insieme ad un altro edificio del sito collocato più a nord, come Sa Cresiedda de Corongiu. Era un edificio costruito con blocchi squadrati di arenaria e travertino sopra un basamento di pietrame. Sul versante settentrionale del rilievo, si scorge un lacerto murario, in gran parte interrato, sulla cui sommità sono accumulati pietrame e blocchi di crollo e di spietramento del fondo. Tra questi è stato rinvenuto un blocco con incavo a coda di rondine ed altri conci isodomi, parallelepipedi o quasi cubici. Sulla superficie del terreno si individuano frammenti di embrici, laterizi, coppi e di contenitori fittili. Alcuni muretti costruiti soprattutto nel versante settentrionale sono, però, d’età contemporanea. La probabile datazione si riferisce tra il primo ed il quinto secolo dopo Cristo. Dallo stesso sito provengono un torso maschile, una testa marmorea e grandi frammenti della copertura a volta.
Tradizionalmente questa struttura è indicata, insieme ad un altro edificio del sito collocato più a nord, come Sa Cresiedda de Corongiu. Era un edificio costruito con blocchi squadrati di arenaria e travertino sopra un basamento di pietrame. Sul versante settentrionale del rilievo, si scorge un lacerto murario, in gran parte interrato, sulla cui sommità sono accumulati pietrame e blocchi di crollo e di spietramento del fondo. Tra questi è stato rinvenuto un blocco con incavo a coda di rondine ed altri conci isodomi, parallelepipedi o quasi cubici. Sulla superficie del terreno si individuano frammenti di embrici, laterizi, coppi e di contenitori fittili. Alcuni muretti costruiti soprattutto nel versante settentrionale sono, però, d’età contemporanea. La probabile datazione si riferisce tra il primo ed il quinto secolo dopo Cristo. Dallo stesso sito provengono un torso maschile, una testa marmorea e grandi frammenti della copertura a volta.
Le grotte in territorio di Tanì
In territorio di Tanì sono state individuata anche diverse grotte, tra le quali la più significativa è la grotta di Baieddus de Sa Sedderenciu, o anche grotta di Su Cungiaureddu de Serafini o più semplicemente Grotta di Tanì. In essa sono stato rinvenuti reperti che risalgono al neolitico medio ossia alla cultura Bonu Ighinu, poi reperti che risalgono al neolitico superiore ossia alla cultura San Ciriaco, ed anche all’eneolitico medio ossia alla cultura Monte Claro.
A pochi metri da essa è stata rinvenuta anche la cosiddetta grotta XIV delle Ossa, una grotta che i fenomeni carsici hanno scavato in un tacco di travertino affiorante, dentro la quale hanno trovato sepoltura decine di uomini. Dai dati emersi in seguito allo studio dei contesti censiti si può affermare che le genti di cultura Monte Claro abbiano utilizzato le cavità naturali prevalentemente a scopo funerario, essendo state rinvenute, nella maggior parte dei casi, ossa umane. Nella grotta di Tanì sono state rinvenute le ossa umane all’interno di grandi vasi entro un circolo di pietre, ed appare interessante l’azione di deporre le ossa su uno strato di carboni. Al momento non è stata individuata in grotta la deposizione primaria, singola o collettiva, osservata nelle caratteristiche tombe a forno e nelle ciste litiche di questa cultura. Di particolare interesse è la singolare pratica funebre della deposizione su strato di carbone, da mettere in relazione a riti legati all’uso del fuoco e testimonianza, forse, di un legame con le attività fusorie legate alla produzione di oggetti in metallo. Si attende la pubblicazione dei dati relativi agli interventi già effettuati all’interno delle grotte in esame e l’avvio di ricerche più approfondite.
La frazione Barega
Dall’uscita della SP2 che ci ha fatto perndere la via Iglesias e ci ha portati a Corongiu, proseguiamo lungo la SP2 per quattrocentocinquanta metri, e troviamo le indicazioni per l’uscita che porta a Corongiu e Barega. Presa l’uscita, arriviamo a un incrocio dove a destra ci si dirige per Corongiu, mentre a sinistra si trova la deviazione che passa sotto la SP2 e prosegue portandoci, in tre chilometri e duecento metri, all’interno della frazione Barega (altezza metri 159, distanza in linea d’aria circa 15.0 chilometri, abitanti circa 113), già antico casale ed oggi una piccola borgata che si trova all’interno di un vasto territorio agricolo bonificato e valorizzato dal vecchio ente regionale fondiario Etfas. Come Corongiu si trova in parte all’interno del territorio comunale di Carbonia, ed in parte in quello del comune di Iglesias.
La chiesa della Natività di Maria
All’interno dell’abitato si trova la piccola Chiesa della Natività di Maria di Barega. La chiesa è stata edificata negli anni sessanta del ventesimo secolo non lontano dai ruderi dell’antica chiesa di Santa Maria de Barega. La facciata della chiesa, sopraelevata mediante alcuni gradini, è coronata dall’andamento ascendente delle falde spioventi del tetto, poste in aggetto. È suddivisa verticalmente in tre porzioni grazie all’inserimento di pilastri. Al centro sono realizzate due finestre affiancate di forma rettangolare orientate secondo il lato lungo, mentre nella parte sottostante è inserito il portale d’ingresso, sormontato da una pensilina che a sua volta riprende l’andamento della copertura della chiesa. Internamente la chiesa si compone di un’unica navata con copertura lignea, la quale si conclude in un presbiterio di altezza inferiore rispetto al vano principale, con copertura orizzontale.
I ruderi dell’antica chiesa di Santa Maria de Barega
 Proseguendo lungo la strada che ci ha condotti a Barega, poco più di cinquecento metri più avanti si trovano, alla sinistra della strada, i pochi ruderi dell’antica chiesa di Santa Maria de Barega. Si trattava di una chiesa giudicale edificata in periodo medievale, appartenente all’insediamento medioevale di Barega nella Curatoria del Sigerro, Giudicato di Karalis e antica Diocesi di Sulcis. Questa chiesa era una delle tappe della strada denominata De Sa Reliquia, che era il percorso della processione di Sant’Antioco che da Iglesias arrivava all’antica Sulci, e che oggi raggiunge la nuova Chiese di Santa Maria di Barega, poi quelle di Santa Barbara di Piolanas e di Santa Maria delle Grazie di Barbusi.
Proseguendo lungo la strada che ci ha condotti a Barega, poco più di cinquecento metri più avanti si trovano, alla sinistra della strada, i pochi ruderi dell’antica chiesa di Santa Maria de Barega. Si trattava di una chiesa giudicale edificata in periodo medievale, appartenente all’insediamento medioevale di Barega nella Curatoria del Sigerro, Giudicato di Karalis e antica Diocesi di Sulcis. Questa chiesa era una delle tappe della strada denominata De Sa Reliquia, che era il percorso della processione di Sant’Antioco che da Iglesias arrivava all’antica Sulci, e che oggi raggiunge la nuova Chiese di Santa Maria di Barega, poi quelle di Santa Barbara di Piolanas e di Santa Maria delle Grazie di Barbusi.
I resti della miniera di Barega
 La frazione è nota soprattutto per la vecchia miniera di Barega, che era una miniera di barite, riconvertita a cava d’inerti, la quale si trova nel territorio comunale di Iglesias e solo in parte in quello di Carbonia. I corpi mineralizzati sono costituiti prevalentemente da barite, tanto che il giacimento di Monte Barega e di Monte Arcau risulta il più importante giacimento baritico di tutta la Sardegna. Il sito minerario è raggiungibile dalla SP2 ed è fortemente visibile dalla strada provinciale visto che il Monte Barega si staglia imperioso dalla pianura sottostante. La miniera è stata scoperta nel 1866 per la raccolta di galena ed altri minerali di piombo, e concessa all’imprenditore Rossi nel 1873. Nel 1879 passa, prima, alla Societè Anonyme des Zincs Francais, e poi alla Società Anonima delle Miniere di Malfidano. Nel 1902 la miniera passa alla Società Anonima delle Miniere di Gennamari Ingurtosu, ed in seguito alla Società Pertusola. Dal 1938 si abbandona la coltivazione della galena a favore di quella della barite, facendo la fortuna della Piombo Zincifera Sarda prima e della Società Bariosarda che negli anni settanta ha acquisito dalla Ferrara SPA la laveria Idrogravimetrica della miniera.
La frazione è nota soprattutto per la vecchia miniera di Barega, che era una miniera di barite, riconvertita a cava d’inerti, la quale si trova nel territorio comunale di Iglesias e solo in parte in quello di Carbonia. I corpi mineralizzati sono costituiti prevalentemente da barite, tanto che il giacimento di Monte Barega e di Monte Arcau risulta il più importante giacimento baritico di tutta la Sardegna. Il sito minerario è raggiungibile dalla SP2 ed è fortemente visibile dalla strada provinciale visto che il Monte Barega si staglia imperioso dalla pianura sottostante. La miniera è stata scoperta nel 1866 per la raccolta di galena ed altri minerali di piombo, e concessa all’imprenditore Rossi nel 1873. Nel 1879 passa, prima, alla Societè Anonyme des Zincs Francais, e poi alla Società Anonima delle Miniere di Malfidano. Nel 1902 la miniera passa alla Società Anonima delle Miniere di Gennamari Ingurtosu, ed in seguito alla Società Pertusola. Dal 1938 si abbandona la coltivazione della galena a favore di quella della barite, facendo la fortuna della Piombo Zincifera Sarda prima e della Società Bariosarda che negli anni settanta ha acquisito dalla Ferrara SPA la laveria Idrogravimetrica della miniera.
La miniera è poi appartenuta alla ditta Fratelli Locci di Iglesias che è stata dichiarata fallita nel 2018, ed oggi giace in uno stato di abbandono che evoca il ricordo di un passato industrioso. Il sito conserva strutture minerarie monumentali, incastonate in cavità carsiche di calcare cambriano, e colonne minerali che sfiorano i cento metri di altezza. Pur non essendo più attiva, la miniera di Barega rappresenta un testimone significativo dell’epoca d’oro dell’estrazione mineraria in Sardegna.
La prossima tappa del nostro viaggio
Nella prossima tappa del nostro viaggio, ci recheremo a visitare i dintorni della Città di Carbonia, con i rinvenimenti nel riparo sotto la roccia di Su Carroppu e con le diverse frazioni a sud dell’abitato ed i resti delle miniere nei loro territori.
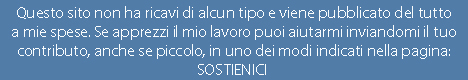
Tutte le foto e riprese sono state effettuate a scopo amatoriale per uso personale senza fini di lucro. Alle nostre foto se ne aggiungono altre inviateci da amici ed alcune tratte da Internet. Alcune informazioni sulle descrizioni dei comuni sono tratte da italiapedia.it, informazioni sui siti archeologici da tharros.info e molte foto da donnanuragica.com, descrizoni e foto di Chiese da Chiesedisardegna.weebly.com, foto di impianti sportivi da sardegnasport.it, altre da siti differenti. È consentito scaricare testi, foto e riprese dell’autore per uso privato senza eliminare i riferimenti. Libri e filmati sono riprodotti per farli conoscere ma non è consentita la riproduzione delle foto di terzi, dei libri, dei filmati e di altro materiale non realizzato dall’autore. È vietato qualsiasi utilizzo commerciale del materiale in assenza di apposita autorizzazione. |
© Claudio de Tisi 2002-2023 - Codice Fiscale DTSCLD44M23F132W